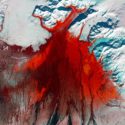Abbonatevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati sul lancio de “Il Grand Continent” in italiano
Green Deal vs ecologia: l’era dell’ambientalismo produttivista
Durante il vertice sul clima del 22 e 23 aprile, che doveva segnare il ritorno degli Stati Uniti alla diplomazia climatica, i vari leader che hanno preso la parola hanno potuto testare i propri migliori leit motiv. Joe Biden ha descritto la sfida climatica come un’opportunità per riportare gli Stati Uniti a una posizione competitiva basata sull'”energia pulita” (con ciò intendendo basse emissioni di carbonio), e il suo inviato John Kerry ha aggiunto “a nessuno viene chiesto un sacrificio, si tratta di un’opportunità”1. I decenni passati a squalificare l’ambientalismo come un peso per lavoratori e imprenditori hanno dato i loro frutti: per aprire la strada a un futuro sotto i 2°C di riscaldamento globale, è la retorica della fattibilità tecnica e della convenienza economica ad avere la meglio. Jennifer Granholm, la segretaria per l’energia dell’Amministrazione democratica, ha riciclato una delle più famose metafore della guerra fredda annunciando che i mercati aperti e il green tech erano il “l’allunaggio” della nostra generazione2. L’eco storica è evidente: già negli anni ’40, la diplomazia economica americana dichiarava in modo grandioso che la cooperazione tecnica e scientifica avrebbe potuto salvare il mondo dalla fame e dalla guerra, che la “frontiera infinita” del Progetto Manhattan e del programma spaziale3 teorizzata da ingegneri come Vannevar Bush apriva possibilità tecniche talmente grandi che miseria e paura sarebbero state presto un lontano ricordo. L’amministrazione Biden riconosce esplicitamente questi riferimenti storici chiamando la sua legge sul finanziamento della ricerca “Endless Frontier Act”.
Allo stesso vertice, il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol, ha parzialmente smorzato l’entusiasmo: “Sarò schietto. Gli impegni da soli non sono sufficienti. Abbiamo bisogno di un vero cambiamento nel mondo reale. In questo momento, i dati non corrispondono alla retorica, e il divario sta diventando sempre più ampio”4. Ma questo non cambia il paradigma politico che è in atto da diversi mesi. La ripresa resa necessaria dalla crisi del Covid-19 (o almeno dopo la crisi del Covid-19 nel Nord) sta accelerando l’integrazione dell’imperativo climatico nella regolamentazione dell’economia globale. L’ingresso nelle politiche dell’Antropocene, è ormai chiaro, non si svolge affatto sul terreno della riconciliazione con la natura e il vivente o della promozione di valori post-materialisti. Prende piuttosto la forma di una reinvenzione della produttività, di un nuovo patto tra lavoro e mercati e di una cooperazione tecnica che dovrebbe garantire la sicurezza globale.
L’importanza di questa riformulazione dell’imperativo ecologico e climatico non puó essere sottovalutata. La cultura politica nata negli ambienti ambientalisti degli anni ’60 e ’70, riprendendo alcuni temi della critica all’industria già diffusi nel XIX secolo, ha messo in evidenza le patologie del sovrasfruttamento e del sovraconsumo, dell’alienazione tra l’uomo e il suo ambiente, e della corsa al potere nella ricerca della crescita. Mezzo secolo dopo, i risultati di questo ambientalismo sono ambivalenti. Da un lato, ha fornito i principali attori della lotta per imporre nel dibattito la questione dei rischi e dei limiti ecologici dello sviluppo moderno. Rachel Carson, Vandana Shiva, Chico Mendes e molti altri hanno raccolto dati sulle minacce ambientali mentre forgiavano i temi politici centrali del movimento verde. Ma d’altra parte, l’ambientalismo è rimasto indifferente al problema fondamentale che poneva, cioè la tensione tra l’aspirazione all’emancipazione e la sua iscrizione entro limiti ecologici, o per dirla in altro modo, tra sicurezza sociale e sicurezza ambientale. Mai una coalizione sociale basata sulla risposta a questo dilemma è stata in una posizione forte nel gioco della politica parlamentare o rivoluzionaria.
Questo è certamente il motivo per cui questa cultura politica viene attualmente messa da parte, o almeno spinta ai margini del dibattito politico. Gli ecologisti sul terreno stanno ovviamente facendo un lavoro essenziale a livello locale e regionale su questioni mirate come l’uso delle foreste, la biodiversità e la conservazione della fauna selvatica, l’agroecologia. Ma è assolutamente sorprendente notare che il tema centrale dei movimenti verdi del Nord e del Sud, cioè la critica del produttivismo e dei suoi abusi, viene completamente rovesciato dalle attuali politiche climatiche. Poiché la critica del produttivismo è sembrata alla stragrande maggioranza (e in particolare alle classi lavoratrici intrappolate nel paradigma industriale) un ostacolo alla realizzazione delle loro aspirazioni, questa critica è stata disattivata, per così dire, per far posto a un ambientalismo opportunista e, in definitiva, produttivista. La conservazione di un oïkos abitabile e l’interiorizzazione dei limiti planetari da parte degli attori più potenti della comunità internazionale prende la forma di una reinvenzione della produttività. I combustibili fossili sono designati come il nemico da distruggere, e gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono formulati in modo prudente grazie al dispositivo contabile dello “zero netto”, che lascia aperta la possibilità di compensare le emissioni in eccesso. L’orizzonte si apre allora per quello che Biden, Kerry, Granholm, ma anche i leader cinesi dei negoziati sul clima descrivono: l’apertura di giganteschi mercati della transizione e l’attuazione di meccanismi di sostegno politico destinati a non compromettere l’accettabilità sociale di questo riorientamento industriale. I Gilets Jaunes francesi sono nella mente di tutti i governi, ansiosi di realizzare la transizione senza perdere la loro legittimità, o addirittura consolidandola.
La fine dell’incanto: l’ambiente come terreno di scontro geopolitico
Le scienze sociali hanno spesso descritto come gli attori più potenti riescono ad appropriarsi delle critiche mosse nei loro confronti ridefinendo i termini e le implicazioni di quelle critiche. In questo caso, un tale sviluppo è evidente: mentre la messa in discussione del modello produttivista condizionava l’apertura di un futuro verde alla costruzione di legami di interdipendenza umana emancipati dall’imperativo capitalista del profitto e dell’accumulazione, le politiche climatiche del XXI secolo utilizzano la ricerca del profitto come leva di riorientamento. E dietro il profitto, naturalmente, c’è il mantenimento delle strutture di potere legate alla capacità di fornire lavoro, formazione, protezione e difesa della sovranità. Le attuali politiche climatiche riecheggiano la famosa frase del Gattopardo di Lampedusa: “Tutto deve cambiare affinché nulla cambi” 5.
Gli elementi di continuità storica tra il mondo dei combustibili fossili e l’era post-carbonio sono quindi importanti, più importanti di quanto gli eroi e le eroine della causa ambientale avrebbero probabilmente desiderato. Ma l’elemento di discontinuità non è meno massiccio e impossibile da ignorare: l’immobilismo geopolitico che ha caratterizzato gli ultimi decenni e il ciclo delle COP sembra volgere al termine. Ciò che sta finendo con esso è ciò che Aykut e Dahan hanno chiamato politica incantatoria6, una governance del clima incapace di agire in concreto sulle cause dell’Antropocene, e che si è ritirata nell’affermazione di principi normativi tanto universali quanto astratti. Questo lungo periodo di diplomazia climatica assomiglia in tutto e per tutto ad altri episodi storici, come il patto Briand-Kellog del 1928, che dichiarò la guerra illegale. O più tardi l’adozione da parte delle Nazioni Unite di una Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Indipendentemente dalla definizione di come e da quale ascendente morale e pratico si potesse eliminare l’uso della guerra o la negazione dei diritti fondamentali, queste dichiarazioni definivano un orizzonte normativo, uno spazio di possibilità e impossibilità che poteva essere universale solo in quanto non vincolante. Gli accordi di Parigi raggiunti nel 2015 erano un’eredità di questa diplomazia incantatoria, un risultato reale e storicamente significativo in termini di affermazioni normative, ma un risultato che ci ha permesso solo di misurare il tempo perso e di osservare passivamente l’aggravarsi della tragedia climatica. Al contrario, la costruzione di una politica climatica economicamente aggressiva, basata com’è sulla corsa ai vantaggi comparati nei settori industriali emergenti, e che vuole essere socialmente inclusiva integrando meccanismi di promozione attraverso il lavoro, è una rottura con il tempo dell’incantesimo. Le infrastrutture dell’economia post-carbonio si stanno dispiegando e l’equilibrio di potere politico si sta spostando dalla lotta contro l’inazione e la negazione a una lotta per catturare i benefici economici e simbolici della transizione7.
Gli accordi di Parigi raggiunti nel 2015 erano un’eredità di questa diplomazia incantatoria, un risultato reale e storicamente significativo in temini di affermazioni normative, ma un risultato che ci ha permesso solo di misurare il tempo perso e di osservare passivamente l’aggravarsi della tragedia climatica.
pierre charbonnier
La centralità storica del capitalismo si manifesta dunque ancora vividamente, poiché è nei suoi termini e condizioni che si sta organizzando la risposta alla crisi che sembrava travolgerlo al di là di ogni redenzione.
Questa nuova economia politica, che combina il ritorno di una forma di dirigismo alla Roosevelt e la cooperazione tecnica internazionale tipica del dopoguerra, è una tappa ambivalente nel processo di modernizzazione. L’obiettivo comune delle grandi potenze è quello di mantenere l’intensità energetica delle società industriali sbarazzandosi di ciò che era stato il loro fondamento dal XIX secolo. L’assioma di George Bush, “L’American way of life non è negoziabile“, dichiarato al Summit della Terra di Rio nel 1992, sembra aver prevalso: solo una volta soddisfatte le condizioni tecniche per la decarbonizzazione senza perdita di crescita e senza cambiamenti fondamentali negli stili di vita e nelle relazioni sociali, la risposta alla sfida climatica è iniziata – al prezzo di un aumento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera da 350 a 415 ppm. In effetti, mai prima d’ora è stato possibile prevedere un’intensificazione energetica senza lo sfruttamento delle risorse fossili concentrate nel sottosuolo, così che il rilancio di una modernizzazione post-carbonio appare come un gioco di prestigio, una scommessa tecnologica e politica il cui esito è totalmente incerto. L’idea a lungo difesa nei circoli piuttosto ristretti dell’ecomodernismo8, che consisteva appunto nello slegare il regime economico della crescita dal sostegno energetico delle energie fossili, è oggi l’assunto implicito del modo di sviluppo che si sta formando.
La scommessa incerta della modernità verde
Dopo più di mezzo secolo di messa in discussione del processo di modernizzazione, dopo la crisi esistenziale della seconda guerra mondiale, dopo gli shock epistemologici e morali provocati dalla presa di coscienza della portata del danno ecologico, la modernità non è ancora morta. Si potrebbe anche dire che è rinata dove avrebbe dovuto essere il suo cimitero: nella costruzione di una risposta alla sfida climatica. In un momento in cui sembrava impossibile andare avanti, e in cui il futuro sembrava un negoziato più o meno tragico con il crollo di un paradigma intellettuale ed economico, il sogno della modernizzazione sta riprendendo forza. Non si tratta nemmeno più, come diceva Ulrich Beck negli anni ’80, di costruire una modernità cauta e riflessiva, ma di trasformare trionfalmente i fallimenti in opportunità. Si tratta di trasformare l’orizzonte di una crisi planetaria in una fonte di creatività, per superare ancora una volta gli ostacoli che la natura si diverte a mettere sulla strada dell’homo sapiens.
Non si tratta nemmeno più, come diceva Ulrich Beck negli anni ’80, di costruire una modernità cauta e riflessiva, ma di trasformare trionfalmente i fallimenti in opportunità. Si tratta di trasformare l’orizzonte di una crisi planetaria in una fonte di creatività, per superare ancora una volta gli ostacoli che la natura si diverte a mettere sulla strada dell’homo sapiens.
pierre charbonnier
L’impasse più evidente che questo paradigma rischia di incontrare è naturalmente il conto ecologico enorme che presenterà al sistema Terra. Perché anche supponendo che le emissioni di CO2 si stabilizzino a livelli compatibili con un danno minimo, lo sforzo produttivo richiesto per installare le nuove infrastrutture non sarà fatto di aria pulita. L’elettrificazione del mondo, attraverso la diffusione di nuove reti intelligenti e la generalizzazione delle batterie nei veicoli e nei sistemi di trasporto, comporta un trasferimento del carico estrattivo dalle risorse fossili ad altri minerali, come litio, grafite, cobalto9. I petro-nazionalismi che si sono sviluppati all’epoca della decolonizzazione e della grande accelerazione in Medio Oriente e in America Latina sono in procinto di essere profondamente destabilizzati 10, mentre nuovi guadagni minerari stanno ridefinendo il destino di Ecuador e Bolivia11. Anche qui, le continuità con il vecchio mondo sono evidenti: l’alone ecologico e politico delle nuove filiere e dei nuovi processi produttivi è notevole, e dà argomenti a chi vuole aggiungere al problema del bilancio del carbonio quello di un più generale bilancio delle risorse 12. Gli schemi di compensazione dei gas serra sollevano anche questioni tecno-politiche: possiamo fare affidamento sulla geoingegneria, e se sì, sotto quale modello di governance? Quanto terreno agricolo sarà inghiottito per garantire lo stoccaggio biologico delle emissioni industriali? La questione della sicurezza alimentare è effettivamente entrata nel dilemma del clima, aggiungendo una dimensione a questioni già complesse.
Ma una cosa è chiara: la costruzione di un’economia mondiale decarbonizzata non garantisce un futuro libero dai problemi dei limiti e dei rischi. Siamo in una situazione tragica. Da un lato, lo sforzo climatico non può essere relativizzato, e ancor meno scoraggiato da argomenti massimalisti che rischierebbero di farlo apparire vano o fuori portata. D’altra parte, i mezzi scelti per realizzare questa impresa danno origine a nuove minacce, spostano aree di conflitto, pressioni estrattive, relazioni di potere tra attori strategici, e naturalmente ridisegnano la divisione sociale tra beneficiari e perdenti della transizione – il tutto in un contesto in cui il cambiamento climatico si farà sentire in ogni caso. Costruire un’economia decarbonizzata è un imperativo universale, eppure il percorso emergente lega questo processo al consolidamento del potere del partito comunista cinese e dell‘establishment politico statunitense. Questa è una tensione classica della modernità tecnica, che dal XIX secolo ha inseguito le conseguenze negative delle sue stesse innovazioni mettendo insieme risposte istituzionali e materiali alle crisi che crea.
Nonostante questi vincoli e incertezze, i principali attori geopolitici hanno già preparato la base ideologica per la loro futura riorganizzazione.
Dopo una fase di sviluppo “sporco” resa necessaria dall’emergere di centinaia di milioni di persone dalla povertà, la Cina prevede per i prossimi decenni una riconciliazione con la biosfera, in una forma di sovranità simbiotica che trae alcuni argomenti dalla filosofia antica. Le misure di protezione della biodiversità e del paesaggio fanno parte della costruzione di una narrazione nazionale in cui la conquista della prosperità pacificherà le relazioni sociali ed ecologiche. Lo stato sviluppista sta sfidando se stesso ad apparire come un leader responsabile sulla scena internazionale, e allo stesso tempo sta disegnando i contorni di un metodo di produzione di alta qualità che rispetta l’unità e l’armonia della natura. Il comunicato di Xi Jinping per il vertice del 22 aprile è un esempio lampante di prosa eco-sovranista13. Vi si riscontrano elementi di deep ecology, che glorificano il sublime naturale e il rispetto che esso impone, evidenti elementi eco-modernisti, che presentano il futuro dello sviluppo come l’integrazione delle norme ecologiche nel regime produttivo attraverso l’innovazione tecnica, e naturalmente elementi strategici che presentano la Cina come garante della giustizia climatica, cioè del diritto allo sviluppo delle nazioni meno avanzate. Tutti questi elementi articolati insieme testimoniano l’intenzione di incarnare un universalismo antimperialista, un universalismo che non è formulato nei termini cosiddetti “occidentali” dei diritti umani.
Da parte sua, anche gli Stati Uniti stanno dando forma alla loro filosofia della storia. Questo è molto più facile da capire per noi, poiché si basa essenzialmente sulla storia del XX secolo, il New Deal, Roosevelt e lo sforzo bellico. La scommessa di Biden e della sua squadra di una transizione che assicuri sia gli investitori che i lavoratori (“win-win”), che mira a rompere la coalizione fossile14 che aveva portato Trump al potere spostando ampi segmenti del capitale e del lavoro dalla parte della lotta per il clima, rimanda al discorso dell’unità nazionale di fronte alla crisi, della mobilitazione dei mezzi, dell’intelligenza e del lavoratore onesto di fronte a un nemico totale. Il successo di questa scommessa è ancora molto incerto, perché dipende dalla capacità di reazione dell’avversario repubblicano nel gioco politico interno, e naturalmente dall’efficacia immediata di queste proposte sulla scala di un mandato quadriennale.
La rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina deriva quindi dal fatto che i loro progetti sono per molti versi simili. Sono in competizione per gli stessi benefici economici e politici da trarre dalla grande transizione climatica. Ma non condividono solo un progetto di riorientamento industriale: condividono anche necessariamente le incertezze di questa scommessa, cioè i rischi che il suo fallimento comporterebbe. O perché il processo di decarbonizzazione è troppo lento, o perché si scontra con troppi muri ecologici, o perché non fornisce abbastanza speranza sociale, e quindi non è molto mobilitante, o infine perché viene subito sepolto dal rilancio della coalizione dei combustibili fossili. In uno scenario in cui le decisioni politiche sono sia superate dall’Antropocene che prese in ostaggio da forze sociali opposte, l’intero edificio ideologico e normativo della transizione capitalista crolla, e con esso ogni prospettiva di futuro. Perché in questo caso, è il piano B che mancherebbe.
La rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina deriva quindi dal fatto che i loro progetti sono per molti versi simili. Sono in competizione per gli stessi benefici economici e politici da trarre dalla grande transizione climatica.
pierre charbonnier
Ecco perché due domande devono tenerci all’erta. In primo luogo, siamo davvero intrappolati in questo orizzonte storico? La reinvenzione di una produttività post-carbonio e l’impulso modernista avallano necessariamente la prospettiva di un male minore ecologico? In secondo luogo, l’Unione Europea ha i mezzi per costruire una narrazione simile a quella proposta da USA e Cina?
La breccia politica: affrontare e superare il capitalismo verde
Cominciamo con la prima domanda. La spirale geopolitica e sociale degli accordi post-carbonio ci viene presentata come una necessità perché è profondamente associata a certe convinzioni ideologiche e all’inerzia ereditata dal passato. Avevo cercato di metterli in evidenza in Abondance et Liberté, descrivendo come la natura e il territorio fossero stati previsti come vincoli da superare nel quadro di una razionalità politica organizzata per stimolare la conquista della produttività. Paradossalmente, è questo patto che è ancora all’opera nella costruzione delle attuali politiche climatiche, forse al suo meglio, poiché potrebbe permettere a milioni di lavoratori di essere reintegrati in un’economia all’altezza delle sfide dell’Antropocene. Tutto sembra essere fatto, tuttavia, in modo che l’emancipazione collettiva non possa rivendicare l’autolimitazione come condizione. Tutto sembra essere fatto in modo che non ci si debba porre la questione politica delle forme di libertà nate con la moltiplicazione delle forze produttive. Ma quante altre frontiere possiamo respingere prima che la macchina modernista si esaurisca definitivamente?
Tuttavia, alcune certezze sono state messe alla prova negli ultimi mesi in un modo che raramente era stato sperimentato nel recente passato. Le ansie generate dalla crisi del Covid-19 hanno permesso di eliminare certi divieti legati al debito, all’intervento dello Stato e, sembra, ai diritti di proprietà intellettuale. Il motivo della paura ha aiutato a sbloccare meccanismi di protezione che erano stati considerati controproducenti per circa 40 anni. E la congiunzione di questa crisi sanitaria con la crisi climatica, di cui è per certi aspetti solo una prova generale su piccola scala, rafforza questi meccanismi di contenimento della crisi: se l’obiettivo è quello di ricostruire un’economia capace di assorbire gli shock e di aprire un nuovo orizzonte storico di progresso, allora tanto vale prendere due piccioni con una fava e organizzare un’economia post-Covid che sia al tempo stesso climaticamente responsabile.
Questo solleva la questione se, tra i meccanismi di protezione implementati sulla scia della crisi del Covid, ci sia un posto per la libertà da un’economia ad alta intensità energetica. Se la possibilità teorica di un’economia post-Covid è da prendere in considerazione, allora la questione è se sia possibile creare un’economia rispettosa del clima. Se la possibilità teorica e politica di un’altra ristrutturazione del patto sociale, diversa dalle varianti americane e cinesi dell’eco-modernismo, deve essere mantenuta, non è solo perché la prospettiva di un capitalismo verde non è sufficientemente radicale in termini di idee e perché conserva l’essenza dei rapporti di potere così come esistono. Questo è senza dubbio il caso, ed era già il caso della socialdemocrazia, dello stato sviluppista post-coloniale, o di qualsiasi accordo politico stabilito dopo una grande crisi. Il problema specifico posto dal perpetuarsi del modo di sviluppo basato sulla crescita nel XXI secolo, però, è lo iato tra le forme di vita, di desiderio e di giustizia che ha generato e i vincoli materiali che incontra. Questo è il punto su cui il pensiero della decrescita avrà sempre assolutamente ragione, qualunque cosa si pensi del loro approccio strategico, del loro antimodernismo, o anche della scelta del termine “decrescita”: i flussi di materia che strutturano l’economia mondiale sono sovradimensionati, non sono sostenibili. Da questo punto di vista, l’invenzione di un capitalismo verde assomiglia a un processo di negazione psicoanalitica. “Lo so, ma comunque”, stiamo dicendo a noi stessi nel nostro subconscio collettivo. Tra una riorganizzazione della produttività che promette di cambiare poco o niente nelle nostre forme di vita – e parlo delle forme di vita del Nord industriale -, salvando il pianeta, e una messa in discussione dello schema ideologico e pratico della produttività che ci chiederebbe di vivere diversamente per aumentare le nostre possibilità di preservare la Terra e probabilmente aumentare la giustizia globale, la grande maggioranza sceglie la prima alternativa, perché percepisce il secondo come un’avventura incerta. Questo ha a che fare con l’inerzia delle infrastrutture decisionali e di potere, che hanno bisogno di continuità per fare cambiamenti incrementali, ma anche con l’inerzia delle strutture sociali e dei desideri collettivi.
Il problema specifico posto dal perpetuarsi del modo di sviluppo basato sulla crescita nel XXI secolo, però, è lo iato tra le forme di vita, di desiderio e di giustizia che ha generato e i vincoli materiali che incontra.
pierre charbonnier
Ma non dobbiamo necessariamente considerare l’alternativa tra capitalismo verde e autolimitazione volontaria come una divergenza ideologica. Piuttosto, questi modelli dovrebbero essere visti come due possibili futuri che hanno tra loro una relazione dinamica. Quello che dobbiamo cercare di immaginare è ciò che è politicamente e socialmente possibile con l’attuale scommessa sulla decarbonizzazione del capitalismo. Possiamo considerare questa prospettiva in due modi.
- In primo luogo, questo processo ha un effetto di chiusura sulla creatività sociale e politica. L’accelerazione della transizione energetica avviene senza grandi danni sociali ed ecologici, crea un sostegno più ampio per le élite politiche ritenute capaci di aver dirottato il meteorite, e mantiene la possibilità, almeno per le persone più ricche del pianeta, di vivere sulla base dello stesso modello materiale dei decenni passati. Il culto della libertà si riflette nell’accesso a mezzi di trasporto individuali elettrici ancora poco costosi, e la sfera dell’esistenza individuale e domestica rimane impermeabile ai vincoli ecologici e territoriali. La domanda di energia è gestita principalmente attraverso lo sviluppo di macchine più economiche, e discreti incentivi limitano l’effetto rimbalzo. Elon Musk e gli imprenditori della rivoluzione elettrica sono divinizzati, e il sistema di valori che prevale nella regolamentazione neoliberale del capitalismo è salvaguardato. Metaforicamente, la svolta viene presa senza bisogno di frenare, senza che le élite politiche si mettano fondamentalmente in discussione. Dopo la svolta, il mondo si sveglia dall’incubo climatico dicendo: “Era tutto qui? “.
- In un altro scenario, molto più realistico, lo sviluppo delle politiche climatiche è più o meno volontariamente accompagnato da cambiamenti sociali più profondi. L’eliminazione delle lobby dei combustibili fossili cambia l’equilibrio di potere all’interno dell’economia, e permette una comprensione più accurata del ruolo della scienza nella società; lo sforzo industriale della transizione modifica l’equilibrio tra lavoro e capitale, tendendo a favorire il primo; la progettazione urbana cambia per integrare nuove forme di mobilità e per rendere possibile il risparmio energetico; le catene di approvvigionamento, in particolare nel settore agricolo, diventano più brevi, e il legame tra produttori e consumatori diventa più stretto; l’adozione di tecnologie di trasporto elettrico sta abituando la società a integrare nei suoi comportamenti nuovi vincoli di tempo e nuove relazioni con lo spazio; la responsabilità giuridica verso le generazioni future permette di limitare la corruzione degli affari pubblici da parte del mercato, mentre i paesi esportatori di minerali critici stanno organizzando il loro equivalente dell’OPEC e ci costringono a una certa sobrietà. Il capitalismo non è morto, ma una serie di effetti collaterali, in parte voluti e in parte non voluti, tendono a ridisegnare le relazioni sociali e i profili antropologici che popolano la Terra.
In questo secondo scenario, le necessità pratiche e istituzionali della decarbonizzazione non chiudono la porta della storia instaurando una modalità di sviluppo egemonica e onnicomprensiva, una tappa finale delle fasi di crescita economica descritte da Rostow negli anni ’6015. Al contrario, inducono un approfondimento della riflessione collettiva sui legami tra produttività ed emancipazione. Non c’è dubbio che le grandi infrastrutture della modernità si trasformeranno, ma non è ancora chiaro se questi cambiamenti contribuiranno a inibire il desiderio di cambiamento (o se vogliamo vedere il lato positivo: ad assicurare una formula socio-economica che funzioni bene anno dopo anno) o al contrario a stimolarlo. Ma nella seconda ipotesi, dobbiamo essere pronti a concepire e articolare insieme le nuove aspirazioni che emergono quando le società, allettate dall’assaggio delle nuove libertà che vengono loro offerte, decidono che non sono soddisfatte e chiedono di più.
L’errore del movimento per la decrescita, in questa prospettiva, è stato quello di presentare la drastica limitazione dei livelli di consumo come una precondizione assoluta per qualsiasi futuro desiderabile, come se la constatazione fisica fosse sufficiente a imprimere un movimento storico e un riallineamento degli interessi sociali, come se bastasse vedere il problema per superarlo. In questo quadro, l’inevitabile cambio di regime energetico sarebbe condizionato da una rivoluzione ideologica che per il momento non solo è fuori dalla portata dei nostri sistemi sociali, ma anche controproducente, perché troppo intransigente, e quindi bersaglio di critiche per la sua inattuabilità. D’altra parte, potrebbe essere che la cultura e le istituzioni necessarie per questa autolimitazione siano meno la condizione iniziale del cambiamento che il suo effetto progressivo. I pochi esempi riportati sopra ci permettono di immaginare che certe conseguenze sociali e culturali del capitalismo verde aprono la porta a nuove disposizioni materiali e sociali, che a loro volta generano nuove idee, nuovi interessi. L’universo della produzione totale, come dice Bruno Latour, non viene abbandonato in seguito alla realizzazione improvvisa e dogmatica dei suoi mali, ma nel corso di un processo di integrazione graduale delle norme di esistenza indotto da una iniziazione socio-storica, che è la modernizzazione verde.
Perché non si tratta semplicemente di nuovi modi di vita, di una modifica superficiale dei paesaggi urbani e delle diete, ma di una serie di trasformazioni che riguardano tutte le dimensioni della convivenza, dal diritto ai rapporti di forza, dai modi di produzione alle dinamiche occupazionali, dalle rappresentazioni della scienza alle forme di legittimazione. Tuttavia, una volta che l’ingranaggio di questa nuova politica di produttività è stato messo in moto, con tutte le conseguenze che ne derivano, è possibile che si inizi a chiedere di più. Dopo aver assaggiato i benefici di un regime socio-economico liberato dalle sue caratteristiche più rovinose e alienanti, forse la maggioranza vorrà proseguire su questa strada, anche se questo non è lo scenario previsto dai leader del capitalismo verde. Questa è l’ambivalenza fondamentale dei progetti del Green New Deal. Possono essere intesi come strumenti per mantenere lo status quo, per rilegittimare un capitalismo che è diventato responsabile e sostenibile, o come un impulso trasformativo più profondo. Questa è allo stesso tempo la debolezza e la forza di questa piattaforma: la sua forza, perché è in principio capace di federare attori politici mossi da interessi e ideali molto diversi tra loro, dal più banale profitto alla più esigente rivoluzione sociale; ma anche la sua debolezza, perché questo movimento federativo è in parte costruito su un malinteso. Tra l’uso da parte del team di Biden di alcuni elementi del Green New Deal per ricostruire la diplomazia economica statunitense, e i movimenti progressisti che cercano di sfruttare il potenziale di giustizia sociale e razziale della transizione, il divario è ampio. Perché nella seconda opzione, più esigente, emerge un’ipotesi di socialismo democratico e sostenibile. Questa ipotesi può essere formulata ex cathedra come la conseguenza naturale dei principi di giustizia, o come una filosofia della storia ecologica, ma è più probabile che si realizzi a partire da un effetto a catena di mutazioni che danno origine ad altre, e che alla fine si fanno strada nello Stato. Nell’incertezza dello sviluppo storico delle politiche climatiche, rimane la possibilità di nuove forme di politicizzazione della società.
Perché non si tratta semplicemente di nuovi modi di vita, di una modifica superficiale dei paesaggi urbani e delle diete, ma di una serie di trasformazioni che riguardano tutte le dimensioni della convivenza, dal diritto ai rapporti di forza, dai modi di produzione alle dinamiche occupazionali, dalle rappresentazioni della scienza alle forme di legittimazione.
pierre charbonnier
Potrebbe benissimo darsi che i mezzi utilizzati per salvare il capitalismo dalla sua stessa rovina, dalle sue stesse contraddizioni, portino a superare l’apparente fatalità di un eco-modernismo divenuto universale, basato sull’elettrificazione degli stessi bisogni, e sul trasferimento del peso estrattivo dei combustibili fossili ad altri minerali. In questa ipotesi, il compito del movimento ambientalista e di giustizia sociale non è quello di opporsi di petto al capitalismo verde e alle sue menzogne, come se fosse una questione di verità o morte. Consisterebbe piuttosto nell’identificare nei meccanismi di decarbonizzazione dell’economia le leve che ci permettono di ripoliticizzare i bisogni, di ridefinire il ruolo dello Stato e delle sue élite, di rendere un altro modo di sviluppo, un altro modo di organizzazione, desiderabile per il maggior numero possibile di cittadini. Si tratterebbe di sfruttare le lacune aperte dalla reinvenzione della produttività (e in particolare il potere restituito ai lavoratori e agli operatori tecnici in un’economia a più alta intensità di lavoro) per farne la base di una domanda socio-ecologica più esigente. L’opposizione di principio al capitalismo verde soddisfa certamente aspirazioni teoriche, che in quanto tali sono legittime, ma hanno solo un ruolo strategico secondario. La vera sfida sta nella capacità di cogliere ciò che erode il desiderio di capitalismo nella società, che a sua volta indebolisce i meccanismi che alimentano la legittimità della ricerca della crescita. Da questo punto di vista, la risposta politica all’impasse materiale delle economie moderne non appare più come un’utopia, o come la costruzione astratta di un ideale sradicato dall’esperienza collettiva (se non quella di un’avanguardia minoritaria), ma come una tendenza sociale concretamente al lavoro nella pratica.
L’ipotesi di una trasformazione europea
Per concludere, possiamo passare alla seconda domanda, sull’Europa. L’incertezza tra il potenziale soporifero o, al contrario, involontariamente rigenerativo del capitalismo verde è molto diversa nelle diverse regioni del mondo16. La capacità degli Stati Uniti e della Cina di mobilitare grandi quantità di risorse e territorio per sviluppare un’economia di crescita decarbonizzata è reale. Ciò è dovuto principalmente alle caratteristiche geo-ecologiche di queste due formazioni politiche, che hanno in comune il fatto di beneficiare di giganteschi cuori estrattivi, sia sotto la propria giurisdizione che attraverso vari processi neo-imperialisti. Tra gli Appalachi e l’Alaska da un lato, e nel fronte pionieristico dell’Asia centrale dall’altro, si trovano le riserve necessarie per una decarbonizzazione politicamente conservatrice. In effetti, non è irragionevole chiedersi se la definizione stessa dell’obiettivo “zero netto” non sia un’eco delle opportunità geo-ecologiche condivise dalle due grandi potenze mondiali, che sono anche imperi continentali con spazi scarsamente popolati e geologicamente ricchi che permettono l’estrazione di risorse strategiche e il rimboschimento di vasti territori per ricreare pozzi di carbonio.
Le cose sono molto diverse in Europa. Geograficamente e fisicamente, l’Europa è l’unica potenza economica del mondo (forse insieme al Giappone) che ha raggiunto una fase di quasi saturazione demografica, o almeno contiene pochi spazi vuoti. Il fatto che la Norvegia, uno dei pochissimi paesi del continente che ha un margine ecologico così ampio, non faccia parte dell’Unione non è certo una coincidenza: sarebbe irragionevole mettere un tale patrimonio in comune. L’Europa, privata delle terre coloniali che costituivano una buona parte della sua ricchezza in passato, non è quindi altro che il cuore metropolitano di un ex impero marittimo che aveva i suoi margini estrattivi. Il libero mercato e il vantaggio tecnologico acquisito prima della guerra gli hanno permesso di non bloccarsi completamente, ma la possibilità di questo scenario rimane, poiché i vincoli ecologici e territoriali si fanno sentire immediatamente nel vecchio continente, che è anche il piccolo continente. Sarebbe certamente pericoloso affermare che l’Europa è condannata dalle sue caratteristiche morfologiche alla decrescita, ma vi è senza dubbio almeno predisposta, o invitata.
Per evitare di porre le questioni esclusivamente in termini neo-malthusiani, legando demografia e territorio in modo ristretto, dobbiamo invece riflettere sul legame storico tra socialismo e crescita, o tra condivisione e rallentamento. François Ruffin ha contribuito a rendere popolare negli ultimi anni in Francia lo slogan apparentemente idealista “Meno beni, più legami“17, che chiede un ridimensionamento dei nostri modelli di consumo nella speranza di rigenerare la solidarietà sociale. Ma è così ingenuo? Come sappiamo, la socializzazione parziale dell’economia è stata resa possibile dopo la guerra dall’aumento della produttività e dall’accesso a risorse a basso costo (o rese economiche dall’esternalizzazione dei rischi). In altre parole, il modello sociale dell’Europa occidentale ha una profonda affinità con la crescita, un’affinità che ha le sue radici nel progressismo illuminista e nella teodicea marxista della produzione. La crisi del welfare state ha poi ancorato nelle rappresentazioni politiche dominanti l’idea che questo modello sociale dovesse piegarsi al gioco della concorrenza per salvaguardare le sue condizioni di esistenza, ed è così che il neoliberismo ha potuto presentarsi come il salvatore del welfare. Ma la questione della relazione tra socialismo e produttività può essere posta al contrario. Definendo uno zoccolo duro di diritti sociali inalienabili, un insieme di infrastrutture pubbliche accessibili senza condizioni, è possibile circoscrivere una sfera di relazioni sociali al di fuori della portata della legge del mercato, anche quando questa si presenta come un vettore di crescita. In altre parole, in un caso, la socializzazione dell’economia dipende dalla conquista dei guadagni di produttività e dei vantaggi comparati del mercato, e nell’altro, il mercato è condannato a occupare lo spazio che emerge una volta che si mettono in sicurezza diritti e infrastrutture sostanzialmente definiti e garantiti “a qualunque costo”.
La formula “Meno beni, più legami”, o quella di George Monbiot, “sufficienza privata, lusso pubblico”, possono allora essere prese come linee-guida politiche senza richiedere una conversione improvvisa della popolazione alla semplicità volontaria e ai precetti di Gandhi. Sono più semplicemente il risultato di un vincolo pratico imposto al socialismo: nella misura in cui non può più essere concepito come un effetto collaterale dell’estensione della sfera economica (il paradigma produttivista della ripartizione dei profitti), esso viene ridefinito come un principio di limitazione, come una volontà politica che determina un cambiamento nella dimensione dell’economia. Questa inversione della gerarchia tra crescita e redistribuzione si può vedere, per esempio, nella creazione di reti di condivisione di automobili ed elettrodomestici vari, nello sviluppo del riciclaggio, della riparazione e della ristrutturazione, che inibiscono la commercializzazione di nuovi oggetti e l’accumulo di rifiuti, nelle politiche di salute pubblica che limitano le patologie evitabili, e naturalmente nelle misure fiscali che impediscono la creazione di fortune private confiscatorie ed ecologicamente costose. Ci sono molti esempi che dimostrano che la condivisione può non portare all’accelerazione economica, ma al contrario all’ottimizzazione dei flussi di materiali e risorse.
In un contesto in cui è improbabile che l’Europa tragga i maggiori benefici dalla modernizzazione verde concepita a Pechino o a Washington, e in cui non ha nemmeno un bisogno urgente di crescita a fini di sviluppo, lo scenario dell’illimitatezza economica post-carbonio è, per essa più che per qualsiasi altra parte del mondo, una scommessa rischiosa. Dobbiamo quindi guardare con una certa distanza alle profezie modernizzatrici di Biden tanto quanto allo sviluppo simbiotico di Xi: la “frontiera infinita” non è accessibile per noi, e certamente non ne abbiamo bisogno. Meglio invece guardare all’economia stazionaria prefigurata da J. S. Mill nel 1848, o all’idea di un’obsolescenza del “problema economico” immaginata da Keynes nel 1930. La decarbonizzazione dell’economia mondiale sarà un test per l’Europa, dove sarà definito il suo atteggiamento verso il futuro. Le prossime trasformazioni del nostro ambiente economico e tecnico possono portare a ciò che la “grande accelerazione” ha causato negli anni 50, cioè una depoliticizzazione dell’esistenza, assorbita nello sbocco del consumo e di un’apparente pace sociale. Ma possono anche portare a una ripoliticizzazione dei bisogni, del tempo e dello spazio, che non può essere ridotta alla richiesta delle classi superiori di una migliore qualità della vita.
In un contesto in cui è improbabile che l’Europa tragga i maggiori benefici dalla modernizzazione verde concepita a Pechino o a Washington, e in cui non ha nemmeno un bisogno urgente di crescita a fini di sviluppo, lo scenario dell’illimitatezza economica post-carbonio è, per essa più che per qualsiasi altra parte del mondo, una scommessa rischiosa.
pierre charbonnier
L’Europa, che manca di una narrazione fondativa capace di sostituire i miti dell’universalismo imperiale e del libero mercato, potrebbe trovare in queste trasformazioni gli inizi di una risposta a questa mancanza. Possiamo rifiutare l’idea che l’Europa sia stata la culla del modernismo, ma non c’è dubbio che sia stata l’Europa a collegare per prima la modernità e l’intensità energetica. Forse è il momento, allora, di farne l’avanguardia di un’altra proposta politica, meno dipendente dallo spirito di conquista che trionfava quando si pensava che la Terra fosse infinita, e che è ormai obsoleta.
Note
- Nell’originale inglese: “No one is being asked for a sacrifice, this is an opportunity”
- https://www.nytimes.com/2021/04/23/us/politics/climate-biden-domestic-policy.html
- https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm
- https://www.ft.com/content/3ea3e9f6-1c18-42c7-9912-c51efed3f721
- https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2017-1-page-17.htm
- https://www.cairn.info/gouverner-le-climat–9782724616804.htm
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/04/private-finance-decarbonise-economies-green-state?CMP=fb_cif)
- https://thebreakthrough.org/
- https://www.revolution-energetique.com/la transition-energetics-will-it-lose-raw-materials
- http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio-histoire/Aux-pays-de-l-or-noir
- https://www.dukeupress.edu/resource-radicals
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/apr/22/earth-day-environmental-catastrophe-policy
- http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/22/c_139899289.htm
- https://foreignpolicy.com/2021/02/12/carbon-coalition-median-voter-us-politics/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rostow%27s_stages_of_growth
- https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-newsletter-17
- In francese nell’originale: Moins de biens, plus de liens