Competenti contro deplorevoli: la nuova lotta di classe
In questa ampia conversazione che apre l’edizione italiana di La Nuova lotta di classe di Michael Lind, appena pubblicata da Luiss University Press, Raffaele Alberto Ventura e Lorenzo Castellani partono dai temi portati avanti dal pensatore americano per ragionare sulle fratture e ricomposizioni in corso nella politica e nelle società globali.
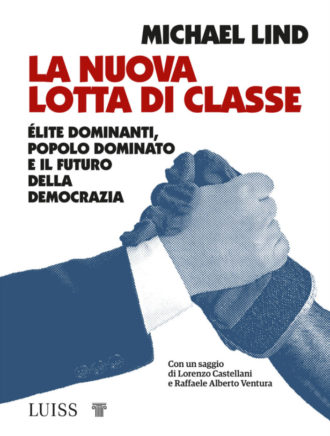
Raffaele Alberto Ventura: L’intera storia della nostra società è la storia di una lotta di classe. Non è solo Marx che lo dice, ma anche Michael Lind, politologo più conservatore che progressista…
Lorenzo Castellani: Come si evince dal titolo, Lind non ha alcun problema a ricorrere alla tassonomia delle classi sociali e a considerare i conflitti in atto come una vera e propria guerra di classe. Secondo l’autore, negli Stati Uniti i confini della geografia, dell’istruzione e del reddito delineano i nuovi gruppi sociali e i loro interessi. La classe cosmopolita, istruita, metropolitana da un lato; le classi medio-basse, con grado di istruzione inferiore, produttori territorializzati che vivono in provincia dall’altro. Sono queste due placche tettoniche che entrano in attrito, secondo l’autore. Ma è davvero così? La divisione è così netta?
RAV: Secondo Lind questa popolazione istruita, concentrata nelle grandi metropoli ma caratterizzata dal suo strutturale nomadismo, costituirebbe oggi la vera classe dominante. Paradossalmente, i primi a parlare in maniera critica di una simile “nuova classe” erano stati i dissidenti sovietici. È noto il libro di Milovan Gilas, Nova Klasa del 1957, che denunciava la burocrazia degli Stati socialisti. Ma in Francia Lefort e Castoriadis, sulla rivista Socialisme ou Barbarie, avevano iniziato fin dal 1949 a studiare questa trasformazione. Potremmo risalire ancora più indietro, al trotzkista Bruno Rizzi che con il suo saggio sulla Burocratizzazione del mondo (1939) influenzò grandemente la teoria della “rivoluzione manageriale” di James Burnham (1941), modello esplicito di Michael Lind. Di fatto l’intera sociologia del Novecento, a partire da Max Weber, ha inseguito questa strana classe per cercare di coglierne la specificità: classe dominante? Classe improduttiva? E come definirne l’estensione? L’economia della conoscenza, a partire dagli anni Sessanta, ha permesso di difendere l’idea che questa classe fosse “produttiva” e non “parassitaria”, aprendo alla costruzione della categoria di cognitariato nel pensiero post-operaista.
Come si vede, la nuova classe è piuttosto malleabile, nel senso che può servire sia da avatar della borghesia che del proletariato, trovandosi esattamente nel mezzo. A rendere ancora più difficile la sua collocazione è la coesistenza tra “capitale economico” e “capitale cognitivo”, l’adozione di consumi tipicamente borghesi unitamente a un reddito da lavoro non necessariamente eclatante. Se vogliamo ridurre il corpo sociale nelle economie avanzate al minimo numero di soggetti direi che non possiamo scendere sotto alle quattro classi: una classe laboriosa in parte immigrata o delocalizzata; una classe proprietaria sempre più concentrata; una classe competente piuttosto disomogenea; infine una classe-scarto prodotta dalla deindustrializzazione e dallo svuotamento delle aree rurali. Sono queste ultime due le protagoniste della commedia degli equivoci del populismo: la “nuova classe” competente diventa l’oggetto del risentimento della piccola borghesia in declino, che a sua volta viene descritta dai competenti come razzista e “deplorevole”. Ma non bisogna perdere di vista il fatto che le presunte élite urbane sono spesso precarie e sottopagate, vincolate a piccoli lussi posizionali (i proverbiali brunch a base di avocado delle caricature) ma incapacitate ad accedere alla proprietà immobiliare. Insomma disagiate a modo loro.
Lorenzo Castellani: L’impressione, e qui vorrei offrire una riflessione diversa da quella di Lind, è di una certa difficoltà ad applicare la tipologia delle classi sociali all’attuale società. Come anche tu sottolinei, le élite scolarizzate e urbane spesso non sono del tutto sovrapponibili al vertice economico delle società occidentali, o comunque ci sono ancora molti benestanti che non possono essere annoverati parte dei competenti. Lo stesso Lind in qualche modo lo evidenzia: esistono ancora produttori territorializzati, piccoli e medi imprenditori, meno alfabetizzati, decentralizzati ma comunque capaci di produrre ottimo valore economico e occupazionale. Ciò che a me pare emergere è dunque una società, per usare un paragone storico forse un po’ azzardato, divisa in ceti e corporazioni di stampo neo-medievale. Lo status, oggi fornito dai centri di certificazione della competenza (grandi università, think tank, giornali ecc), in definitiva conta più dell’elemento economico per l’uomo istruito del Ventunesimo secolo. I competenti sono lavoratori intellettuali altamente scolarizzati e specializzati, che si concentrano in quelli che Lind chiama gli “hub della conoscenza”, in genere in prossimità delle grandi metropoli o in zone capital intensive, come la Silicon Valley. Non tutti sono destinati a diventare CEO di Google o Head of Research di un grande fondo di investimento, ma c’è una condivisione di cultura, uno stile di vita e delle maniere omogenee.
Per molti versi si sta affermando un’ovvietà, perché nella storia queste dinamiche sociali sono sempre esistite, ma oggi la questione è diventata centrale nel dibattito pubblico e intellettuale per tre motivi. Uno politico, e cioè che la democrazia reclama sempre uguaglianza (una testa, un voto), ma è difficile mantenere questo equilibrio in una società completamente alfabetizzata e con livelli di scolarizzazione così differenti. Ciò è reso evidente dal complesso pedagogico che affligge spesso i competenti, i quali vorrebbero correggere il legno storto del resto della popolazione imponendo linguaggi e norme di comportamento. È evidente la frustrazione sul piano politico: il sistema democratico non valorizza anni di studi, master e dottorati poiché il voto di un competente e quello di un qualsiasi altro cittadino hanno valore identico. Da qui la spinta verso la proposizione di forme di tecnocrazia o epistocrazia, idee che negli ultimi anni hanno invaso il mondo dell’accademia e del giornalismo. Una tecnocrazia che è già molto presente negli attuali regimi politici attraverso le banche centrali, le autorità amministrative, i regolatori globali, le magistrature e le istituzioni internazionali.
C’è poi un motivo sociale, per cui i filtri funzionali della meritocrazia tendono a creare gruppi auto-segregati che hanno perso il contatto con altre forme di realtà, e con le province in particolare. Si costruiscono network della competenza, spesso sovranazionali o addirittura globali, che però diventano enclave chiuse rispetto al resto della società. Da un lato i cosmopoliti, che possono vivere e lavorare ovunque, dall’altro i territorializzati, che possono vivere e lavorare soltanto dove si trovano. Questa mancanza di prossimità al mondo territorializzato e manifatturiero tende a delegittimare i competenti nelle loro rivendicazioni politiche. E poi c’è un fattore culturale, e cioè che una mentalità neo-positivista si è fatta strada nelle nostre élite: nell’era della totale secolarizzazione e della fine delle ideologie, la complessità sociale può essere gestita solo ricorrendo alla scienza e alla tecnica. Procedure, dati, metodologie, esperimenti vengono richiesti anche in campi un tempo dominati dalla conoscenza storica, filosofica, umanistica. Aleggia in gran parte della classe dirigente occidentale l’illusione fatale che la competenza possa fornire tutte le risposte, abbracciare tutta la conoscenza di un dato problema, e che il rigore dei metodi e dei processi sia più importante dei fini e dell’oggetto della ricerca.
RAV: La pandemia del 2020 ha indubbiamente rivelato l’esistenza di una nuova tecnolatria o scientismo che seduce la sinistra, in controtendenza con la tradizione filosofica costruttivista che l’aveva sedotta precedentemente, a partire dagli anni 1960. Io ancora mi chiedo come siamo passati da Michel Foucault alle ontologie forti del post post-post-strutturalismo. È la sinistra del patentino di voto e dell’obbligo vaccinale, una sinistra medio-progressista che non si accorge della contraddizione fondamentale che le sue tentazioni epistocratiche fanno emergere. Se il sistema democratico ha funzionato tanto bene e per tanto tempo è perché il suo principio di legittimazione attraverso la volontà popolare forniva la dose di consenso necessaria per operare. Ma nel momento in cui viene svelato l’inganno – come nella Fattoria degli animali di Orwell, non a caso ispirata a Bruno Rizzi, “Siamo tutti uguali ma alcuni sono più uguali degli altri” – rischia di crollare tutto. Fiducia, consenso, potere. Non a caso La nuova lotta di classe si apre con un riferimento alla rivoluzione francese.
Cosa ci riserva il futuro? Lind torna sul tema del conflitto tra centri urbanizzati e periferie rurali, già esaminato da David Goodhart e Christophe Guilluy, poi incarnato plasticamente dalla rivolta dei Gilets jaunes in Francia nonché dalla distribuzione geografica del voto populista nel Regno Unito e negli USA, concentrato nelle zone più vuote e dimenticate. Lind paventa che alla “rivoluzione neoliberale dall’alto” si opponga una “controrivoluzione populista dal basso”. Ma ci sono davvero margini perché questa si realizzi?
Lorenzo Castellani: Temo sia molto difficile. E non perché non ci possano essere degli esperimenti politici di successo: per molti versi Trump, Brexit, il Movimento 5 Stelle lo sono stati. Ma perché le strutture su cui poggia il nostro mondo hanno dato prova di essere molto forti e resistenti. La globalizzazione può essere rallentata, ma non smantellata. La politica può perdere la postura tecnocratica degli ultimi anni, ma non si può ricostruire la democrazia diretta degli ateniesi. Il capitalismo può essere regolato, ristrutturato, ri-territorializzato, ma nessuno immagina un mondo fondato su una politica economica totalitaria e autarchica o un’economia di soli beni pubblici e comuni. La somma tra scienza, burocrazia e capitalismo è ancora la nostra gabbia d’acciaio e si estende su scala planetaria.
Qui la sfida posta da Lind è suscettibile di un’interpretazione più realistica: ristrutturare il sistema verso il basso per evitare che s’inneschino crisi di legittimazione così potenti da minare l’ordine politico occidentale. Se c’è una global polity, ordinamento e rete globale, regno dei tecnici e dei competenti, deve esserci anche una local polity, ordinamento locale, comunità dove esperienza concreta e partecipazione politica contano più del resto. Il populismo evocato da Lind vuole eliminare la prima, mentre gran parte dell’establishment liberale e progressista non si preoccupa, e spesso detesta, la seconda. Invece, va trovato un punto di equilibrio tra l’autonomia del locale e l’eteronomia del globale.
RAV: Se le contraddizioni in seno al campo progressista sono evidenti, a me pare che in Europa esista anche una evidente contraddizione nel campo populista, tra la tentazione statalista del sovranismo e il suo rigetto delle élite manageriali che sarebbero inevitabilmente chiamate a governare. Questa contraddizione è probabilmente meno evidente nel contesto americano, dove il conservatorismo si associa al liberalismo o persino al libertarianesimo. Ad esempio, Lind non è certo un nemico del mercato, bensì critica il neoliberalismo in quanto progetto tecnocratico “calato dall’alto”: il prefisso neo-, più che completare, emenda il liberalismo che lo segue, descrivendo di fatto secondo Lind un progetto di pianificazione portato dalla burocrazia. L’impiego del concetto di neoliberalismo contribuisce così a una vera e propria ambiguità interpretativa, un “significante vago” tipicamente populista nel quale possono convergere sia il malcontento di destra che quello di sinistra. L’esistenza di tutte queste contraddizioni ci mostra quanto rapidamente si stanno muovendo le placche tettoniche dell’ideologia, avvicinando tra loro cose che prima erano molto lontane.
Lorenzo Castellani: Il libro di Michael Lind è importante per il contesto politico-culturale che stiamo vivendo, perché mi pare teorizzi e consolidi una posizione che si è sempre di più ben definita negli ultimi anni, quella del ritorno delle categorie marxiste nell’analisi sociale, declinate in chiave identitaria e conservatrice…
Raffaele Alberto Ventura: Secondo Lind e contrariamente a Marx, le due classi in lotta non sono borghesi e proletari, ovvero chi ha tutto contro chi non ha niente, ma proprietari vs. dirigenti, professionisti, competenti; insomma, chi possiede il capitale economico contro chi possiede il capitale culturale. Non è una differenza da poco. In effetti si parla molto, da qualche anno, di un marxismo di destra. Innanzitutto per lo spostamento di alcuni intellettuali di sinistra verso il nazionalismo o il sovranismo, laddove le conversioni eclatanti degli anni 1970-1990 erano perlopiù in direzione del liberalismo: e questo è già un evidente segno dei tempi. Il “margine di manovra” politico sembra essersi spostato, come se di fronte alla crisi del capitalismo occidentale si sia tentato in un primo tempo di “aprire tutto” e in un secondo tempo di fare esattamente il contrario.
Ancor più vistoso tuttavia è il fenomeno di assorbimento di alcune categorie del discorso di sinistra da parte della destra: l’insistenza sulle classi sociali, la critica del capitalismo, lo stesso riferimento esplicito a Marx, elementi che ormai troviamo tranquillamente nel discorso di alcuni sostenitori di Trump e persino di Salvini. Precorritrice fu in Francia la Nouvelle Droite di Alain de Benoist, grande macchina di riciclaggio e recuperazione che ha indicato una via poi percorsa anche dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Ma su questi sconfinamenti bisogna intendersi: il “marxismo” di cui si parla, a destra come a sinistra, è ormai una pallida fotocopia di una fotocopia del materialismo dialettico, una specie di “cargo cult” nel quale permangono soltanto alcune parole e dei tic linguistici. Oggi destra e sinistra si contendono quell’eredità, adattandola ai tempi e quindi inevitabilmente deformandola.
È davvero marxista la nuova sinistra statalista, keynesiana, tecnocratica, neo-positivista, come dicevi sopra? O è marxista Lind quando rilegge la lotta di classe relegando il proletariato a un ruolo secondario? Raymond Aron denunciava un “marxismo immaginario” fin dagli anni Sessanta, e questo significa che abbiamo oggi a che fare con la terza, quarta o persino quinta generazione di marxisti immaginari, che hanno studiato con altri marxisti immaginari, che a loro volta hanno studiato con dei marxisti immaginari. Cosa rimane di Marx? Un trofeo da rivendicare, innanzitutto, prova che si tratta ormai di un riferimento trasversale, e in quanto trasversale, molto malleabile. Diceva il teologo Alano di Lilla: “L’autorità ha un naso di cera che può essere deformato come si vuole”. Nel caso di Lind possiamo parlare di un marxismo conservatore solo in senso lato, ma di certo il fatto che ne parliamo in questo modo ci dice molto su come si sono modificati i rapporti di forza nel dibattito pubblico dell’ultimo decennio. Sottraendo il riferimento a Marx alla sinistra, in un certo senso “svuotandolo”, la destra si è assegnata un incredibile vantaggio competitivo. In questo gioco di appropriazioni, recuperi, reimpieghi, dirottamenti e malintesi, sarà interessante vedere se la sinistra saprà appropriarsi delle tesi sulla crisi della tecnocrazia o se le rigetterà rompendo con un pezzo essenziale della sua stessa tradizione. O la prossima rivoluzione sarà irrimediabilmente populista e di destra?
Lorenzo Castellani: Non so quanto la mancata critica della tecnocrazia a sinistra sia davvero un pezzo essenziale della sua tradizione. Come tu stesso sottolineavi, le prime critiche contro “la nuova classe” vengono da dissidenti comunisti e socialisti, ma non tanto nei confronti di altri partiti, quanto verso il proprio. Ciò forse perché l’elemento pedagogico e dirigista, dunque inevitabilmente burocratico, è un connotato che da un secolo fa parte del patrimonio della sinistra stessa. Nonostante il contributo del pensiero di Foucault nella critica al potere, il richiamo ancestrale di questo tipo di mentalità dirigista sembra prevalere. Oggi il mondo progressista conta molto sulla tecnocrazia per far avanzare le proprie idee sulla identity politics, per ridisegnare i canoni dell’etica e della scienza, e più tradizionalmente per progettare politiche sociali.
Su questo forse Michael Lind non si sofferma abbastanza, poiché l’ordine tecnocratico non è soltanto una forma di dirigismo economico, di combinazione tra vertici burocratici e capitalismo oligarchico, ma per i progressisti è anche un dispositivo per creare una certa forma di società. La rottura nei confronti della tradizione, e del potere residuo che da essa promana, viene infatti cercata da sinistra proprio attraverso il mezzo della tecnocrazia. Sono i competenti a guidare non soltanto le politiche economiche, ma anche l’emancipazione degli individui dai legami tradizionali, a pilotare la transizione verso un nuovo egualitarismo che fa spazio alle minoranze (si pensi al potere di stabilire quote rosa, quote etniche, in ogni forma di reclutamento, di imporre l’utilizzo di un certo linguaggio all’interno delle istituzioni e così via). Emerge così il paradosso per cui la liberazione dalle “catene della tradizione” avviene proprio attraverso la gabbia d’acciaio.
Ma quanto è sostenibile politicamente questo atteggiamento in società democratiche e pluraliste? Ha senso voler imporre dall’alto, cioè tramite le istituzioni, la liberazione dalla tradizione per sostituirla con un preciso modello di vita, di diritto e di linguaggio o è un esercizio vano e pericoloso di ingegneria sociale? Questa artificialità non rischia forse di suscitare discriminazioni inverse e di sollecitare gli istinti peggiori delle cosiddetta maggioranza? Ad ogni modo, fino a che questo pensiero resterà dominante avremo una divisione inevitabile tra una sinistra manageriale e tecnocratica e una destra populista e nazionalista.
Ciò non significa, ovviamente, che non ci possano essere riallineamenti in futuro. Potrebbe emergere, ad esempio, una sinistra neo-autonomista e socialista e di conseguenza, per reazione, una destra conservatrice e oligarchica. Oppure potrebbero nascere degli esperimenti capaci di mescolare, smussando gli angoli, l’ethos tecnocratico con il nazionalismo (e forse Macron è già oggi qualcosa di simile). Da ultimo, non sovrastimerei eccessivamente la presunta carica rivoluzionaria del populismo. In fin dei conti, questo pare fondato sulla nostalgia più che sull’utopia. Si può fare una qualche rivoluzione in nome della nostalgia? Al massimo si può frenare più che cambiare tutto.
Ciò che è preoccupante, semmai, è che tanto la tecnocrazia quanto il populismo sono avversi al pluralismo, alla moderazione, alla mediazione e, in definitiva, al liberalismo profondo su cui poggia il nostro contratto sociale. Per quanto usurato, indebolito, precario, il patto del costituzionalismo è ancora il perno della nostra libertà e della nostra politica. Tecnocrazia e populismo, invece, sono due visioni antipolitiche, dunque rischiose e pericolose. Poiché dietro ogni tentativo di annullare la politica come processo di discussione si nasconde un pericolo dispotico.
RAV: Per finire, dovremmo forse dire qualcosa sul rischio, a forza di criticare la competenza, di “buttare il bambino con l’acqua sporca”. È chiaro che la prosperità e la sicurezza, di cui hanno goduto le economie occidentali per decenni, dipendono dagli investimenti educativi e dalla divisione del lavoro cognitivo. Meno chiaro è se questo meccanismo virtuoso sia sostenibile sul lunghissimo termine. Lind ci mostra gli indizi di un’erosione del rendimento sociale delle élite. I machiavellians citati in epigrafe all’inizio della Nuova lotta di classe – ovvero gli italiani Pareto, Mosca e Michels – ci insegnano che non possiamo rinunciare alle élite, ma la reazione populista suggerisce che nel loro rapporto con la società qualcosa, a un certo punto, si è rotto. Saremo in grado di ripararlo? Questa è la grande domanda.
Lorenzo Castellani: Possiamo andare verso una società della competenza sostenibile? È possibile, ma prima è necessario rendersi conto che qualsiasi tentativo di neutralizzare la conflittualità tra gruppi, anche con i mezzi tecnici più avanzati, è destinato a scontrarsi con il sottosuolo della politica, con le pulsioni e l’irrazionalità dell’uomo, con i limiti conoscitivi dell’individuo, e con la pluralità di interessi, passioni, ragionamenti che scuotono la vita associata degli esseri umani. La politica resta un processo di discussione, e la discussione richiede sempre, nel senso greco del termine, una certa dialettica.
Per questo servono nuovi “miti” o, se si preferisce un termine più laico, nuove “finzioni” della politica di cui discutere. Abbiamo cioè bisogno di idee e mezzi per evitare gli scollamenti, le paranoie e i frazionamenti della società della competenza. Questo processo non deve avvenire necessariamente tornando indietro, rievocando il mito della “vecchia” democrazia rappresentativa e della sovranità nazionale, ma al contrario guardando avanti con realismo e consapevolezza. Viviamo in una gabbia di acciaio fatta di tecniche, di capitale, di amministrazione che, almeno ad oggi, non sappiamo come aprire, ma quale sistema della libertà possiamo ricavare all’interno di questo perimetro per evitare che le maglie di questa gabbia soffochino individui e comunità? Questa potrebbe essere la domanda a cui rispondere e che ci viene posta da libri come La nuova lotta di classe.

