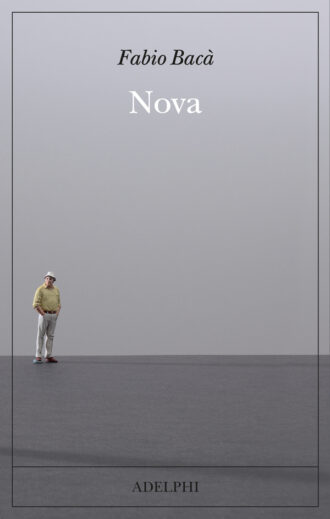Nova
Fino a sabato, pubblichiamo ogni giorno in anteprima brani tratti dai cinque romanzi finalisti del Premio Grand Continent, che saranno presentati domenica 18 dicembre a 3466 metri, nel cuore del massiccio del Monte Bianco. Oggi, vi proponiamo alcuni estratti del romanzo Nova di Fabio Bacá, un intreccio moderno in cui le certezze cerebrali di un neurochirurgo lucchese vengono sconvolte una dopo l'altra — fino alla catastrofe.
PROLOGO
« … prendi Kabobo. Te lo ricordi Kabobo? È successo a Milano, tre o quattro anni fa. Esatto. Il pazzo con il piccone. Il ghanese che uccise tre poveracci incontrati per caso a Niguarda. Sì. Proprio lui. Il clandestino che disse di aver sentito delle voci nella testa e se ne andò in giro a spaccare quelle altrui, e che alla fine si beccò una condanna relativamente mite grazie alle contestatissime attenuanti invocate da uno psichiatra del tribunale. Anche se a me sembra più significativo quello che era accaduto qualche ora prima. Te lo ricordi? Non credo. Ormai l’hanno dimenticato quasi tutti. Un dettaglio indubbiamente subordinato all’enormità del fatto in sé, come no, ma in un certo senso altrettanto emblematico della vicenda di un trentunenne irregolare che trova un piccone in un cantiere incustodito e lo usa per silenziare i mortiferi suggerimenti di una voce nella sua mente. Alle tre di quel mattino, Kabobo aggredisce a mani nude due persone: nei pressi di piazza Belloveso una ragazza gli sfugge solo perché abita a due passi ed è velocissima ad aprire il portone di casa; mezz’ora dopo, un poveraccio non altrettanto fortunato si becca un cazzotto in faccia. Ora, la cosa strana è che alle autorità non arrivano segnalazioni in proposito. Non è sorprendente? Una coppia di tranquilli cittadini sfugge alle lusinghe potenzialmente fatali di un evidente squilibrato, ma nessuno dei due spende mezzo minuto per una telefonata alla polizia. Tra le cinque e le sei Kabobo si procura una spranga e ferisce seriamente due passanti. Ne insegue un terzo che porta a spasso il cane, ma quello si mette a correre, e il nostro rinuncia a inseguirlo dopo pochi passi. E indovina un po’? Anche qui nessuno si sogna di denunciare l’accaduto alle autorità. Uno dei due sprangati si fa addirittura medicare il braccio al pronto soccorso, ma ai medici fornisce spiegazioni vaghe: né ho idea del perché questi ultimi abbiano trascurato di avvertire le autorità come avrebbero imposto sia la legge che il codice deontologico. A quel punto Kabobo ha già rinvenuto lo strumento che darà un contributo esponenziale all’efferatezza delle imprese successive. Ebbene, non so se riesci a immaginare il polverone alzato dalla stampa entro le ventiquattro ore successive. Cinque aggrediti, zero segnalazioni: cinque potenziali strangolati o sprangati a morte, ma non una sola chiamata giunta ai centralini di carabinieri o polizia. A seguire, il solito plotone di sociologi, psicoanalisti, filosofi e sobillatori di professione che somministra al pubblico interpretazioni autorevoli: l’egoismo epidemico, l’autismo emozionale, il crollo di valori come civismo, empatia e solidarietà. Tutte opinioni sensate, certo. Ma io ti dico che c’è di più. Qualcosa che non ha molto a che fare con la logica elementare o l’erosione del senso di umana pietà. Io credo che la maggior parte delle persone non sia preparata a un evento psichicamente traumatico come un’aggressione brutale. Considerata la società in cui viviamo, è assolutamente probabile che un occidentale tipico si predisponga all’eventualità di subire un qualche tipo di violenza: ma ti assicuro che tra la presa d’atto di un fatto spiacevole e la sua metabolizzazione emotiva c’è un abisso. Sono pronto a scommettere che nessuna delle persone scampate alla furia di Kabobo avesse avuto esperienza dell’aggressività tanto da identificarla e gestirla a un livello razionale più profondo. No, non sto dicendo che la sensibilità del cittadino medio sia diventata impermeabile alle conseguenze interiori di una tentata picconata; detta così, sembrerebbe che il problema sia l’indifferenza. No. Io sostengo una cosa ben diversa, ossia che per quasi tutti noi la violenza è un fatto emotivamente alieno. Non è che il cittadino medio sia diventato immune ai contraccolpi psichici di un agguato: è che non riesce a stabilire un collegamento produttivo tra
l’impatto razionale e le inferenze emotive che tale impatto innesca. La parola fondamentale, qui, è “produttivo”. Il problema è che abbiamo perso contatto con qualcosa di essenziale dentro di noi. Pensaci un attimo. Com’è possibile che una ragazza scampata a un pazzoide sotto casa non sia in grado di intuire che l’assalitore potrebbe scegliere la prossima vittima tra le persone che conosce in quella stessa via? Come può non barattare il fastidio di una telefonata al 112 con il sollievo di aver rimosso un pericolo mortale dal quartiere in cui vive? Che poi è lo stesso in cui vivono i genitori, magari – o i suoi amici, o il ragazzo che le piace?
Come fa a ignorare che la mattina dopo potrebbe aprire la finestra e spalancare gli occhi davanti a un mucchio di segatura sul marciapiede con i residui mezzo assorbiti di sangue
e fluidi cerebrali di un innocente?
« Come credi che reagirebbe, se accadesse?
« E tu?
« Fatti questa domanda, dottore.
« Come reagiresti, tu? ».
1
A cosa pensa un uomo appena si sveglia? Cosa gli recapita la connivenza d’inconscio e realtà? Qual è l’oggetto delle sue prime, confuse meditazioni mentre tenta di recuperare la potestà sul vero? Quali le immagini, i suoni, i bisbigli, i tumulti nella sua testa?
Probabilmente riflette su di sé, o sulla donna che gli dorme accanto.
Forse pensa ai figli. Oppure ai genitori, all’amante, alla colazione, a un amico in difficoltà, alle scadenze fiscali, alla cena di gruppo del sabato successivo, al mal di schiena, alla politica, ai contrattempi professionali, alla macchina nuova in leasing che gli ha proposto il suo concessionario, a Dio, ai gol della sera prima, alla casa in campagna, alle vecchie ambizioni arenatesi chissà dove, alle caviglie di una collega, ai film di Christopher Nolan, alla mozione di coito avanzata dalla fugace libidine dell’erezione mattutina.
Davide no.
Davide pensa alla morte.
Succede poco dopo le sei. Apre gli occhi, recupera il minimo di nitore intellettivo necessario ad affrontare la prospettiva del nulla eterno, e si mette a fissare il soffitto. No, non è pazzo.
Non è gravemente malato.
E non è nemmeno depresso.
Sì, certo. Ha qualche difficoltà con il suo diretto superiore, il dottor Martinelli, principe della medicina toscana, virtuoso della neurochirurgia, che da un po’ di tempo sembra averlo preso di mira.
E sì, ha più di un problema con il suo vicino, Massimo Lenci, proprietario del locale notturno che per più di un anno ha turbato la pace del tranquillo quartiere in cui vive, alla periferia meridionale di Lucca, prima che una salvifica ingiunzione comunale intervenisse a ristabilire la quiete.
Nulla d’irrimediabile, certo. Nulla che di per sé lo inserisca nella schiera dei perennemente afflitti, dei tanatofili o degli aspiranti suicidi.
Eppure, Davide pensa alla morte.
Considera il tutto una specie di rituale, un antidoto ai periodi complicati che assume periodicamente da più di quindici anni. Apre gli occhi, fissa il soffitto di legno e riflette sulle implicazioni della fine della vita.
Non necessariamente della sua, in realtà. E spesso non pensa nemmeno più alla morte intesa come termine delle esperienze terrene di un vivente. Sdraiato accanto a sua moglie, apre gli occhi, prende coscienza di sé, del crepitio soffuso delle travi al calore del sole, del respiro vagamente adenoideo che giunge dal lato opposto del letto: quindi comincia a meditare sulla cessazione delle funzioni primarie e accessorie di organismi viventi, sociali, meccanici o virtuali di qualunque tipo.
Ha cominciato poco dopo la nascita di Tommaso. Negli anni seguenti, avrebbe concluso che riflettere sulla morte era il logico contrappeso all’eclatante sovrappiù di vita che la cura di un piccolo e frignante essere umano dalle inconcepibili esigenze aveva imposto alla tranquillità quotidiana di una giovane coppia di professionisti. Un cane, due gatti e un bambino: ce n’era abbastanza da giustificare un primo risveglio dedicato alla rassicurante prospettiva del
riposo eterno.
Il cane, per inciso, era un Jack Russell di nome Fred Flintstone. I gatti, Epaminonda e Kociss, due fratellini tigrati e ombrosi, poco inclini a condividere l’entusiastica ipercinesia di Fred: lo osservavano con aria circospetta da angoli sopraelevati del soggiorno, e ogni tanto lo circondavano, in cucina o in corridoio, imponendogli i piccoli, umilianti tributi che il sadismo connaturato alla specie pretende.
Ma se gli animali erano una panacea intermittente o disattivabile all’eccesso di requie domestica – c’era sempre un giardino in cui confinarli quando scaramucce, guaiti, miagolii o incursioni sul divano eccedevano il limite – un neonato era onnipresente. Infondeva alla casa un senso di attesa messianica: dei suoi risvegli, del suo umore, della sua fame, della sua digestione, della quantità o qualità delle sue deiezioni, dei suoi segnali di soddisfazione o malessere. Confinato nello studio al piano superiore della villetta, Davide cercava di tirare le fila di un semestre di perfezionamento al Guy’s Hospital di Londra. Era tornato in tempo per assistere al parto, ma sospettava che la sequela di notti insonni accluse alle gioie della paternità avrebbe compromesso la possibilità di trarre un minimo profitto dalla sua esperienza londinese.
Di notte dormiva pochissimo: di giorno posava la fronte sui libri, sonnecchiava sulle poltroncine in facoltà o vagava tra i corridoi, in una polla di perenne ottundimento. A fine estate sarebbe entrato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Campo di Marte, ma a quel punto dubitava di uscire vivo dalle sue prime dieci settimane da genitore.
Gli unici minuti di pace coincidevano proprio con il primo risveglio. Ne approfittava per cominciare a riflettere sugli insospettabili vantaggi della mortalità. Le allettanti lusinghe dell’estinzione, termine misericordioso di ogni affanno. La grevità incantata dell’espressione « sonno eterno » (il meraviglioso evocato del sostantivo, soprattutto).
L’apologia della fuga, della rinuncia, dell’abbandono.
Non era credente, ma ogni tanto si era ritrovato persino a fantasticare sulla serena ascensione post mortem al flusso di anime che sovrintende, con qualche giustificata perplessità, all’evoluzione del mondo.
Il sollievo di quei minuti di riflessioni fu tale da persuaderlo a continuare anche dopo il ripristino di condizioni di vita accettabili. Scoprì di non detestare poi così tanto il bambino, che almeno gli aveva permesso di accedere a una visione consolante dell’apparente dualismo vita/morte.
Dalle riflessioni sulla sua fine passò a quella dei congiunti più prossimi – infante compreso. Poi dei parenti lontani. Poi degli amici. Poi dei suoi animali. Poi dei colleghi.
Poi dei pazienti che visitava in ospedale e degli sconosciuti che incontrava per caso. Infine si dedicò ai divi del cinema, alle stelle della musica e dello sport.
Nulla di particolarmente cruento: di solito immaginava lente e serene uscite di scena nell’abbraccio consolante dei propri cari.
In seguito si dedicò alla fine delle istituzioni politiche (l’estenuante dissolvimento dell’Impero romano d’Occidente, la brusca ablazione dalla storia dei Romanov o dei Borbone-Orléans), a quella delle macchine, delle mode, dei cliché lessicali.
Non seguiva una strategia, o una programmazione. Si svegliava e lavorava sulla prima cosa che gli saltava in mente.
Dopo un po’ si era addirittura convinto di proiettare una specie di benevolo influsso apotropaico sul morente di turno.
Il gioco era proseguito per poco più di sei mesi, dopodi ché i suoi pensieri mattutini erano stati requisiti da considerazioni più urgenti. Ma negli anni successivi, in mezzo a qualche inevitabile tempesta, avrebbe di nuovo tratto conforto da quello strano vezzo, dai pochi minuti tra le lenzuola passati a fissare il soffitto meditando sulla pace eterna.
La fine di ogni problema.
Barbara dormiva su un fianco, dandogli le spalle. Al solito la gamba sinistra si era sovrapposta alla sua, ancorandogli la caviglia al materasso come per impedirgli di levitare
durante la notte.
Epaminonda sonnecchiava sul comò. A ulteriore conferma delle virtù propiziatorie delle sue riflessioni, gli animali di casa avevano trionfalmente superato i sedici anni di età.
Quella mattina Davide avrebbe rimosso un glioma dal cervello di una ragazza, quindi spese doverosamente qualche minuto a riflettere sulla morte delle cellule di Schwann.
A un tratto qualcosa attirò la sua attenzione. Un grosso insetto nero, una specie di scarabeo goffo e lucido, era sbucato da sotto l’armadio. Lo fissò, senza troppa sorpresa: la portafinestra della camera, che si apriva sul giardino, era una fonte inesauribile d’incursioni animali.
Spostò lo sguardo su Epaminonda. Il gatto aveva già aperto gli occhi, allertato dall’udito, dall’olfatto, dall’istinto felino.
Sollevò la testolina e fissò l’intruso che zampettava con commovente determinazione sul parquet. L’uomo si preparò a un’appendice imprevista delle sue riflessioni: dalla fine dignitosa di una cellula alla morte cruenta di un grosso insetto.
Ma Epaminonda si era predisposto di nuovo al sonno.
Entro dieci minuti il suo padrone si sarebbe alzato per riempirgli la scodella: perché darsi da fare per qualcosa di visibilmente meno appetitoso?
Per almeno un decennio, Epaminonda era stato il più feroce e temerario tra i gatti del quartiere. Occhi color topazio, andatura sinistra, riflessi portentosi. Si arrampicava sulle tende, si dondolava dai lampadari, prendeva il sole in equilibrio precario sui bovindi di casa, saltava tra i tetti per accurate ricognizioni aeree del suo territorio, ingaggiava zuffe epocali con i gatti del vicino per vane questioni di supremazia sessuale – i contendenti erano tutti sterilizzati.
Nella bella stagione integrava la dieta con supplementi entomologici di equanime varietà: grilli, api, farfalle, mosche, scarabei, cicale. Era uno sterminatore seriale, un genocida a quattro zampe, uno strumento di controllo demografico dell’ecosistema faunistico di mezzo quartiere.
E ora, invece? Ora si preparava a trascorrere l’ultima parte della sua esistenza all’ombra del più pigro e rilassato laissez-vivre : aveva raggiunto la giudiziosa oculatezza della senilità, l’assenza di spreco che misura le dimensioni della più ponderata saggezza.
Beato lui, pensava Davide.
Più tardi Barbara lo raggiunse in cucina, a piedi nudi.
« Non toccava a me fare il caffè? » gli domandò.
« Ero già sveglio da un po’ ».
Lei si mise a esaminare qualcosa sul soffitto, grattandosi un seno, poi andò a sedersi sullo sgabello della penisola.
Qui mise in opera un consumato gioco di caviglie e talloni per tenere a bada Epaminonda, che tentava di strusciarsi ai suoi polpacci.
« Tommaso è già sveglio? » domandò.
« Credo di sì. È da un po’ che sento armeggiare ».
« Prima che me ne dimentichi, tesoro. Ieri mattina è arrivata la lettera di un avvocato ».
« Avvocato di chi? ».
« Indovina ».
Davide posò la caffettiera sul piano a induzione.
Lei si passò le mani ai lati della testa, raccolse i capelli in una coda e la legò con un elastico rosso che le era spuntato tra le dita. Fred Flintstone, acquattato sul tappeto della cucina, la guardava attentamente. In una percentuale non trascurabile di casi, la sua padrona si sistemava i capelli quando doveva occuparsi di lui in modi meno ordinari di cibo o coccole. Tipo fargli il bagno, o portarlo dal veterinario.
« Perché fai quella faccia? » chiese Barbara. « Ha detto che avremmo avuto altre notizie dai suoi legali ed è stato di parola. Apprezziamone la coerenza, almeno, considerato che non c’è molto altro da apprezzare ».
« E che dice quest’avvocato? ».
« Niente di preoccupante. In pratica, diffida il nostro dal continuare a diffidare il suo assistito ».
Davide si avvicinò al frigo, lo aprì e ne studiò il contenuto.
Prese un cartone di latte d’avena e un barattolo di marmellata.
Posò il secondo sulla penisola. Riempì di latte una scodella di ceramica, e prima di deporla accanto alla marmellata la annusò. Poi si girò, aprì lo sportello sinistro della credenza e ne estrasse una confezione di fette biscottate.
« Ho già mandato tutto a Paolo » disse Barbara.
« Hai fatto bene ».
In quel momento dalle scale apparve Tommaso, seguito silenziosamente da Kociss. Non lo perdeva mai di vista, sollecito e discreto come l’attendente di un generalissimo sudamericano.
« Ehilà » disse Tommaso.
« Ciao tesoro » gli rispose Barbara.
« Ti ho versato un po’ di latte d’avena » disse Davide.
Tommaso aprì la tasca superiore dello zaino, trovò il cellulare, sfiorò lo schermo e si mise ad analizzare le conseguenze del suo diteggiare sfoggiando il repertorio di microespressioni insoddisfatte che esibiva da un po’. Quindi si avvicinò alla penisola, si sedette e posò il telefono accanto alla scodella, infilando le dita nella confezione aperta di fette biscottate.
« Non ti lavi le mani? » disse Barbara.
« Ho appena fatto di sopra » rispose Tommaso. Poi allungò un braccio, prese il barattolo di marmellata, ne controllò l’etichetta e lo rimise dov’era.
« Dove vai oggi? » gli chiese Davide.
« A casa di Marco » rispose lui, inzuppando una fetta biscottata nel latte. « Con l’autobus » puntualizzò, prevenendo l’arrivo di una probabile istanza paterna di chiarimento.
« Chi c’è con te? » disse Barbara.
« Matteo. Anna. Claudio. Forse il Penna. Francesca. Giorgio. Forse Lenny ».
Barbara scoccò un’occhiata a suo marito. Lenny? chiese, senza emettere suoni. Lui scrollò le spalle, come a dire che aveva rinunciato da un pezzo a investigare le bizzarrie onomastiche della cerchia di Tommaso.
« Posso accompagnarti io » disse. « La villa dei Callipo non è lontana dall’ospedale ».
« Se vuoi ».
« Prendo il caffè, mi vesto e sono pronto ».
« Non ho fretta ».
« Io sì ».
Kociss attendeva ai suoi piedi, seduto sulle zampe posteriori, con aria docile e lievemente immusonita. Aveva un carattere talmente speculare a quello di Epaminonda da rendere la loro consanguineità quasi implausibile. A un tratto spiccò un salto fulmineo, atterrò con un piccolo tonfo sulle cosce del suo padroncino e gli si acquattò sui jeans.
La caffettiera cominciò a gorgogliare.
« Tu che fai a pranzo? » domandò Davide a Barbara.
« Non lo so. Perché? ».
« Mi piacerebbe provare quel ristorantino in viale Puccini di cui parlano tutti benissimo. Mi raggiungi lì? Qualcosa che ti piace lo troviamo ».
« Perché no? ».
Poi si rivolse a Tommaso.
« Vieni anche tu, tesoro? ».
« Non lo so » disse lui. « A che ora sarebbe? ».
« Dipende da tua madre. Per me dopo l’una va bene ».
« Nel pomeriggio devo passare dai miei » disse Barbara.
« Ma ho detto a mamma per le tre e mezza. Tempo sufficiente per un pranzo di nozze ».
« E pranzo di nozze sia ».
Mezz’ora dopo, Davide e Tommaso salirono a bordo della BMW. Il cancello elettrico scivolò sulla rotaia con un sussurro un po’ meno leggiadro del solito. Davide diede un’occhiata alla facciata della villetta: Barbara aveva pronosticato che entro fine anno avrebbero dovuto sottoporla a una blanda manutenzione, ma il cigolio del cancello sembrava vaticinare l’imminenza di un intervento conservativo più generalizzato e costoso. A quanto ne sapeva Davide, la casa, di due piani, era stata la prima in tutta Lucca realizzata completamente in legno. Meno di una settimana dopo aver scoperto di essere incinta, infatti, Barbara aveva trascinato suo marito da una società di edilizia alternativa. Avevano consultato cataloghi di case prefabbricate: lussuose, ecosostenibili, dotate di ogni confort, ma senza il fardello dei sensi di colpa da eccesso di capricci esauditi a spese del pianeta. Sulle pubblicazioni in patinata lucida si stagliava imperioso l’acronimo NZEB, Nearly Zero Emission Building. Loquace e fidente, Barbara memorizzava ogni dettaglio. Davide sbatteva le palpebre, a braccia conserte, nella diffidenza dell’uomo di scienza davanti al sovvertimento di precetti inveterati.
L’idea di andare a vivere in una casa di legno, come il sopravvissuto a una calamità naturale, lo atterriva.
Appena sposati si erano sistemati a casa dei suoi, al piano superiore di una cupa dimora sulle colline a nordest della città. Poi avevano concepito Tommaso, e Barbara aveva preteso, con volitiva dolcezza, di affrancarsi dalla tutela dei suoceri e stabilirsi in un appartamentino in centro.
Non era solo la tetraggine dell’architettura a turbarla: da qualche tempo l’armonia familiare era scossa dallo scontro ideologico in atto tra Davide e suo padre – anch’egli neurochirurgo – il cui pretesto edipico era stata l’epocale diatriba tra localizzazionisti e plasticisti.
Barbara aveva appena cominciato a occuparsi di logopedia, materia il cui interesse per la comprensione approfondita dei meccanismi cerebrali era poco meno che accessorio: non c’era bisogno di una teoria unificata della neurologia per insegnare a un bambino come eliminare un difetto di pronuncia. Ma aveva letto Sacks, e qualcosa di Kandel, e voleva capire se la voragine dottrinale tra marito e suocero fosse davvero incolmabile.
Una sera Davide guardava distrattamente la TV. Lei si avvicinò e gli chiese di chiarirle il problema.
« Be’, i primi studiosi credevano che ogni funzione fosse localizzata in una determinata zona del cervello, fissa e immutabile » le spiegò lui, stirandosi. « Finché si è scoperto che ognuna di quelle zone, se necessario, può surrogare il lavoro delle aree vicine: il cervello è quindi plastico, mutevole, adattativo. Peccato che mio padre faccia ancora spallucce
quando sente certi discorsi ».
« E ti sembra un buon motivo per tenergli il muso? ».
« È lui che lo tiene a me ».
Poco dopo avevano affittato un appartamento al secondo dei tre piani di un edificio in via Sant’Andrea. Al piano superiore c’era una famiglia con quattro figli, a quello inferiore due adorabili anziani: tutti impegnati a saturare di rumore porzioni di giornata così rigorosamente ripartite da sembrare assegnate nel corso di apposite riunioni di condominio. La mattina era il turno dei programmi più desolanti del panorama televisivo nazionale, di cui i vecchietti erano appassionati esegeti. Il pomeriggio era invaso dalle grida dei bimbi al piano superiore, appassionatamente coadiuvati dal saltellante cucciolo di famiglia: un grosso cocker spaniel color miele, tonto e sovreccitato, che in deroga alle ripartizioni condominiali latrava o uggiolava a qualunque ora del giorno.
Davide e Barbara avevano resistito fino all’autunno del secondo anno. In estate, Barbara aveva ereditato dai nonni un piccolo terreno in via Tofanelli, a sud delle mura. Ed era stata lei, dopo alcuni sopralluoghi, a proporre a Davide di costruirci una casa in legno.
In legno, sì: aveva capito bene. Ma con soluzioni tecniche innovative e un impatto energetico irrisorio.
Un amico architetto, affiliato a una misteriosa congrega di utopisti della bioedilizia, aveva già abbozzato un progetto: due piani, il porticato inferiore foderato di glicine, una Jacuzzi per quattro sul lastrico solare. E gli abitanti delle case intorno? Tenuti a distanza da un giardino di salici e ulivi, pietre nere e trifogli, al punto da destituire quasi completamente di senso il termine « vicini di casa ».
Altro che cocker, bimbi irrequieti e telequiz.
Alla fine Davide aveva detto di sì, anche se a malincuore.
A che serviva diventare un professionista da centomila euro l’anno se doveva vivere in una specie di palafitta come un indigeno degli arcipelaghi polinesiani?
Tommaso estrasse una dispensa ciclostilata dallo zaino che teneva tra i piedi.
« Cos’è? » chiese Davide.
« Appunti » rispose lui. « Per una ricerca che abbiamo consegnato sabato ».
« Credevo che la scuola fosse finita ».
« Finisce dopodomani ».
« In tempo per il grande evento. Sei carico? ».
« Non lo so. Dovrei? ».
Erano fermi a un semaforo e Davide gli lanciò un’occhiata.
Suo figlio era impegnato a grattare via qualcosa dalla pelle color champagne della porzione di sedile sotto la sua coscia: un ragazzo timido, fenomenale a scuola, appassionato di astronomia, che stava lentamente emergendo da un periodo complicato dopo un trascurabile episodio di pseudosovversione giovanile – una delle tante, esili ordalie che cadenzano lo sviluppo di un adolescente occidentale.
« Alla tua età » gli disse « non ci avrei dormito la notte. Gli Aerosmith. Ti rendi conto? ».
« Dormo già abbastanza male, grazie ».
« “Rolling Stone” li ha inseriti al cinquantanovesimo posto dei cento migliori artisti di sempre ».
« Solo al cinquantanovesimo? ».
« D’accordo. Ma Steven Tyler è stato votato icona musicale di tutti i tempi. Di tutti i tempi. Più di Elvis. Di Freddie Mercury. Di Bono Vox. Di John Lennon ».
« Chi è Elvis? ».
Davide lo fissò, vagamente perplesso. Tommaso era in quella fase della vita in cui sembra evidente che l’unico modo di contenere l’incremento di pretese di cui gli adulti diventano famelici latori, appena ratificano che la tua infanzia è terminata, è opporre disinteresse a ogni questione apertamente secondaria. Fase che a Davide non era capitato di sperimentare: per tutta la giovinezza non aveva fatto altro che accogliere con gratitudine ogni stimolo possibile.
Ancora ricordava lo sgomento nell’apprendere, giovane matricola, una di quelle informazioni inverificabili che per qualche giorno sono fonte di una meravigliata repulsione tra gli studenti del primo anno: il mondo che percepiamo è un’illusione, aveva detto il professore di embriologia.
I fiori, gli alberi, il cielo, le nuvole, gli oceani, le case, le auto, i libri, gli animali, il viso dei genitori o della donna amata non sono veri : o almeno, non nella forma che riteniamo essere tale. Il mondo è un’architettura cinerea e silenziosa di molecole prive di colore, odore, sapore e temperatura, da cui ogni cervello umano plasma la sua realtà attraverso potenziali elettrici deputati a creare sensazioni completamente diverse dalla livida e concreta sostanza dei fatti.
La BMW si era inerpicata lungo una breve salita. A metà di un lungo muro di mattoni videro una cancellata.
« Ci vediamo al ristorante » disse Davide mentre Tommaso apriva la portiera. « Viale Puccini, civico 1524 ».
« Civico 1524 è il nome? ».
« No. È il civico ».
« E il nome? ».
« Non me lo ricordo ».
Tommaso si issò lo zaino sulla spalla sinistra. Davide lo osservò procedere verso il cancello, lievemente ingobbito, come ancora intorpidito dalle recenti mutazioni del suo corpo. Un piccolo intoppo nei suoi sincronismi ormonali aveva ritardato di un anno l’avvio della maturità sessuale, con il suo imbarazzante corredo di baffetti, dolori articolari, ptosi del timbro vocale, fitte ai testicoli e acute esalazioni androgene da ogni confluenza di arti. Dalla fine di quell’esperienza Tommaso intratteneva una relazione estremamente cauta e formale con se stesso, come temesse altre spiacevoli sorprese.
Cinque minuti dopo Davide arrivò nel parcheggio riservato dell’ospedale.
L’auto di Martinelli non c’era.
Meglio così, si disse. Spense il motore e alzò gli occhi sulla facciata.
All’apice della scalinata una porta circolare orbitava pigra su se stessa: da quando lavorava a Campo di Marte, Davide non aveva mai visto interrompersi la sua torpida rivoluzione.
Prese la borsa e uscì dall’auto.
A partire da una determinata disposizione d’animo, pensò, qualunque simbolismo risuona come un lugubre rintocco nelle segrete del nostro spirito.
Il primo premio letterario che riconosce, ogni anno, una grande narrazione europea.
————————————-
31
Trovò una vecchia camicia di ricambio nell’armadietto dello spogliatoio. Si sfilò con cautela la maglietta e controllò la fasciatura. Poi si vestì, si pettinò e uscì per raggiungere l’ufficio.
Aggirò la scrivania e si lasciò cadere sulla sedia.
Piegò ad angolo retto le braccia, le posò sul tavolo e adagiò la fronte sul polso della mano sinistra. Chiuse gli occhi per un paio di minuti. La testa continuava a inviargli piccoli segnali di protesta. Non aveva idea di dove fosse il suo cellulare, e non era abbastanza lucido da scovare una modalità alternativa per recuperare il numero di Diego.
In quel momento squillò il telefono.
« Ho sentito pronto soccorso, chirurgia e terapia intensiva » disse Lucio. « Il tuo amico non c’è. Forse è al San Luca, o al Cisanello ».
Davide chiamò il centralino e si fece passare il primo ospedale. Chiese di parlare con chirurgia, e una voce femminile gli passò il reparto. Al quindicesimo squillo non aveva ancora risposto nessuno. La chiamata rimbalzò al centralino. La ragazza disse laconicamente che dovevano essere tutti molto occupati.
« Immagino » commentò lui.
Ripeté la procedura con il Cisanello di Pisa e stavolta chirurgia rispose. Il dottore disse che l’unico con ferite da taglio arrivato nelle ventiquattr’ore precedenti era un barista che si era affettato due falangi la sera prima: quasi tutti i feriti da piazza Napoleone, gli spiegò un po’ pedantemente, avevano le tipiche conseguenze da evento traumatico di massa – ematomi, fratture, schiacciamenti e un paio d’infarti. Ma nessun accoltellato.
Davide riattaccò. Intrecciò le dita davanti alla fronte, chiuse di nuovo gli occhi e si mise a riflettere. Poi afferrò di nuovo la cornetta, e si sorprese a ricordare a memoria il numero di una compagnia di taxi che non usava quasi mai.
Il sole era sorto da poco. Diede un’occhiata al piazzale dal pianerottolo delle scale di servizio.
La folla era imponente. Davanti all’ingresso un gruppo di cameramen, le cineprese in spalla, chiacchieravano in attesa dei collegamenti mattutini con i rispettivi notiziari. Poco lontano, un agente scriveva qualcosa chinato sul cofano di un’auto con i lampeggianti accesi.
Davide scese lentamente fino a uno degli ingressi riservati ai fornitori.
Ancora prima di uscire vide Massimo Lenci. Era seduto sul muretto del giardino, con un mozzicone spento tra le dita e lo sguardo fisso su una porzione di muro priva di apparenti motivi di indagine o interesse.
Davide si immobilizzò sulla soglia.
Massimo si voltò e si accorse di lui. I suoi lineamenti parvero deformarsi in un impeto di sentimenti repressi – la bocca semiaperta, gli occhi socchiusi, il fremito della pappagorgia –, ma erano solo i preparativi di uno sbadiglio che abortì nell’istante in cui capì chi aveva davanti.
Si fissarono senza ostilità. Negli occhi del suo vicino, Da vide intuì le stesse cose che sentiva nei suoi. Stanchezza, afflizione, lo sforzo insostenibile di recuperare il piccolo gregge di certezze disperso nella nebbia di quella notte.
Massimo tornò con lo sguardo all’angolo di muro di poco prima.
« Carlos ha visto ogni cosa » disse. « Mi ha detto che è stato mio figlio a combinare tutto il casino ».
Davide non riuscì a trattenersi dall’annuire.
Massimo rimase in silenzio per un po’.
« Ha cominciato a comportarsi in modo strano quando aveva otto o nove anni » disse alla fine.
Gettò la sigaretta davanti a sé.
« Piccoli atti di autolesionismo, soprattutto. Rubava le mie lamette da barba e ci si tagliuzzava le dita, oppure si bruciacchiava i polpastrelli con i fiammiferi. Poi si è messo a picchiare i compagni di classe, e per picchiare intendo far male, non spintoni e tirate di capelli. Mordeva dita e orecchie, rifilava cazzotti, stringeva colli. Sua madre dava la colpa a me: diceva che era il mio atteggiamento a eccitare il tipico istinto violento maschile. Ma per me, nel comportamento di mio figlio, non c’era quasi niente di tipico. I suoi erano rancori intensi, irrazionali. Era come se per lui il tempo non esistesse: a dodici anni soffriva ancora per i torti subìti dai compagni delle elementari. Alla fine convinsi mia moglie a portarlo da uno psicologo. Ci disse che Giovanni aveva una forma insolitamente grave di… disturbo
oppositivo provocatorio. Mi pare si chiami così ».
Si guardò le mani.
« Dato che il problema peggiore era l’incapacità di gestire la rabbia, diede al ragazzo dei farmaci, e a noi due qualche consiglio per rasserenare il clima domestico. Per un po’ le cose andarono meglio: niente più lamette e fiammiferi, e soprattutto niente botte a scuola. Anche se il prezzo da pagare era vedere mio figlio perennemente intontito dai farmaci. Alla fine di quell’anno sua madre se ne andò di casa per seguire in Australia un allevatore di tori. Giovanni si attaccò a me in modo morboso. Cominciai a portarmelo dietro ovunque. Una sera d’estate mi misi a giocare a carte in un bar con un balordo che conoscevo di vista. Giovanni era in veranda, mezzo addormentato sul dondolo. Io e quel tipo iniziammo a litigare. Non so bene perché. Cominciammo a insultarci, a spintonarci, finché quel bastardo prese la bottiglia e me la spaccò in testa. Il sangue mi colava sulla faccia. Non lo vidi arrivare, mio figlio. E non vidi che aveva in mano un cavatappi ».
Si posò le mani sulla testa.
« Colpì l’uomo alla gola. Lo guardai cadere per terra. Vidi il sangue schizzargli dal collo. Non riesco a dimenticare la sua espressione mentre Giovanni gli montava sul petto e continuava a colpirlo. Alle braccia, alle spalle. Non si sarebbe fermato. Avrebbe continuato fino a ucciderlo. Ci fiondammo in tre su di lui. Prima di riuscire a bloccarlo mi beccai un paio di fendenti alla mano ».
Chiuse gli occhi.
« Risarcire quell’uomo mi è costato quasi tutto quello che avevo. Giovanni lo hanno spedito in una comunità psichiatrica. Sono andato da lui ogni martedì e venerdì degli ultimi quattro anni. Sua madre non ha mai smesso di scrivergli. Gli mandava libri sull’Australia, vestiti, piccoli regali. L’ultima volta gli ha spedito quel boomerang ».
Aprì gli occhi e rialzò il busto.
« I medici della comunità mi avevano assicurato che il suo disturbo era diventato gestibile » disse. « In pratica usando le stesse parole dello psicologo ».
Alzò lo sguardo su Davide.
« Non è un peccato che di queste previsioni sballate finisca sempre per pagare il prezzo qualcun altro? ».
C’era una pena sincera, sul suo viso.
« A questo punto dimmelo tu, dottore. Che ne sarà di mio figlio quando uscirà dal coma? Non posso scappare per sempre. Come riusciremo a contenere la sua rabbia? Come faremo a salvarlo da se stesso? A salvarci da quello che abbiamo risvegliato dentro di lui? ».
Il taxi lo aspettava all’incrocio di via Borgognoni.
In un cassetto della scrivania aveva recuperato le quattro banconote da venti che teneva di riserva nel caso avesse dimenticato soldi e carta di credito a casa. Si chiese se la sera precedente fosse uscito senza portafogli, oppure se dovesse considerarlo perduto insieme al cellulare: portafogli, peraltro, del quale non ricordava forma, materiale e dimensioni, tanto che in taxi passò almeno cinque minuti a cercare di ricostruirne induttivamente la storia. Decise di attendere quarantott’ore prima di preoccuparsi del persistere di quei vuoti di memoria.
Il tassista lo lasciò in via di Moriano.
Svoltò nella piccola e anonima via laterale e vide la Golf di Diego a una cinquantina di metri dal monastero.
La portiera spalancata amplificò all’istante la sua angoscia. Aumentò l’andatura, reprimendo la tentazione di mettersi a correre solo perché era troppo debole. Rimorsi assortiti sbatacchiavano dentro di lui a ogni passo. Quasi si tuffò nell’abitacolo. Era certo di trovare Diego riverso sui sedili: ferito, o più probabilmente morto, con il coltello ancora nel ventre.
Ma in macchina non c’era nessuno.
Il sedile era zuppo di sangue. Vide altre macchie di liquido scuro sull’asfalto, sotto i suoi piedi. Diego doveva essere rimasto lì alcuni secondi per recuperare le forze, riflettendo su qualche oscura questione.
Perché non si era precipitato in ospedale? Forse non aveva giudicato la ferita così grave da meritare l’intervento di un medico? L’ipotesi gli sembrò traballante nell’attimo stesso in cui la formulava. Chi avrebbe pensato un’assurdità del genere con un coltello piantato nell’addome?
Lasciò la macchina e zoppicò verso il monastero, gli occhi fissi sul macabro sgocciolio che imbrattava la strada. A metà dello steccato c’era un altro piccolo assembramento di gocce, come se Diego si fosse fermato una seconda volta.
Davide proseguì fino al sentiero che collegava la strada all’ingresso.
E qui si bloccò.
La ghiaia era immacolata.
Non una sola traccia di sangue fino al portone.
Com’era possibile? L’emorragia era visibilmente diminuita, ma gli sembrava improbabile che fosse cessata di colpo.
Alzò gli occhi verso il bosco.
E se Diego avesse proseguito fin lì?
Non aveva senso, ma controllare non gli costava nulla.
Fece un paio di metri e notò una goccia solitaria. S’inginocchiò a studiarla come uno scout indiano.
Era sangue.
Si rialzò e procedette fino al confine fra strada e prato.
Fissò la radura. Il declivio gli forniva una visuale vantaggiosa, ma l’erba era troppo alta per riuscire a notare la presenza di qualcuno.
Ammesso che lì in mezzo ci fosse qualcuno.
Continuava a non capacitarsi delle azioni di Diego. Tornare a casa non era un atto completamente irrazionale: per quanto contorta e residuale fosse, era la logica elementare di un animale ferito. Ma trascinarsi in un bosco oltrepassava ogni sua facoltà d’immedesimazione.
S’incamminò nella radura.
In certi punti l’erba era alta almeno mezzo metro, o persino di più. Minuscole gocce di rugiada brillavano al sole che presto le avrebbe assunte a sé. Davide proseguì con una strana calma, guardandosi intorno. L’odore di terra e di vari tipi di fiori gli riempiva le narici. Aveva l’impressione che l’erba serbasse la traccia del passaggio di qualcuno, una scriminatura appena accennata, la violazione delle delicate proporzioni di spazio ed equilibrio tra uno stelo e l’altro.
A un tratto s’imbatté in una larga zona di vegetazione che pareva essere stata compressa da qualcosa con la forma approssimativa di un corpo umano. A metà della sagoma c’era una grossa macchia di liquido assorbito dal terreno.
Stavolta non si chinò a esaminarla.
Brulicava di formiche.
Riprese a camminare, cercando di ignorare lo sciabordio della marea di presagi che sentiva montare dentro di sé.
Oltrepassò i primi alberi e si addentrò nel bosco. Il rumore del fiume rimbalzava sulle chiome dei pioppi in uno scroscio delicato. Privata della munificenza del sole, l’erba lì sotto era molto più rada e bassa.
In meno di un minuto giunse alla riva. Si concesse pochi secondi di silenziosa contemplazione di quell’angolo edenico. Da un argine all’altro c’erano almeno sei metri. Pensò che Diego non avrebbe avuto la forza, né alcuna presumibile ragione, di raggiungere la sponda opposta: quindi si mise a osservare con attenzione il terreno, in cerca di tracce. Dopo un po’ notò due minuscole macchie di sangue accanto a un piccolo avvallamento dell’erba.
Il suo amico doveva essersi seduto o inginocchiato lì.
E poi?
S’inginocchiò anche lui, come un medico forense sulla scena del crimine. Si piegò su un fianco per avere una prospettiva più accurata della riva a destra, poi ripeté l’operazione per il lato sinistro.
Niente.
Si alzò e proseguì l’ispezione per una ventina di metri in entrambe le direzioni.
Ancora niente. Non c’erano altre tracce.
Quindi si mise a verificare che non ci fosse erba importunata da passi umani in un raggio ancora più ampio, sperando che le sue capacità d’indagine fossero sufficienti a enucleare un indizio così fraintendibile. Passò i dieci minuti successivi a esplorare buona parte della riva, ma non trovò nulla di insolito: l’unico dettaglio straniante fu la curiosa sensazione di essere osservato – una specie di fremito alla nuca che ogni tanto lo spingeva a voltarsi.
Per un attimo considerò l’eventualità di allontanarsi dal fiume e setacciare almeno una parte dell’estremità meridionale del bosco, ma sospettava di essere troppo debole per un’impresa del genere.
Cosa poteva fare?
Il mal di testa era sfumato in una serie di lente pulsazioni regolari, che lo lasciavano pensare con un po’ più di lucidità.
L’unica soluzione era tornare al monastero e chiedere aiuto.
Quindi si diresse fino al punto nel quale aveva supposto che Diego si fosse seduto. Da lì guardò il fiume.
Si chiese quanto fosse profondo in quel tratto.
Abbastanza, si rispose.
Si girò e cominciò a camminare più in fretta che poteva, cercando di ignorare le implicazioni più indicibili e dolorose di quella parola.
Fu un giovane monaco ad aprirgli la porta. Aveva i capelli rasati, i piedi nudi, l’abbigliamento paramilitare e la stessa compostezza profusa dall’uomo che l’aveva accolto la prima volta. Il quale – se il livello di ascesi era proporzionale all’inespressività – doveva essere il roshi, il maestro. Il giovane ascoltò in silenzio la sua storia, scrutandolo da capo a piedi per trovare conferma alle assurdità appena proferite. Poi, quando intuì che le parole e l’aspetto allucinato dell’uomo configuravano una spaventosa attendibilità, corse dai suoi confratelli.
Che un minuto dopo si precipitarono fuori.
Erano in otto. Due di loro si avvicinarono alla macchina di Diego e ne osservarono l’interno con piccoli cenni costernati del capo. Pochi secondi ancora, e dal monastero sbucò il roshi. Salutò Davide congiungendo le mani e avvicinando il naso alla punta delle dita: disse solo che aveva provveduto a chiamare la polizia, poi s’incamminò con piglio deciso verso il bosco. I suoi discepoli lo seguirono allargandosi a ventaglio per buona parte dell’ampiezza del prato.
Davide si disse che avrebbe dovuto aiutarli. Ma non aveva il coraggio di contemplare il cadavere dell’uomo che aveva salvato la vita di Tommaso a prezzo della sua.
S’incamminò verso via di Moriano. Quello che avrebbe fatto sarebbe stato raggiungere a piedi il primo bar e chiamare un taxi perché venisse a prenderlo il più in fretta possibile.
32
Arrivò in ospedale un’ora dopo.
Entrò dallo stesso ingresso dal quale era uscito poco dopo l’alba di quella mattina. Guardò in basso dalla finestra del primo piano. La folla era aumentata.
Ripensò alle formiche che estraevano nutrienti dal sangue sul terreno.
Salì fino a neurologia. Entrò nello spogliatoio e si diresse all’armadietto. Si tolse la camicia e controllò di nuovo la fasciatura. Sul braccio sinistro erano apparsi graffi che in precedenza non aveva notato.
I segni delle unghie di sua moglie.
Si tolse le scarpe e indossò le Crocs da corsia, prese una t-shirt pulita e il piccolo beauty case dal ripiano superiore. Entrò in bagno e si rasò con cura, cercando di ignorare l’uomo sottoposto a traumi multiformi che lo fissava dalla superficie riflettente. Si lavò le ascelle con
qualche difficoltà – non riusciva a sollevare il braccio destro senza avvertire una fitta alla spalla –, s’infilò la maglietta e si pettinò. Poi si concesse una seconda panoramica allo specchio.
Il problema erano gli occhi: aveva dormito con le lenti a contatto procurandosi un’infiammazione.
Se le tolse e le gettò nella tazza.
Tornò all’armadietto e indossò il camice. Uscì dallo spogliatoio. Non vedeva quasi nulla. Dopo meno di venti passi incrociò un’infermiera che gli chiese come stava. Non riconobbe la sua voce e rispose alzando un pollice, senza fermarsi, poi affrettò il passo per non incappare in altri imbarazzi da omessa identificazione. Entrò in ufficio e si mise a rovistare nel cassetto della scrivania. Trovò un vecchio paio di occhiali da vista fotocromatici, li estrasse dall’astuccio e si alzò. Si avvicinò alla finestra e li espose alla luce fino a farli diventare della tonalità sufficiente a celare lo stato pietoso degli occhi.
Li indossò e uscì.
Incontrò un collega che si bloccò in mezzo alla corsia, atteggiando il viso a sollievo e sorpresa. Davide lo avvisò con una scrollata di capo che non poteva fermarsi.
Prese l’ascensore e scese in terapia intensiva. Attraversò il reparto e arrivò alla penultima stanza.
La 52.
Pieri aveva parlato di un ragazzo in coma per un colpo alla testa.
Se era in coma, quasi certamente era la stanza giusta.
Aprì la porta.
Giovanni era sdraiato sul letto, incosciente e intubato, con la testa posata su un cuscino occipitale da scarico. Un piccolo livido gonfio e scuro gli segnava la tempia sinistra.
Sui polsi erano evidenti le ecchimosi di una torsione vigorosa e prolungata. La cannula gli spuntava dalle labbra, collegata al ventilatore meccanico che sospirava con enfasi alla sua sinistra.
Davide si accomodò sullo sgabello a due passi dal letto.
Fissò il viso del ragazzo che aveva tentato di ucciderlo.
Che aveva spedito in rianimazione suo figlio.
Che aveva ammazzato il suo amico.
Il viso di un essere umano pazzo, irrimediabilmente pazzo, quindi presumibilmente incapace di arginare il tremendo Potere dentro di sé.
Sarebbe sopravvissuto? Probabile. Il trauma gli avrebbe lasciato danni permanenti? Non ne aveva idea.
In ogni caso non poteva fare molto per lui, che lo volesse o meno. Entro quella mattina le autorità avrebbero incrociato fatti e testimonianze e gli avrebbero impedito di vedere il ragazzo che aveva attentato alla sua vita. Da quel momento in poi, l’unico modo di contribuire alla sua salvezza sarebbe stato immaginarne la morte.
Ma Davide non era sicuro di essere buono fino a quel punto.
Lo odiava?
Riformulò: lo odiava al punto da desiderarne la morte?
E se non si fosse limitato a desiderarlo?
No, pensò.
Non sono un assassino.
Non voglio fargli del male.
Non ho mai voluto fare del male a nessuno in vita mia.
Chinò la testa e se la strinse tra le mani.
(Giuro di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente
la morte di un paziente…).
Ma…
… e se fosse uscito dal coma? Se una giuria gli avesse riconosciuto, di nuovo, l’infermità mentale?
Presto sarebbe tornato. Sarebbe tornato per vendicarsi di lui e di suo figlio.
Oppure lo avrebbe dimenticato. Fino al giorno inevitabile in cui il residuato semisepolto della sua ira sarebbe deflagrato sulla testa di qualcun altro. Nessun dubbio sull’intensità dello scoppio: le uniche incertezze erano legate a numero e identità delle vittime.
Ma lui non avrebbe mai patito le conseguenze delle sue azioni.
Gli sovvenne qualcosa che gli aveva raccontato Tommaso: ogni tanto, nell’universo, una nana bianca esplodeva in un lampo di devastante fulgore elettromagnetico, annichilendo
ogni altro corpo celeste attorno a sé in un raggio di miliardi di chilometri, ma sopravvivendo alla sua stessa furia.
Giovanni era qualcosa di simile.
Era questa la vita che lo aspettava? Vivere nel timore di vederlo ricomparire? O nel rimorso di non averlo fermato?
Davide si alzò.
No, si disse. Non posso permetterlo.
Sopprimerlo sarebbe stato di una semplicità disarmante. Avrebbe potuto iniettargli un po’ di morfina, oppure manipolare il ventilatore meccanico fino ad abbassare la percentuale di saturazione, somministrandogli la lenta eutanasia della carbonarcosi.
L’alternativa era uscire dalla stanza e illudersi che tutto sarebbe andato per il meglio.
(Inammissibili. Entrambe le opzioni erano semplicemente inammissibili).
A quale inverosimile dilemma si era consegnato? Guardò il profilo disegnato dalle cime degli alberi oltre la finestra, onde di sismografo verticillate nel cielo. Nessun dubbio che l’epicentro del terremoto fosse in quella stanza. Guardò la cannula che spuntava dalla bocca di Giovanni, come l’amo di una grottesca lenza. Non aveva idea di quanto tempo sarebbe passato prima dell’ingresso di un medico o di un infermiere.
Fece un paio di passi indietro e si sedette ai piedi del letto.
Non ne aveva idea, e in fondo non gli interessava.
Il tempo non esisteva più.
Lontano, oltre le cime degli alberi, la finestra incorniciava il consueto panorama cittadino di mura medioevali e tetti color terracotta, le torri al centro del quadro.
Davide aveva quasi l’impressione di sentire la voce dei feriti dai piani inferiori, il tumulto dell’emergenza rimbalzare sul contrafforte di suoni del piazzale. Chiuse gli occhi e rilassò le spalle. Non riusciva a pensare a un momento più inopportuno di quello per interrompere le comunicazioni con il mondo.
Invece no, si disse. Va bene così.
La sua mente proiettò una successione incoerente d’immagini sul fondale rosato delle palpebre. La pineta di Camaiore. Il corpo di Tommaso sul selciato di piazza Napoleone. Epaminonda che uccideva una serpe nel giardino di casa. Il viso impassibile di Neil Tennant. I piedi nudi di Barbara. Una piramide azteca in mezzo agli alberi. La triste adunanza di gocce sull’asfalto della via senza nome, che si sfioravano senza sovrapporsi.
Inalò a fondo e ripudiò ogni pensiero, lasciandosi cullare dal sospiro del mondo. Non c’era altro da fare.
La vita è una questione di giuste proporzioni.
A un certo punto deve succedere. O sei illuminato, o non lo sei. O sei innamorato, o non lo sei. O sei pronto, o non lo sei.
Si allungò sul ragazzo e gli posò una mano sul petto.
Tagliare o morire: non aveva alternative. Sentì di nuovo il brivido che gli aveva accarezzato la nuca sulla riva del fiume.
Qualcuno mi sta guardando, si disse. Qualcuno testimonierà che sto per rinnegare quello in cui ho sempre creduto.
Ora so che l’universo è infinito perché contiene tutto l’odio generato dalla razza umana dall’inizio dei tempi. Questo è ciò che siamo. Questa è la sostanza di cui siamo fatti: sangue, furore e detriti di sogni al confine tra sonno e veglia.
Dominare la violenza o esserne dominati. Toglietemi di dosso l’epitelio della civiltà fino a esporre il sembiante scorticato del mio vero io. Non sono più solo un medico seduto al capezzale di un ragazzo. Sono il figlio prediletto della foresta e del fiume. Sono il nucleo ribollente di Potere acquattato nelle tenebre in attesa di emergerne. Sono l’uomo con gli occhi chiusi, e medito sul tremendo koan oltre il quale saprò se sono capace di uccidere per salvare me stesso.