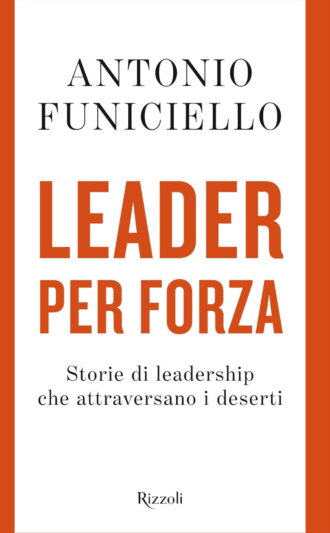Lo stile Draghi, una conversazione con Antonio Funiciello
Nel suo nuovo saggio, Leader per forza (Rizzoli), l’ex capo di gabinetto di Mario Draghi e Paolo Gentiloni tratteggia quali sono le caratteristiche più importanti di un capo, e perché spesso i leader migliori diventano tali per necessità. In questa conversazione, piena di aneddoti sui mesi passati a Palazzo Chigi, l’ex consigliere italiano riflette sulla crisi della democrazia e sulle possibili soluzioni per restare competitivi di fronte alle autocrazie
Cos’è per lei la leadership, quanto è cambiata nel corso della storia?
La leadership significa farsi carico dei destini della comunità, e la sostanza non è molto cambiata, il significato è questo fin dai tempi di Pericle o anche prima. Certo, cambiano gli strumenti e i contesti, ma nella sua essenza e nella sua identità leadership vuol dire farsi carico degli altri: il deserto non si attraversa da soli, altrimenti la definizione adatta è quella di eremita, il deserto si attraversa con dei seguaci di cui si ha la responsabilità. Con dei follower, se vogliamo utilizzare la stessa lingua della parola leadership.
Il leader ha una una duplice rappresentazione, una oggettiva e una soggettiva. La prima è la sua definizione istituzionale, un capo è parte di un sistema più complesso, che necessita di leadership. I sistemi di governo hanno bisogno di decisori apicali, altrimenti sarebbero immobili, e in questo senso non conta tanto la persona che, pro tempore, incarna la leadership, ma contano la sua storicizzazione e la sua funzione.
Esiste poi la dimensione soggettiva nella misura in cui i leader sono diversi perché diverse sono le persone che incarnano il ruolo. La presidenza della Repubblica è una leadership istituzionalizzata, così come la Presidenza del Consiglio, ma cambia l’interpretazione della carica da parte di chi soggettivamente la ricopre, perché la incarna sulla base dei valori, degli ideali, ma anche del carattere e dei bisogni e degli interessi di chi si rappresenta.
Il leader ha una una duplice rappresentazione, una oggettiva e una soggettiva
antonio funiciello
La dimensione istituzionale è più rilevante, perché essa è il frutto della storia della comunità; l’uomo o della donna che la incarnano devono essere bravi a interpretare e rappresentare gli interessi che la comunità esprime in quel momento storico.
Esistono dunque delle caratteristiche peculiari dei leader secondo la loro nazione di origine? Quanto concorrono i sistemi politici nella formazione delle leadership, rispetto alla personalità del leader? Emmanuel Macron potrebbe governare in modo così verticale senza il sistema che ha alle spalle?
Sicuramente le leadership francesi della Quinta Repubblica hanno caratteristiche legate a un certo modo di pensare se stesso del popolo francese, negarlo non è possibile. Si possono individuare tratti di continuità e di somiglianza tra Macron, Chirac, Mitterrand, Sarkozy o Hollande, che li distinguono dai leader contemporanei britannici o spagnoli, per non parlare di quelli tedeschi o italiani. Questo perché la leadership oggettiva influenza quella soggettiva.
Bisogna dire che quello francese è un sistema peculiare, unico nel suo genere, e questo però mi sembra molto legato alla storia della Francia, a come si crea la democrazia decidente e rappresentativa francese, la figura del Presidente della Repubblica, con i suoi poteri e le sue attribuzioni molto superiori a quello americano, non è casuale, attiene a una scelta dei francesi a un loro comune sentire. Il sistema però può certamente creare più conflitti di altri, perché conosce meno check and balances, meno corpi intermedi. Si tratta tuttavia di un portato storico e dall’interpretazione della leadership verticistica che i francesi in qualche modo vogliono, pretendono: non vedo una peculiarità di Emmanuel Macron in questo.
La leadership oggettiva influenza quella soggettiva
antonio funiciello
Certo, il presidente è un leader dei nostri tempi e interpreta la sua funzione con uno stile contemporaneo, ma dal punto di vista istituzionale non ha cambiato nulla, anzi subisce riforme approvate prima del suo insediamento. Trovo sia un interprete perfetto della grandeur francese, oltretutto è stato rieletto ed è il primo a esserci riuscito, al di là delle indubbie difficoltà che sta affrontando questo conterà qualcosa.
Nel suo libro lei racconta la vita e in particolare l’interpretazione del potere di leader molto diversi tra loro, da Mosè a Golda Meir, da Nelson Mandela a Vaclav Havel: qual è il tratto comune che li caratterizza?
Mi soffermo di più su leadership che nascono in maniera meno carismatica, più casuale, molte personalità di cui scrivo emergono perché sono meno divisive di altre. Penso a Truman o Lincoln, ma anche a Mosè che è il primo protagonista. Certamente Vaclav Havel è un altro caso di questo tipo e anche Golda Meir, che viene scelta come capo del labour israeliano come terza scelta: in quel momento ci sono due contendenti più forti che sembrano favoriti, ma sono molto divisivi, mentre Meir è il profilo che fa litigare meno il partito, e sul suo nome si trova una sintesi. Di esempi però ce ne sono molti, come quello di Sadat che succede a Nasser perché è la seconda scelta di tutti.
Ho scelto di approfondire la storia di queste personalità perché erano più affini al tema che stavo trattando, cioè la necessità della leadership. Credo che eludere il tema della leadership significhi indebolire drammaticamente la democrazia, perché si indebolisce quell’elemento fondamentale del potere democratico che è la decisione. Le autocrazie sono più agili nella formulazione della decisione, nel processo decisionale: se le democrazie non riescono a decidere con processi di trasparenza ma anche di velocità, esse perdono terreno, e nel mondo attuale questo può diventare un problema molto rilevante.
Credo che eludere il tema della leadership significhi indebolire drammaticamente la democrazia, perché si indebolisce quell’elemento fondamentale del potere democratico che è la decisione
antonio funiciello
Nel libro lei racconta un episodio molto interessante: durante il viaggio in Ucraina con Macron e Scholz, nel giugno 2022, il presidente Draghi ha un obiettivo, che è quello di far entrare Kiev nell’Unione europea, una linea non condivisa fino in fondo né dalla Francia né dalla Germania. Nonostante le divergenze, in quell’occasione Draghi, Scholz e Macron annunciano di appoggiare le richieste degli ucraini, e dare a Kiev lo status di paese candidato. L’italiano riesce a ottenere questo risultato politico, non scontato, evitando di parlare nella riunione decisiva. Draghi è quindi un leader silenzioso?
Silenzioso in quel contesto, nel senso che io racconto come, in un vertice durato per quasi due ore e mezzo, a un certo punto il presidente Draghi smetta di parlare, e lasci la scena ai due suoi omologhi. Però attenzione, aveva parlato molto prima, perché Draghi è un costruttore di soluzioni politiche, è abituato ad arrivare molto preparato al momento in cui il processo decisionale entra nel vivo e produce la decisione.
Draghi aveva preparato accuratamente quella missione, anche con uno sforzo politico e relazionale piuttosto accentuato nelle settimane precedenti. Preparare il terreno era necessario per arrivare poi al momento decisivo in cui le tessere del domino vanno giù una dietro l’altra. In questo senso paragono la sua figura a quella di Cavour, abituato a giocare di sponda, non a imporre la sua volontà.
Draghi è un costruttore di soluzioni politiche, è abituato ad arrivare molto preparato al momento in cui il processo decisionale entra nel vivo e produce la decisione. In questo senso paragono la sua figura a quella di Cavour, abituato a giocare di sponda, non a imporre la sua volontà
antonio funiciello
Nella riunione decisiva con Macron, Scholz, il premier romeno Iohannis e Zelensky, Draghi lascia che sia l’ucraino a perorare la causa del suo paese, naturalmente sostenendolo, ma lasciando spazio alla discussione. Dopo le due ore e mezzo sembrava che la decisione di concedere lo status di candidato all’Ucraina fosse un’idea di Scholz e Macron, ma in realtà era una posizione italiana, di Draghi: lui fu talmente bravo da lasciare che i suoi partner, i suoi alleati principali, i suoi amici, si appropriassero di questa decisione. Questa è leadership.
Lei sostiene che l’Italia può dunque giocare un ruolo di primo piano negli affari internazionali, a condizione che non si lanci in avventure velleitarie e solitarie.
Sì, e l’esempio dell’Ucraina è utile in questo senso. Draghi riesce a inserire la sua posizione in un contesto più generale, in cui l’Italia diventa un player internazionale forte perché riesce a giocare di sponda, a non pensare di mandare in buca la palla in modo diretto, perché tanto non ha la forza per farlo, non è gli Stati Uniti. In questo senso c’è una grande differenza con la Francia, che invece vuole tirare la palla in bica in prima persona, ma la verità è che Parigi riesce a farlo soltanto quando riesce a giocare una leadership europea, quando assume pienamente una responsabilità europea. In coppia con la Germania la Francia può riuscire a far molto, perché sono i due paesi guida dell’Europa, ed è necessario che lavorino insieme per tirare avanti tutti.
Dopo le due ore e mezzo sembrava che la decisione di concedere lo status di candidato all’Ucraina fosse un’idea di Scholz e Macron, ma in realtà era una posizione italiana, di Draghi: lui fu talmente bravo da lasciare che i suoi partner, i suoi alleati principali, i suoi amici, si appropriassero di questa decisione. Questa è leadership
Antonio funiciello
L’Italia è invece legata all’immagine del piccolo Piemonte cavouriano che cerca di inserire la propria questione nazionale dentro il grande scacchiere internazionale. Roma è forte perché è più agile di altri, può sfruttare gli spazi stretti e giocare di sponda. Per riuscirci deve però far valere le proprie alleanze.
Lei parla di una leadership, quella di Mario Draghi, che tuttavia non ha avuto l’unzione del suffragio universale. Avete mai sentito la mancanza di questa investitura nei mesi a palazzo Chigi?
Credo molto nel mandato popolare, è importantissimo, ma le elezioni non sono l’unico modo per ottenerlo, c’è un mandato anche quando questo è mediato dal voto del Parlamento. Draghi è stato chiamato in circostanza un po’ estreme a gestire delle crisi, la prima era la vaccinazione, la seconda era portare a casa il PNRR, e poi durante il mandato ha dovuto affrontare la terza crisi, cioè la guerra in Ucraina. Non abbiamo mai sentito la mancanza del mandato popolare: avevamo una maggioranza parlamentare ampia e diffusa che sosteneva la nostra azione, e se uno crede nella Costituzione deve credere che quel mandato parlamentare sia pienamente legittimo. Noi lo credevamo. A questo si aggiunge il fatto che Draghi ha sempre avuto un consenso molto forte nel paese, che mostrava di comprendere e condividere le decisioni prese dall’esecutivo.
Crede che la struttura di Palazzo Chigi e più in generale i poteri dati al presidente del Consiglio siano sufficienti? Oppure la presidenza del Consiglio italiana è un’istituzione ancora troppo debole se paragonata alla Cancelleria tedesca, all’Eliseo, a Downing Street?
È più debole, e questo è un limite che spero venga presto recuperato, credo che bisognerebbe colmare questo gap e dare più forza alla Presidenza del consiglio. È debole perché si vuole che sia debole, la legge che regola il funzionamento dell’esecutivo è degli anni Ottanta, tra l’altro voluta fortemente dall’allora ministro dei rapporti con il Parlamento che si chiamava e si chiama Sergio Mattarella. Era, tuttavia, un altro tempo, oggi dovremmo ripensare l’executive office del governo italiano, che ha un ruolo meno incisivo a causa della particolare storia italiana: il premier è un primus inter pares perché quando è stata scritta la Costituzione, nell’immediato dopoguerra, le forze politiche avevano il complesso del tiranno, la memoria del fascismo era ancora fortissima e i padri costituenti non volevano rafforzare il capo dell’esecutivo.
Ciò non vuol dire che chiunque vada al governo abbia le mani legate o non abbia alcun potere e in realtà le decisioni che contano in Italia vengano prese non si capisce bene da chi. Questa è una fesseria. In Italia decide il capo del governo, insieme ai ministri e al Parlamento, e nell’esercizio delle sue funzioni deve tenere conto del Quirinale, della Corte Costituzionale e degli altri organi di controllo, è normale e giusto che sia così. Ma chi siede a palazzo Chigi conta moltissimo, conta la sua storia, ciò in cui crede, la sua vita, le sue convinzioni. E conta anche perché la nostra Repubblica è molto più forte di come viene raccontata, quando non si prendono decisioni c’è un tema di limite di capacità decisionale, ma questo va ricondotto alle persone non a oscure trame. Vuol dire che su quel dossier c’è un limite del presidente del Consiglio, dei ministri, di tutti quelli che hanno responsabilità esecutive.
Il premier è un primus inter pares perché quando è stata scritta la Costituzione, nell’immediato dopoguerra, le forze politiche avevano il complesso del tiranno, la memoria del fascismo era ancora fortissima e i padri costituenti non volevano rafforzare il capo dell’esecutivo
antonio funiciello
La politica italiana ha preso un paese distrutto e devastato dalla Seconda guerra mondiale e l’ha portato a diventare un player globale; oggi l’Italia vive una fase di marginalizzazione del proprio ruolo globale ma perché sono emersi nuovi attori molto più grandi, ma siamo da sempre protagonisti della creazione di un’identità europea che può a ragione competere con le grandi identità globali, quella cinese, quella americana. Bisogna proseguire su questa strada.
Oggi le nostre leadership democratiche sono in crisi?
La democrazia ha due problemi distinti ed egualmente importanti. Da un lato una limitata capacità decisionale e dall’altro il tema della rappresentatività. Della prima abbiamo detto, ma anche la fuga dal voto e l’abbassamento della partecipazione sono diventate un problema, la leadership ha bisogno di emergere da una larga rappresentanza, se emerge da una più piccola è un problema: certo è legittima sul piano procedurale e costituzionale, ed è un principio che non si può mettere in discussione, però deve affrontare un problema politico non di poco conto, perché una scarsa partecipazione implica una leadership meno rappresentante.
Siamo da sempre protagonisti della creazione di un’identità europea che può a ragione competere con le grandi identità globali, quella cinese, quella americana. Bisogna proseguire su questa strada
antonio funiciello
Risolvere una delle due crisi porta a risolvere anche l’altra: la bassa partecipazione è generata da una insoddisfazione verso una scarsa capacità decisionale; che d’altro canto interviene quando manca un forte mandato di rappresentanza che consente al decisore di assumersi qualche rischio. Quando si decide i rischi esistono e per affrontarli è necessario coraggio politico ma anche un consenso rilevante nella propria comunità. Altrimenti il meccanismo rischia di sfaldarsi.
Nel suo libro lei dice che nel breve termine assisteremo a un cambiamento nella formazione delle leadership in Europa, che saranno sempre più formate nelle istituzioni comunitarie e meno in quelle nazionali. Come mai?
Io dico che i luoghi di formazione della leadership sono i luoghi di decisione. Perché l’Italia ha avuto Luigi Einaudi, Guido Carli, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi, tutti grandi leader venuti dalla Banca d’Italia e ora non più? Perché nel Novecento era l’istituzione che definiva la politica monetaria, assumeva delle decisioni complesse e rilevantissime, mentre oggi ha un ruolo diverso, di vigilanza, e quindi fa più fatica a far emergere leadership poi spendibili sul lato esecutivo, della finanza pubblica, della macroeconomia. Oggi il livello di governance cruciale è quello comunitario: tante decisioni esecutive si assumono in Europa, dunque accumulare esperienza in quelle sedi può avere un valore davvero esemplare per poi avere incarichi di governo e svolgerli a livello nazionale. L’esperienza comunitaria garantisce un livello di competenza e conoscenza di una scala di governance fondamentale quando si torna nel proprio paese in ruoli apicali.
La leadership ha bisogno di emergere da una larga rappresentanza, se emerge da una più piccola è un problema: certo è legittima sul piano procedurale e costituzionale, ed è un principio che non si può mettere in discussione, però deve affrontare un problema politico non di poco conto, perché una scarsa partecipazione implica una leadership meno rappresentante
antonio funiciello
Nel capitolo su Nelson Mandela lei pone l’accento sul fatto che il suo percorso dopo il carcere è possibile anche grazie all’assenza di polarizzazione, alla capacità di mondi diversi di lavorare insieme. È ancora possibile o le nostre società democratiche sono per loro natura ormai troppo polarizzate? Guardando gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, l’Italia è difficile non notarlo.
Viviamo in una fase di estrema polarizzazione. L’assalto a Capitol Hill è un fenomeno a parte: non riconoscere il risultato elettorale e distruggere il Parlamento è l’ultimo passo prima della distruzione completa della democrazia, non è paragonabile alle proteste francesi dei gilet gialli, per intenderci. Se la polarizzazione prosegue e si estremizza ulteriormente la democrazia non può sopravvivere, perché si basa sull’idea che la polarizzazione si governa, che c’è la possibilità di arrivare a un compromesso in cui anche le posizioni più lontane trovino concordia. La polarizzazione in occidente è coincidente con la fase declinante della democrazia liberale degli ultimi 30 anni, che dopo una forte espansione ha cominciato un lento ripiegamento, oggi al suo culmine.
Oggi il livello di governance cruciale è quello comunitario: tante decisioni esecutive si assumono in Europa, dunque accumulare esperienza in quelle sedi può avere un valore davvero esemplare per poi avere incarichi di governo e svolgerli a livello nazionale
antonio funiciello
La conseguenza di una polarizzazione ancora più radicale in cui non ci si riconosce reciprocamente è la fine della società così come la conosciamo. La democrazia va preservata. Non penso che sia il peggior sistema eccetto gli altri, penso al contrario che sia un ottimo sistema, che meglio rappresenta e dà vita ai diritti fondamentali dell’individuo: devo credere e credo che a questa fase di polarizzazione possa seguire una fase di riavvicinamento, in cui nei paesi occidentali i sistemi democratici tornino a rappresentare bisogni e interessi della cittadinanza.
La democrazia non è soltanto uno strumento di accrescimento e di miglioramento delle condizioni delle persone in senso materiale, ma anche un formidabile strumento di miglioramento di beni immateriali degli esseri umani, perché garantisce diritti e libertà.
Lei dedica l’ultimo capitolo ad Angela Merkel, e definisce la sua leadership come «irrisolta». È sicuro che sia così? Alla fine la sua politica di appeasement con la Russia è stata fallimentare, in questo senso, dal punto di vista dei rapporti internazionali, è «risolta»…
Merkel è stata la più importante leader dell’Occidente nella prima parte di secolo e non c’è dubbio che la Germania si sia rafforzata in questi anni, la sua guida è stata senz’altro positiva per i tedeschi. Mi stupisce, dei suoi anni, una coincidenza singolare: il periodo in cui Helmut Kohl unifica la Germania e inaugura un periodo di forte espansione e miglioramento sociale della Bundesrepublik, coincide con una complessiva espansione democratica e diffusione dei valori democratici.
Con Angela Merkel avviene il contrario, da qui la mia definizione di leadership irrisolta: la cancelliera non è riuscita a trasferire questa sua capacità di governare bene la propria democrazia su scala più ampia, non è riuscita a rappresentarsi pienamente come leader occidentale. Non aver pensato la guida della Germania anche in chiave extra nazionale è stato un suo limite. Non può non pesare la vicenda russa, l’appeasement tedesco verso la Mosca non ha giovato, esso si fondava sul principio che bisognava tenere Putin vicino, ma a furia di accettare l’aggressività del Cremlino siamo arrivati all’invasione dell’Ucraina con i carri armati.
Sono curioso di leggere le sue memorie, gli argomenti da lei avanzati finora, e cioè che ha dato tempo all’Ucraina di organizzarsi e difendersi li trovo un po’ deboli, non mi pare che Nord Stream 2 fosse una scelta per rafforzare l’Ucraina. Lei ha sempre derubricato questo come una scelta economica, ma in realtà è stata una scelta geopolitica e geostrategica di fortissimo impatto globale, ed è stata fatta in piena consapevolezza ed è stata sbagliata, tanto che hanno dovuto bloccare tutto.
Negli ultimi 3 anni l’Europa ha vissuto due momenti che possiamo definire hamiltoniani: il primo, con la decisione finanziare il rilancio economico del continente dopo la pandemia con l’emissione di debito comune, il secondo con l’aiuto compatto all’Ucraina e le sanzioni alla Russia. Quando conterà la visione e la perseveranza dei leader per continuare in questa direzione?
I leader sono fondamentali, ma non bastano: è necessario che i capi di governo rimangano rappresentativi di interessi e aspirazioni dell’opinione pubblica europea, che deve comprendere l’assoluta necessità di queste scelte. Siamo in mezzo al guado, con il programma Next generation EU ci siamo spinti dove non eravamo mai andati, non possiamo tornare indietro.
I progressi arrivano sempre grazie alle emergenze e alle crisi, la CECA nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e nasce per una necessità, oggi l’Europa si sta evolvendo grazie al Covid e adesso grazie alla minaccia della Russia di Putin. Il punto è che ci siamo spinti molto avanti, e quindi la strada da percorrere è molto complessa: leadership consapevoli, coraggiose e trasformative, sono leadership che a questo punto vogliono completare il percorso. Il grande sogno resta quello di trasformare la più grande area commerciale del mondo in un’area politico-economica.