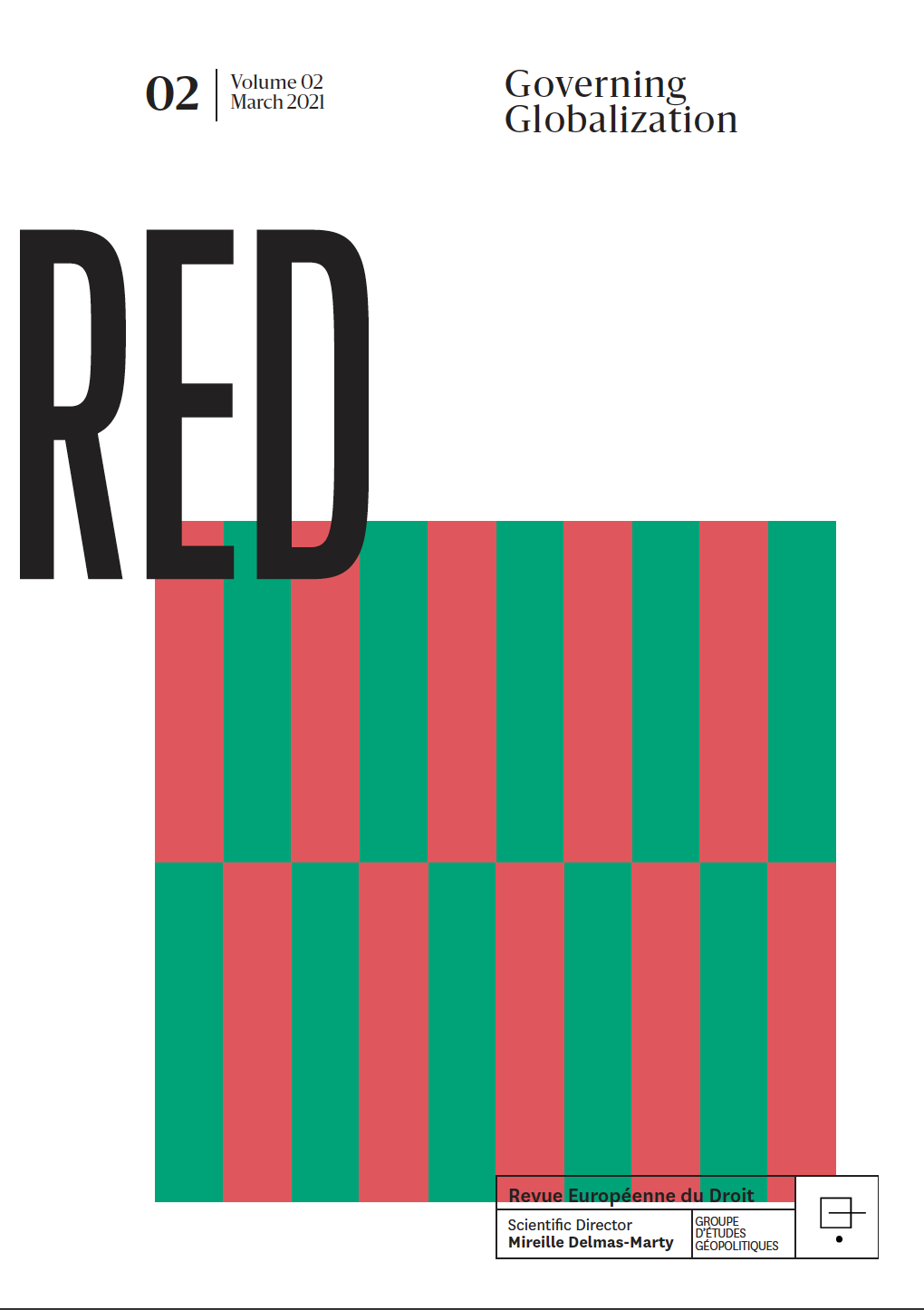Abbonatevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati sul lancio de “Il Grand Continent” in italiano
Questo fascicolo è disponibile in inglese sul sito del Groupe d’études géopolitiques.
Interrogarsi su una governance globale potrebbe sembrare, a prima vista, anacronistico: i tempi non appaiono più maturi per le grandi dichiarazioni universalistiche, la globalizzazione del commercio o gli accordi sovranazionali, bensì per la riscoperta degli interessi particolari dello “stato nazionale”, il ripiego su di sé dell’”ognuno a casa propria”, o anche l’egoismo del “Me First”. La crisi – o forse dovremmo chiamarla policrisi – in cui siamo tutti coinvolti a causa di interdipendenze economiche ormai slegate dalla solidarietà è soprattutto il prodotto di un certo tipo di globalizzazione, caratterizzata da una fragilità strutturale ereditata da profonde e precipitose trasformazioni. Un nuovo mondo sta già prendendo forma, un amalgama eterogeneo, instabile e imprevedibile le cui caratteristiche, faglie e fratture non potevano essere previste. Ciò è evidenziato non solo dal nuovo protezionismo e dalla crisi del multilateralismo, ma anche dalla moltiplicazione di modelli politici, sociali ed economici alternativi e talvolta incompatibili.
Così, senza pretendere di essere esaustivi, le sfide globali si moltiplicano, siano esse legate alle pandemie vissute e annunciate, alle crisi migratorie attuali e future, alla lotta contro i crimini contro l’umanità, alle crisi finanziarie e sociali, all’evasione fiscale; senza dimenticare, con il potere della tecnologia digitale, l’ambivalenza delle nuove tecnologie. Tale insieme, che trasforma l’umanità in una forza capace di minacciare il suo stesso futuro, crea, infatti, una comunità (involontaria) di destino. Che ci piaccia o no, queste nuove sfide richiedono una concertazione globale e, senza dubbio, il rifiuto dei riflessi nazionalistici e la ridefinizione di un regime di convivenza comunitaria. Piuttosto che negare queste realtà, l’attuale policrisi è un’opportunità per mettere in discussione, prima di un nuovo inizio, i concetti alla base di questa corsa imperturbabile.
Inoltre, è necessario prendere coscienza della crescente inadeguatezza del pensiero giuridico tradizionale. In assenza di una vera ideologia comune che ordini i molteplici, disparati e frammentari spazi normativi, le nostre società sembrano ancora alla ricerca della narrazione giuridica che dovrebbe rifletterle e/o addomesticarle, permettendo loro di evitare la doppia minaccia del “grande collasso” e della “grande schiavitù”.
Lungi dal limitarsi a un’apertura degli scambi economici su scala mondiale, la globalizzazione richiede una ridefinizione del regime di coesistenza di comunità politiche eterogenee, dove il punto di riferimento normativo (il “Polo Nord”) non può più emergere nei tradizionali centri di valori comuni. Al tempo delle comunità nazionali, fatte di memorie e ricordi condivisi, gli accordi e i disaccordi collettivi sembravano plasmare le regole del diritto e strutturare i quadri politici, stabilizzati da valori e interessi condivisi, anche se in evoluzione e imposti. Ma queste “bussole nazionali” sono diventate effimere e stanno scomparendo una dopo l’altra sotto le forze corrosive della globalizzazione, e di conseguenza sono incapaci di affrontare le sfide comuni di tutta l’umanità. Senza bussola, l’umanità viaggia come un battello ebbro, spinto ai quattro venti del mondo nella nostalgia di una memoria svanita e di valori comuni inesistenti. Dove possiamo trovare allora gli strumenti per una tale ricomposizione e come possiamo reinventare, insieme ai vari attori, una forma di governance globale?
Naturalmente, le riflessioni su una legge “globale” non sono una novità. Le vediamo all’opera nelle teorie che cercano di costruire un costituzionalismo globale, un diritto amministrativo globale, o un ordine giuridico privato non statale transnazionale. Se questi sforzi, molteplici e diversi, faticano ad avere successo, è perché riflettono le tensioni intrinseche, anzi l’irrazionalità, di qualsiasi tentativo di trovare sostegno in categorie ben ordinate, derivate da storie e memorie idiosincratiche, per capire e agire in un mondo che è fondamentalmente disordinato, interattivo, instabile e non gerarchico.
In altre parole: la complessità di sfide inedite, così come la diversità dei modi di vita e degli interessi coinvolti, rendono i trapianti giuridici, o le estrapolazioni di soluzioni nazionali a livello globale, inefficaci e, soprattutto, inappropriati.
Tra l’ordine egemonico di questa monarchia universale che Kant chiamava “dispotismo” e il grande disordine di un mondo non solo diviso, ma frammentato, le due insidie della globalizzazione ci obbligano a pensare a un universalismo contestualizzato, dove la ragione giuridica non offra soluzioni preconfezionate, ma piuttosto strumenti di deliberazione e fecondazione reciproca (cross-fertilization) capaci di fondare l’unità nella pluralità. In altre parole, in assenza di un’impossibile identità tra sistemi normativi nazionali unificati, una vera governance globale dei beni comuni, se è possibile, non può che essere pluralista e instabile, ibrida e flessibile.
A ben vedere, questo appello alla creazione di una governance pluralista non è che il riflesso di una pratica comune, quella del “bricolage” giuridico degli attori della globalizzazione, ovvero il tentativo di “globalizzare” gli ordinamenti giuridici nazionali avvicinandoli senza confonderli, e di “contestualizzare” le norme internazionali adattandole alle realtà locali. Il bricoleur sostituisce il proporzionale al categorico, oppone l’integrazione verticale alla consultazione orizzontale, e preferisce il simile all’identico. Ci sono molte incarnazioni di questo fenomeno.
Fondamentalmente, si tratta di uno sforzo di tolleranza reciproca che si manifesta, per esempio, nel diritto internazionale privato, dove l’esercizio di qualificazione e riconoscimento si basa su un’identificazione della prossimità delle istituzioni nella diversità delle loro manifestazioni, a condizione però che il risultato non vada contro i principi fondamentali (o l’ordine pubblico internazionale) del “riconoscitore”. In altre parole, che quest’ultimo possa accogliere nel suo ordinamento una soluzione diversa senza per questo negare la propria essenza.
Si tratta inoltre di metodi utilizzati nella messa a punto di strumenti internazionali quando l’uniformità è impensabile, come il cosiddetto metodo dell'”equivalenza funzionale”, che è il risultato di una fruttuosa combinazione di realismo giuridico e funzionalismo sistemico. Quando l’OCSE ha cominciato a lavorare a una Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, i suoi redattori, consapevoli delle profonde differenze tra le culture penali degli Stati membri, si sono accontentati di definire un sistema di principi di base e si sono rivolti a questo concetto di equivalenza funzionale per permettere un margine di adattamento nazionale, senza esigere l’uniformità e senza offendere i principi fondamentali dei sistemi giuridici degli Stati membri, per esempio, per quanto riguarda le forme di responsabilità penale delle persone giuridiche.
In questo contesto, l’equivalenza tra le misure nazionali è allo stesso tempo sia un metodo che un obiettivo, il cui successo dipende dalle modalità di monitoraggio e controllo delle misure nazionali, così come sono scritte e applicate nella pratica.
Lo stesso vale, nel campo dei diritti umani, per il “margine di apprezzamento nazionale”, originariamente assente nella CEDU, ma ben presto istituito dalle corti europee nei casi in cui misure restrittive o addirittura derogatorie sono ammesse dalla Convenzione in nome dell’ordine pubblico nazionale: le corti tengono conto del contesto (culturale, sociale, economico, ecc.) di ogni Stato per attenuare le esigenze di applicazione uniforme e preservare così il principio di sussidiarietà.
Questi esempi mostrano che armonizzare le differenze (dal basso verso l’alto, dal locale al globale) e contestualizzare l’universale (dall’alto verso il basso, diversificandolo dal globale al locale) non significa in nessun modo abbandonare ogni razionalità assiologica. La governance pluralista si basa, prima di tutto, su un insieme di principi guida che devono essere rispettati affinché sia possibile valutare la prossimità nella diversità.
Tracce di tale ricerca si possono trovare nella lunga (ma un po’ trascurata) tradizione dello ius gentium dell’antichità romana, che riflette le esigenze della ragione naturale, cioè i bisogni comuni a tutti gli esseri umani in quanto esseri senzienti. La tradizione continuò nel Medioevo attraverso lo ius commune, un ibrido di diritto romano, diritto canonico e lex mercatoria, applicato come metodo di ragionamento e guida all’interpretazione delle diverse e complesse variazioni locali.
Oggi, nuovi valori comuni possono essere pensati attraverso l’integrazione dinamica, a spirale, di diverse visioni dell’umanesimo: l’umanesimo emancipato dell’illuminismo, che suggerisce la pari dignità degli esseri umani, ma anche l’umanesimo relazionale, che evoca l’umano nelle sue relazioni di prossimità e ospitalità, così come l’umanesimo emergente dell’interdipendenza, che riconosce che l’umano appartiene alla natura e non è padrone di essa, aggiungendo alla domanda di solidarietà sociale quella di una solidarietà ecologica di fronte alle nuove capacità dell’umanità di fare danni. A questi valori fondanti si aggiungono quelli che nascono, come hanno dimostrato gli studiosi costituzionali contemporanei, dall’ibridazione e dall’arricchimento reciproco e graduale delle identità giuridiche organizzate in una rete non gerarchica, un esercizio di avvicinamento attraverso il contatto e la comprensione reciproci, la deliberazione, lo scambio, l’accordo e il disaccordo.
Quest’ultimo punto ci porta all’esigenza di una governance pluralista in cui la validità formale, che accompagna la definizione di norme comuni di razionalità deliberativa, si combina con la validità assiologica che ammette le differenze, purché siano compatibili tra loro. Ciò implica uno sforzo di integrazione e di adattamento, e non il rifiuto ab initio dei valori proposti. Ciò implica anche requisiti procedurali, volti a rendere razionalmente accettabile, senza pregiudicarla, la decisione finale: equa rappresentanza delle parti, trasparenza nella motivazione delle decisioni, rigore e coerenza nell’uso dei metodi di ponderazione; così come, nei settori che vi si prestano, il rispetto dei dati scientifici quando sono affidabili.
Queste sono le condizioni che rendono possibile una deliberazione razionale, che sostituisce la contestualizzazione all’uniformità e la compatibilità alla conformità pura e semplice, senza cadere nell’arbitrarietà, grazie a un formalismo rivisitato da logiche non standard, come le fuzzy logics (logiche sfumate) o la topologia (logica dei vicinati).
È in questo senso che la governance pluralista permetterebbe l’emergere di una narrazione dell’umanità come un’avventura comune, alla ricerca di un “equilibrio dinamico” che stabilizzi le società nelle loro relazioni reciproche senza congelarle nelle loro differenze. In breve: che pacifichi gli esseri umani senza standardizzarli. In questo senso, la costruzione dell’Europa è senza dubbio uno dei più ambiziosi laboratori di osservazione e di prova che abbiamo per costruire solidarietà comuni. È proprio perché l’Europa è vaga, incerta, che forse riuscirà a stabilire un pluralismo ordinato. Valorizzando il meglio di ogni tradizione nazionale attraverso prestiti reciproci (lo statuto del Pubblico ministero europeo ne è un esempio), un’Europa sovrana inventerebbe così un ordine sovrano che non sia autoritario né uniforme, bensì democratico e pluralista.
Questa utopia è tanto più realizzabile in quanto l’Unione Europea sta anche cercando di inventare un altro modo di governare tramite il diritto, non solo separando i poteri, ma aggregando livelli di organizzazione (statale, infrastatale e sovrastatale) e categorie di attori (pubblici e privati, ma anche attori civici e scientifici), in una forma di governance ancora regionale, ma che sostituisca già relazioni interattive ed evolutive, quindi complesse, alle relazioni gerarchiche e stabili dello Stato nazionale. È in questo senso che va intesa l’idea di “sovranità” europea: se la costituzione di un’Europa “sovrana, unita e democratica” permette di restituire alla politica la sua “capacità d’azione” nel contesto della globalizzazione, è perché essa segna il passaggio da una sovranità solitaria, protetta ma anche chiusa nei suoi confini, a una sovranità solidale, aperta e accresciuta, che mira a proteggere, al di là dei soli interessi nazionali, veri e propri beni comuni globali.
Methods
- Luis Arroyo Zapatero, Which method for penal harmonization?
- Pavlos Eleftheriadis, Natural Reason and the Ethical Foundations of European Law
- Vincent Forray et Sébastien Pimont, Governing globalization through law: The hypothesis of a new natural law
- Pascal Lamy, Answering the crisis of multilateralism with polylateralism
- Astrid Mignon Colombet et Nicola Bonucci, Towards Plural Governance: Functional Equivalence in the Fight Against Transnational Corruption
- Dani Rodrik, The Right Scope of Global Governance and Democracy Enhancement
- Jean-Marc Sorel, The Role of Soft Law in Global Governance: Heading Towards Hegemonic Influence?
- Christiane Taubira, World, globalization and mondialité
Actors
- Frédéric Baab, Will the European Public Prosecutor’s Office be a stab to the heart?
- Samantha Besson, Reconstructing International Law starting from Regional Organizations
- Li Bin, The Belt and Road Initiative: A New Landscape in Mapping the Changing Global Governance
- Anu Bradford, The European Union in a globalised world: the “Brussels effect”
- David Djaïz, A new architecture for globalization
- Bernard Hoekman et Petros Mavroïdis, Avoiding a Requiem for the WTO
- Dominique Rousseau, For Democratic Global Governance
- Bernard Stirn, Participating in the Governance of Globalization through Law: New Horizons for National Supreme Courts
Challenges
- Yann Aguila et Marie-Cécile de Bellis, A Martian at the United Nations or Naive Thoughts on Global Environmental Governance
- Edith Brown Weiss et Vicki Arroyo, Addressing Climate Change from the Bottom-Up in a Kaleidoscopic World
- Guy Canivet, Global governance through the market and sustainable development
- Peter Chase, Data Protection and Global Data Governance
- Laurent Cohen-Tanugi, Law is more than ever the necessary language of globalization
- Martin Collet, Taxation of the digital economy: global challenge, local responses?
- Thierry de Montbrial, Governance of common goods as a political lever
- Jorge Viñuales, Geopolitics of the Energy Transformation
Ouverture
- Olivier Abel et Mireille Delmas-Marty, In the spiral of humanisms