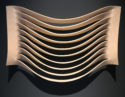Abbonatevi alla nostra newsletter per rimanere aggiornati sul lancio de “Il Grand Continent” in italiano
L’attuale dibattito europeo presenta allo stesso tempo vigorosi appelli alla necessità di nuovi progetti ambiziosi, per esempio nelle parole di Emmanuel Macron e Mario Draghi, ma anche richiami alla prudenza da parte di numerosi governi. L’Unione Europea si trova quindi davanti a un trilemma. Le circostanze vorrebbero un progresso deciso nell’integrazione. Tuttavia realizzare progressi importanti con il consenso di tutti i membri diventa sempre più difficile. Allo stesso tempo però l’unità dei 27 è ancor più che per il passato un bene prezioso da proteggere. Come sempre, la fattibilità dei progetti, allo stesso tempo ciò che è necessario e ciò che è fattibile, dipenderà dall’evoluzione degli avvenimenti. È quindi da lì che bisogna cominciare.
Nei quindici anni che ci separano dalla crisi finanziaria, l’UE ha vissuto uno dei suoi periodi di più intensa mutazione. Il decennio precedente che era stato il teatro di due decisioni epocali come l’introduzione dell’euro e il passaggio da 15 a 28 paesi membri; per quanto importanti, esse tuttavia erano annunciate da tempo, il compimento di progetti e impegni presi in precedenza in seguito alla caduta del muro di Berlino e alla dissoluzione dell’URSS. Nulla di quanto è successo più recentemente era stato programmato. Abbiamo dovuto reagire agli avvenimenti e l’abbiamo fatto spesso in una situazione di sostanziale vuoto giuridico e con istituzioni mal equipaggiate per far fronte a crisi di quell’ampiezza. Dire che tutto ciò è successo sotto la guida di fatto di Angela Merkel, Cancelliera del paese più importante dell’Unione, è solo in parte una semplificazione. Il percorso effettuato riflette quindi il suo stile, ma più in generale la prudenza con cui la Germania si muove solo dopo aver assicurato un grado elevato di consenso interno e poi europeo. È un modo di procedere che può creare esasperazione e suggerire un’analogia con quanto Churchill diceva dell’America: “fanno la cosa giusta solo dopo aver esaurito tutte le alternative”. D’altro canto, il consenso (interno ed europeo) così acquisito si è poi dimostrato duraturo, in contrasto con gli ondeggiamenti che hanno caratterizzato la politica europea di altri grandi paesi come la Francia e l’Italia. La Germania ha anche introdotto nel dibattito europeo un concetto di sacralità delle regole che è parte integrante del suo consenso interno e riflette la volontà di esorcizzare un drammatico passato. L’altra caratteristica del percorso effettuato è che l’UE è programmata fin dalla sua creazione per occuparsi delle crisi quando avvengono ma non di affrontare i nodi sistemici che le permetterebbero di prevedere e prevenire le crisi successive.
Gli avvenimenti a cui mi riferisco sono noti. Intorno a Brexit ci sono due narrative. Secondo la prima, l’Europa ne risulta indebolita sul piano economico, politico e militare. Inoltre è stato infranto il tabù della perennità. Secondo la seconda, Brexit ha effetti positivi perché viene a mancare uno dei paesi che in passato si erano opposti con più forza a una maggiore integrazione. Entrambe le interpretazioni sono vere, ma devono anche essere relativizzate. L’opposizione britannica è spesso servita di alibi alla resistenza di altri, ma non ha mai impedito progressi che erano fortemente voluti da una maggioranza di paesi: per esempio Schengen e l’euro. Inoltre, Brexit ha rafforzato l’unità dei 27 e accresciuto il senso di appartenenza anche di chi era tradizionalmente vicino alle posizioni britanniche. D’altro canto però, l’assertività di questi paesi (gli scandinavi e l’Olanda per esempio) è stata rafforzata dall’assenza del più influente difensore del liberismo in economia e dell’atlantismo in politica estera e ha dato loro quasi una “nuova missione” in seno all’UE. Brexit ha peraltro incoraggiato la tesi di una inevitabile frattura, politica, culturale e addirittura valoriale, fra il continente europeo e un mitico “mondo anglosassone”. Tesi che non ha però fondamento reale e sottovaluta sia quanto la Gran Bretagna sia in realtà “europea”, sia quanto una parte importante dell’Europa, soprattutto a nord ma anche a est, si senta vicina storicamente, politicamente e culturalmente al mondo anglosassone. Detto questo, Brexit resta un cantiere incompiuto, mal negoziato dal governo britannico e ancora mal digerito. Ciò non toglie che l’UE e la Gran Bretagna hanno comunque bisogno l’una dell’altra.
La seconda serie di avvenimenti riguarda la risposta alle ricorrenti crisi economiche: prima quella finanziaria, poi quella dovuta alla pandemia, infine quella che si annuncia in seguito alla guerra in Ucraina. È noto quanto il percorso sia stato accidentato. È cominciato con l’illusione che si potesse fare interamente affidamento sulla sacralità e l’automatismo delle regole, per poi proseguire con i gravi errori della “passeggiata di Deauville” fra Merkel e Sarkozy, nella risposta accidentata e a momenti drammatica alla crisi greca, al “Whatever it takes” di Mario Draghi, alla creazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), all’ammissione da parte della Commissione Juncker che le regole dovevano essere interpretate e applicate con flessibilità, alla sospensione delle regole stesse durante la pandemia, fino al tabù infranto dell’indebitamento comune con il Next Generation EU. Nessuna persona sana di mente potrebbe sostenere che la risposta dell’Unione sia stata in ogni momento tempestiva e brillante. Tuttavia, l’UE e l’euro hanno tenuto di fronte alla prova forse più difficile dall’inizio della costruzione europea. A ciò si è aggiunta la decisione di fare della transizione climatica il progetto destinato a definire la strategia economica dell’UE per i prossimi anni.
Il terzo avvenimento è la pandemia. In partenza, l’UE era sprovvista di competenze e mandato chiaro in materia sanitaria. La risposta dell’Europa è stata all’inizio confusa e frammentata con manifestazioni di egoismo nazionale che hanno fatto temere il peggio. Poi, con sorprendente rapidità, la situazione è stata raddrizzata, è stato varato un programma comune di sviluppo e approvvigionamento di vaccini. Alla distanza, la risposta dell’Europa alla pandemia non è stata peggiore e sotto vari aspetti è stata migliore di quella degli USA e di molti paesi asiatici, Cina compresa. Poi, la crisi forse più importante di tutte, l’aggressione della Russia all’Ucraina. Anche questa volta, la rapidità con cui si è trovata l’unità dell’Europa e della NATO è sorprendente per quanto riguarda sia la durezza delle sanzioni sia l’invio di armi sempre più pesanti. Infine, la crisi a cui è stata data la risposta più insufficiente: quella di una pressione migratoria senza precedenti dall’Africa e dal Medio Oriente. Per un’organizzazione che, secondo il suo creatore Jean Monnet, è destinata a “progredire nelle crisi”, il minimo che si può dire è che siamo stati ben serviti.
L’evoluzione dell’UE non è stata solo guidata dagli avvenimenti così sommariamente descritti, ma anche da un contesto internazionale profondamente mutato. La costruzione europea è il prodotto più compiuto della concezione dei rapporti internazionali sviluppata dagli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale: quella di un mondo non dominato da rapporti di forza, ma da un sistema di regole accettate e condivise. Un mondo “kantiano”, o se vogliamo “post westfaliano”. Questa visione del mondo coincideva con quella che l’Europa aveva di sé stessa: una “potenza gentile”, nata da un desiderio di pace, che non aveva bisogno di una grande forza militare e che poteva espandere la sua influenza attraverso la sapiente elaborazione di regole. Regole che si sarebbero imposte per la loro saggezza ed efficacia, ma anche perché erano la porta d’accesso al più grande mercato del mondo. Poco importa se dietro questa concezione ci fosse una notevole dose di diniego, dal momento che la difesa dell’Europa era stata di fatto appaltata agli Stati Uniti. L’UE era così diventata il principale campione di un multilateralismo che non aveva inventato, ma aveva fortemente contribuito a costruire. Al crollo del comunismo era seguito un breve periodo di incontrastata egemonia americana, quindi occidentale, che aveva portato con sé l’illusione che quell’ordine sarebbe presto diventato globale. Sappiamo che non è andata così. Alcuni errori strategici compiuti in Medio Oriente dagli Stati Uniti, la minaccia del terrorismo islamico e soprattutto l’ascesa della Cina hanno profondamente modificato la situazione. Questa diffusa situazione di instabilità ha permesso ad alcune potenze intermedie (L’Iran, il Brasile, la Turchia e altre) di cercare di affermarsi come attori autonomi. È un’evoluzione che ha anche avuto importanti ripercussioni economiche, conducendo a una messa in discussione dei benefici della globalizzazione, o quanto meno mostrarne i limiti e la fragilità. Oggi, chi vuole promuovere il multilateralismo è sulla difensiva. L’Europa, creatura kantiana, si è così trovata confrontata a un mondo sempre più hobbesiano; una sfida che per l’UE è, prima ancora che politica, quasi ontologica.
L’Europa è ora costretta a trarre due conclusioni non facili da questo contesto internazionale. La prima è che l’emergere di una potenza come la Cina, poco rispettosa delle regole internazionali e campione di un capitalismo largamente sottoposto alla politica, non consente più di separare le questioni economiche e commerciali da quelle geopolitiche. Tanto più che anche gli Stati Uniti non esitano a usare a fini politici la loro forza economica. La seconda è che l’Europa aveva accumulato un notevole ritardo rispetto agli USA e alla Cina nella rivoluzione digitale.
Questo doppio risveglio ha introdotto nella narrativa europea alcuni concetti nuovi: quello di dimensione geopolitica dell’azione dell’UE e quello di “autonomia strategica”. Il secondo in particolare, lanciato nel dibattito da Emmanuel Macron, ha creato allo stesso tempo grande interesse ma anche numerosi interrogativi. Parlare di “autonomia” europea o come è anche stato fatto di “sovranità”, contiene una dose elevata di ambiguità. La moderna fisica quantistica ci dice che lo stato di una particella non può essere determinato a priori, ma dipende da quando, come e chi la osserva. Così il concetto di autonomia europea cambia a seconda che lo si guardi dall’interno o dall’esterno. Nel primo caso può voler dire che i membri dell’UE devono essere capaci di esercitare la loro sovranità in comune. Nel secondo che bisogna essere autonomi da qualcosa di diverso da noi. Questa seconda discussione si è immediatamente concentrata sulle conseguenze per il rapporto con gli Stati Uniti e con la NATO. Si tratta di una delle questioni più divisive del dibattito europeo che ha il potenziale di paralizzare tutto il resto.
Sulla base di quanto precede, è interessante ora vedere non tanto la bontà e i difetti di ciò che è stato fatto, ma piuttosto quanto tutto ciò ha modificato i rapporti di forza all’interno dell’UE, il suo modo di operare, i suoi interessi strategici e la sua identità. Quei recenti, drammatici avvenimenti hanno tra l’altro condotto a superare o addirittura a smentire un certo numero di analisi su cui erano basati sia consensi dati per acquisiti, sia dissidi a volte difficili da sanare.
La prima questione riguarda i valori fondanti. L’Unione Europea è un’organizzazione che comprende paesi che, pur con strutture costituzionali diverse, condividono gli stessi valori democratici, liberali e il rispetto dello stato di diritto. Tuttavia, non essendo una compiuta unione politica, non dispone degli strumenti per imporne il rispetto dai suoi membri. Fino a tempi recenti ciò era considerato implicito, al punto che il principio di supremazia del diritto europeo su quelli nazionali era basato sul presupposto che la Corte di Giustizia europea avrebbe “per definizione” rispettato nei suoi giudizi i diritti fondamentali che sono alla base delle costituzioni degli stati membri. L’esperienza con i nuovi membri dell’est ha scosso questo equilibrio. Il cammino verso una compiuta democrazia liberale si è rivelato per alcuni di loro (Polonia e Ungheria ma non solo) più accidentato del previsto. Ne sono risultate alcune gravi anomalie nel rispetto ai principi dello stato di diritto che sono mal percepite dall’opinione pubblica degli altri paesi la quale non capisce perché si possano sanzionare mancanze molto meno gravi e non veri attentati alla democrazia. Il problema è che gli strumenti di cui l’UE dispone per combattere le deviazioni sono molto deboli, essenzialmente di natura finanziaria, e difficili da usare quando i paesi “devianti” sono più d’uno.
La seconda questione riguarda l’idea di un’Unione irrimediabilmente divisa da un dissidio fra liberisti (o ordoliberisti) da una parte e keynesiani e interventisti dall’altra; come è stato anche detto, fra cicale e formiche. Questa supposta frattura, ha assunto il carattere di una lacerazione nord-sud. A parte il fatto che fra il “liberismo” e l’ordo-liberismo prevalente in Germania e in gran parte dell’Europa ci sono colossali differenze e che i sacerdoti di Francoforte si trovano difficilmente a loro agio a Chicago, la gestione concreta della crisi ha permesso di de-ideologizzare il dibattito. Nessuno sembra più pensare che le regole siano per definizione né sacre (come vorrebbero alcuni) né “stupide” (come le aveva definite Romano Prodi, allora Presidente della Commissione). Inoltre la creazione di strumenti di solidarietà come il MES e Next Generation EU, pur senza rappresentare il “momento Hamiltoniano” rivendicato da alcuni, costituiscono un’innovazione di cui nessuno può sottovalutare l’importanza. Allo stesso modo, affrontare il ritardo che si è creato nella rivoluzione digitale e la contemporanea sfida di un mondo in cui le regole multilaterali sono messe sempre più in discussione, richiede un ruolo dell’intervento pubblico maggiore di quanto si considerava auspicabile fino a poco tempo fa. L’atteggiamento verso la globalizzazione, in particolare a causa della fragilità delle filiere di produzione, è sottoposto a revisione. Su queste questioni, tradizionalmente oggetto di forti contestazioni, si constata una notevole convergenza anche fra due paesi tradizionalmente su fronti opposti come Francia e Germania. D’altro canto, è anche chiara la percezione che fra le grandi aree economiche l’UE è quella che più dipende dal commercio internazionale e non può quindi isolarsi dal resto del mondo. Nonostante la sua dimensione e l’attrattiva del suo mercato, non può nemmeno illudersi di poter regolare in piena libertà tecnologie che non possiede. Nessuno quindi pensa che ciò possa significare il ritorno a forme di politiche industriali simili a quelle praticate in Francia, in Italia e altrove fino agli anni ’80 del secolo scorso.
Le questioni che seguono riguardano il superamento della distinzione fra dimensione economica e strategica dell’integrazione; quindi il concetto di Europa “geopolitica”, o di autonomia strategica. La politica estera, grande assente nel disegno iniziale di Jean Monnet, ha fatto prepotentemente irruzione nel dibattito europeo. Il caso più importante, quello che ci obbliga al più grande ripensamento, sono i rapporti con la Russia alla luce dell’aggressione all’Ucraina. Dopo il crollo dell’URSS era prevalsa in Occidente la speranza che anche la Russia potesse, se non diventare compiutamente democratica e occidentale, almeno avere un’evoluzione compatibile con un ordine europeo stabile e consensuale. Soprattutto dopo l’avvento di Putin al potere i segnali di involuzione, troppo noti per enumerarli tutti si erano moltiplicati. Tuttavia molti paesi europei, soprattutto Germania, Francia e Italia avevano preferito decidere che il dialogo con Mosca restasse prioritario; sposavano così la teoria tedesca del Wandel durch Handel, il cambiamento attraverso il commercio. In altri termini, legare a noi la Russia sul piano economico ne avrebbe facilitato un’evoluzione nella direzione auspicata. Ne è seguita una dipendenza massiccia dalle importazioni di idrocarburi dalla Russia. In questa ottica, un’invasione dell’Ucraina era considerata improbabile se non impossibile.
A questa narrativa se ne contrapponeva un’altra, portata soprattutto dai paesi baltici, dalla Polonia e da altri paesi dell’est. Secondo questa analisi gli “aperturisti”, obnubilati dal loro illuminismo, avevano gravemente torto. La deriva adottata da Putin aveva invece radici profonde. L’obiettivo era di ristabilire un’identità russa libera da corruzioni occidentali e basata su un nazionalismo allo stesso tempo etnico, territoriale e religioso che si rifaceva alle radici autocratiche, ortodosse e imperiali della storia russa. L’ostilità ai valori occidentali intesi come la principale minaccia al ritorno della Russia alle sue radici, era quindi irriducibile. In questa ottica, la Russia non era solo un partner difficile, ma una minaccia concreta. Ristabilire il controllo sulle antiche repubbliche della Georgia, della Moldavia e soprattutto dell’Ucraina non era solo un modo per ristabilire una sfera imperiale, ma anche per difendersi dalla contaminazione da eventuali evoluzioni democratiche e occidentali di quei popoli. Questo è del resto il vero senso dell’ossessiva, quasi paranoica, opposizione all’allargamento della NATO.
La risposta degli altri europei fu di comprendere i timori storici della Polonia e degli altri, ma di considerarli anche con un po’ di condiscendenza eccessivamente estremisti. Per calmare le loro paure, si favorì l’ingresso nella NATO e nell’UE, ma per il resto continuò l’atteggiamento di diniego della minaccia. Persino Angela Merkel, che pure aveva di Putin una visione molto lucida, scelse di non modificare sostanzialmente la politica tedesca e europea. Nemmeno l’espansione della Russia nel Medio Oriente, nel Mediterraneo e in Africa condusse a sostanziali ripensamenti. Questa risposta insufficiente, concretizzata nella reazione velleitaria e ambigua alla richiesta di Ucraina e Georgia di adesione alla NATO, consolidava la convinzione di Putin della decadenza e divisione dell’occidente. D’altro canto gli permise di eccitare ancor più i sentimenti nazionalisti all’interno con la tesi dell’accerchiamento dovuto all’allargamento della NATO e delle umiliazioni inflitte alla Russia dai vincitori della guerra fredda.
Oggi è doveroso ammettere che la Polonia e i suoi amici avevano ragione e la maggior parte degli altri paesi avevano torto. Il risultato è la guerra a cui stiamo assistendo. Non è qui il posto adatto per analizzarne gli sviluppi. Basterà costatare che la combinazione delle insufficienze militari dell’esercito russo, delle terribili atrocità commesse, della imprevista capacità di resistenza degli ucraini, e della altrettanto sorprendente risposta unitaria dell’occidente e dell’Europa, rendono un negoziato di pace molto improbabile nel prevedibile futuro. Resta la possibilità di una tregua provvisoria e precaria, inevitabilmente seguita da una lungo periodo di tensione che da molti punti di vista sarà non dissimile dalla guerra fredda. La prospettiva di un nuovo e condiviso sistema di sicurezza europea, è realisticamente tramontata. Per questo sarà necessario che cambi quello che è diventato l’equivalente russo del Sonderweg tedesco, l’ossessiva ricerca di un’identità speciale distinta e in opposizione all’occidente. Permane però, come ai tempi della guerra fredda la necessità di un sistema di regole del gioco condivise per evitare che il conflitto latente si trasformi in conflitto aperto.
Ne discendono un certo numero di conseguenze. Putin è stato fermato, oltre che dall’eroismo degli ucraini e dai suoi stessi errori, dall’unità dell’occidente. Il rapporto fra NATO e autonomia europea ne risulta profondamente modificato. È infatti stato dimostrato aldilà di ogni possibile dubbio che non esiste, oggi e per un avvenire prevedibile, una risposta militare efficace dell’Europa al di fuori della NATO. Uno sviluppo confermato e rafforzato dalla storica decisione di Finlandia e Svezia di aderire all’alleanza. È stata comunque clamorosamente smentita la favola di un’America che voltava le spalle all’Europa per pensare solo al Pacifico. D’altro canto però si è anche visto che l’unità dell’Europa è indispensabile per rafforzare l’efficacia della risposta occidentale. Il mantenimento dell’impegno americano in Europa dipende oggi anche da un concreto rafforzamento dell’impegno europeo. Senza l’UE, sanzioni di quella portata non sarebbero state possibili.
Se l’unità dell’occidente è dunque fondamentale, nasce spontanea la domanda se il tempo giochi a favore nostro o di Putin. A medio termine, gioca sicuramente a nostro favore. Le sanzioni mostrano infatti di avere pesanti effetti sull’economia russa e quindi anche sulla sua capacità militare. A breve termine la risposta è meno certa, anche perché le sanzioni hanno bisogno di tempo per operare e una sconfitta militare della Russia sul campo non è ipotizzabile. Il consenso intorno alla strategia adottata dall’occidente è al momento solido, anche perché in assenza di serie prospettive di tregua non ha alternative. Tuttavia la situazione in alcuni paesi importanti come l’Italia e la Francia è fragile a causa di una forte polarizzazione politica interna. Anche la posizione tedesca presenta ancora elementi di incertezza. Assistiamo quindi al paradosso di paesi che, pur sostanzialmente sulla stessa linea, adottano retoriche pubbliche a volte divergenti e comunque ambigue. Ciò è visibile soprattutto in Italia e in Francia, ma anche in Germania. Adattare il discorso alle condizioni politiche locali fa parte del realismo politico. In questo caso tuttavia, l’opinione pubblica può essere indotta a dubitare dell’unità dell’occidente, o addirittura a convincersi che l’ostacolo alla tregua sta da noi e non a Mosca. Un cedimento del consenso interno in alcune importanti nazioni europee avrebbe effetti potenzialmente devastanti non solo per l’unità dell’Europa, ma anche per le prospettive della sicurezza e della pace. L’unità dell’occidente è quindi oggi un bene supremo da preservare, sia per convincere Putin dell’inanità delle sue minacce, sia per consolidare il consenso della nostra opinione pubblica. È uno sforzo che richiede da parte di tutti collaborazione nel linguaggio e nei comportamenti.
Il principale pericolo per il mantenimento dell’unità dell’occidente e dell’Europa, il fattore che più di altri può compromettere il consenso interno, è di natura economica e sociale. Il conflitto ci impone allo stesso tempo di accelerare il disimpegno dalla dipendenza dagli idrocarburi russi e la transizione climatica, ma senza compromettere le fragili possibilità di ripresa economica che si intravedevano prima della crisi. Si tratta di una sfida, aggravata da forti tensioni inflazioniste, che richiede un impegno eccezionale nazionale e collettivo dei paesi europei. L’architettura stessa del governo della moneta e dell’economia ne sarà condizionata.
Un’altra conseguenza del conflitto è di aver posto in termini nuovi il problema dello sforzo specificamente europeo per la difesa comune. In questo caso, il principale attore di cambiamento è la Germania che ha annunciato una Zeitenwende, una svolta epocale nel suo atteggiamento verso le spese militari. Questa svolta, sia pure accompagnata da esitazioni e ambiguità tipiche del funzionamento del sistema politico tedesco, permette per la prima volta di dare un senso concreto e urgente alla prospettiva di una difesa europea. Prospettiva tanto più concreta che la svolta tedesca vuole esplicitamente conciliare impegni europei e impegni atlantici. Anche in questo caso, la tecnologia ha cambiato i termini della questione. Per gli europei non si tratta tanto o solo di costruire in comune qualche aereo o qualche sottomarino, ma di prepararsi a conflitti ibridi che smentiscono l’antico detto di Cicerone: inter pacem et bellum nihil medium, non c’è nulla fra la pace e la guerra. Conflitti quindi che possono rappresentare un continuo fra disinformazione, provocazioni di varia natura, sanzioni economiche, hackeraggio, uso militare delle tecnologie spaziali e dell’intelligenza artificiale, fino all’uso delle tecnologie militari classiche e dell’arma nucleare. Una prospettiva che modifica profondamente anche il concetto di deterrenza.
Molto è stato scritto sul fatto che la NATO ha riunito importanti alleati fuori delle sue frontiere (Giappone, Australia e altri ancora), ma che un gran numero di paesi emergenti hanno dichiarato la loro neutralità. Questo fenomeno è in realtà naturale e comprensibile. Anche durante la guerra fredda gran parte dell’umanità era neutrale. Essere neutrali in questo caso non vuol dire schierarsi a favore della Russia e tanto meno della Cina; semplicemente, questa “non è la loro guerra”. Tra l’altro le motivazioni di questa posizione sono molto dissimili, per esempio fra asiatici, africani o latino americani. Ciò non toglie che si tratta di motivazioni di cui dobbiamo tenere conto, per esempio facendo il massimo sforzo per far fronte alla penuria alimentare che il conflitto ucraino rischia di provocare in parti dell’Africa.
Di particolare importanza sono le motivazioni dei pasi asiatici, per esempio dell’India, che sono naturalmente determinate più che dal conflitto in sé dal ruolo della Cina. Per molti paesi dell’area e per gli Stati Uniti, il conflitto in Ucraina è anche una metafora del problema di Taiwan. L’alleanza fra la Russia e la Cina non è stata provocata da noi. È il prodotto della naturale convergenza fra due grandi paesi la cui politica è nutrita da un forte nazionalismo, dal rifiuto dei valori occidentali e dalla volontà di sovvertire l’ordine e le regole che l’occidente ha stabilito nel corso dei decenni passati. La convergenza è quindi basata su ragioni oggettive. La “questione cinese” rappresenta il fallimento dell’altra grande illusione di un mondo che, grazie a commerci liberi e aperti, si riunirebbe facilmente attorno al multilateralismo e ai valori occidentali. Tuttavia gli interessi di due attori come Russia e Cina che sono peraltro in un rapporto molto squilibrato fra loro, coincidono solo in parte. La prova è che il sostegno cinese all’aggressione russa è stato finora poco più che verbale e alcuni sperano che la Cina possa avere un ruolo attivo nella ricerca di una tregua. La realtà è che per molti attori asiatici e per gli americani, il confronto con la Cina resta la sfida che caratterizzerà più di ogni altra il corso del secolo. Per quanto riguarda l’Europa, una conseguenza importante è che non possiamo più considerare i teatri europeo e asiatico come completamente distinti. Non possiamo nemmeno continuare a considerare la “questione cinese” sotto un angolo unicamente economico e commerciale. Ciò si aggiunge alla lista dei dinieghi europei che devono essere superati; ciò vale soprattutto per la Germania, ma non solo. Ugualmente velleitaria sarebbe la tentazione di volersi porre come mediatori fra Cina e USA. Realizzare una politica unitaria verso la Cina è però ancora più difficile che verso la Russia.
Un’altra conseguenza del conflitto in Ucraina è il flusso di qualche milione di rifugiati, in prevalenza donne e bambini, verso l’Europa. Si tratta di cifre senza precedenti, come senza precedenti è la reazione di apertura e di accoglienza di molti membri dell’UE. Resta da vedere se questa grande manifestazione di solidarietà che contrasta con il permanente atteggiamento di chiusura verso l’immigrazione dall’Africa e dal Medio Oriente, faciliterà il raggiungimento di un maggiore consenso europeo sulla politica migratoria.
Le questioni che precedono hanno in comune la caratteristica di porre in termini nuovi problemi che già esistevano e di porre tutte con forza la necessità di un rapporto stretto con gli Stati Uniti, allo stesso tempo sul piano strategico ed economico. Fra le due rive dell’Atlantico ci sono inevitabili divergenze di percezione e di interessi contingenti, ma esse si manifestano all’interno di una sostanziale convergenza strategica allo stesso tempo sui valori e sugli interessi. Le condizioni attuali dei rapporti transatlantici sono le migliori da moltissimo tempo. Lo sforzo di dialogo dell’amministrazione Biden è innegabile. Anche la politica francese, forse il partner europeo più difficile da questo punto di visto ha subito una notevole evoluzione. È interessante esaminare l’evoluzione della retorica macroniana, dalla constatazione di “morte cerebrale” della NATO fino a una gestione della crisi ucraina in sostanziale coordinamento con gli alleati. Tuttavia permane in Europa una forte diffidenza verso l’affidabilità degli USA, alimentata dall’esperienza traumatica della presidenza Trump, ma anche da incertezze o errori della politica americana che datano da ben prima di Trump. Il timore di un secondo Trump è a volte agitato da parte dei nemici europei dell’unità occidentale come una profezia di cui in fondo si auspica la liberatoria realizzazione. Speculare a tutto ciò è una diffusa diffidenza americana verso l’affidabilità degli alleati europei. Si tratta quindi di convincere gli americani che non potranno affrontare il mondo turbolento che si prepara senza l’apporto europeo. Per gli europei si tratta invece di capire che autonomia non vuol dire distacco, ma piuttosto l’emancipazione di un partner diventato adulto. Sul piano economico, entrambi i partner dovrebbero prendere coscienza che, mentre la tendenza alla globalizzazione resterà forte, un certo grado di disconnessione tecnologica dalla Cina è ineluttabile ed è del resto già in atto. Né gli USA, né l’Europa, né i nostri alleati in Asia sono in grado di realizzare da soli la regolamentazione di cui internet ha bisogno o la riorganizzazione delle filiere di produzione e approvvigionamento di alcune componenti critiche. Una vera convergenza strategica non sarà né facile né automatica. Per realizzarla e mantenerla ci vorrà un costante sforzo di dialogo e di volontà politica. Sviluppando anche strumenti di coordinamento permanente che in parte si stanno creando come per esempio il Trade and Technology Council, ma che per il momento esistono in modo solo parziale.
Ciascuna delle sfide di cui abbiamo parlato porrebbe di per sé problemi formidabili a un sistema fragile e imperfetto come quello dell’UE. Tutte insieme possono sembrare insormontabili. Esse sono però largamente interconnesse: affrontarne una aiuterà a trattare le altre. Se l’evoluzione degli avvenimenti ha profondamente modificato i termini di molti problemi e rende possibili convergenze prima considerate impossibili, bisogna ora vedere quanto l’UE sia preparata a rispondere concretamente a tutte queste sfide. La prima risposta spontanea è negativa. La struttura istituzionale resta barocca e poco comprensibile dall’opinione pubblica e troppe decisioni importanti richiedono il consenso unanime degli stati membri. In queste condizioni, realizzare in tempi rapidi un consenso a 27 è spesso estremamente difficile.
Una difficoltà spesso sottovalutata è l’assenza di un vero dibattito politico europeo. Mai come oggi sarebbe necessario non solo che le autorità spieghino senza compiacenza la verità all’opinione pubblica, ma anche che lo facciano in modo coerente con i partner europei. La “Convenzione” che si è appena conclusa e che ha organizzato il dibattito fra qualche centinaio di cittadini europei, costituisce un tentativo generoso e utile, ma dimostra anche i limiti dell’esercizio. È stato detto che gli Stati Uniti hanno cominciato a esistere come entità politica solo nei primi decenni dell’800, quando la tecnologia ha reso possibili la stampa di giornali a grande diffusione. Oggi la tecnologia non è certo un problema. Il principale ostacolo al dibattito transnazionale sono le barriere linguistiche che rafforzano il carattere nazionale della politica. Quel tanto di dibattito transnazionale che pure esiste è per definizione limitato a un’élite. Per esempio, sarà necessario spiegare in modo coerente all’opinione pubblica le ragioni e i limiti della nostra politica di contrasto all’aggressione russa, ma anche che accelerare il disimpegno dalla dipendenza dagli idrocarburi russi, richiede qualche arbitrato difficile con la strategia di transizione climatica. Ciò è tanto più importante dal momento che la guerra attuale avviene in parte anche sul terreno dell’informazione e della disinformazione. Il modo con cui si sviluppa il confronto politico in Europa è anche molto diverso. In alcuni paesi, soprattutto a sud e in quelli in cui la politica è più polarizzata, le questioni tendono a essere discusse in termini di alternative radicali, di cambi di paradigma. In altri, soprattutto a nord, le scelte sono discusse in termini di cambiamenti incrementali. Abbiamo assistito a una campagna elettorale francese che contrapponeva radicali scelte di società, preceduta da una campagna elettorale tedesca in cui Scholz, candidato dell’opposizione, si presentava come un continuatore… di Angela Merkel con la quale peraltro governava fino a prima delle elezioni.
Tutto ciò conduce a riaprire una discussione sulle istituzioni europee che era sopita dopo il fallimento dei referendum francese e olandese sul progetto di “costituzione”. Le questioni da discutere sono molte, ma la più importante è sicuramente quella dell’esigenza di unanimità che ancora esiste per materie importanti come la politica estera, la difesa e la fiscalità. Leader importanti come Macron e Draghi ne hanno ufficialmente chiesto l’abbandono. La difficoltà più grande in Europa resta sempre quella di riunire una maggioranza, ma è innegabile che il diritto di veto può paralizzare o comunque ritardare decisioni importanti. Basti pensare ai problemi ora posti dall’Ungheria. In un’organizzazione come l’UE che riunisce stati sovrani prevarrà sempre il riflesso di ricercare il consenso, ma la possibilità concreta di votare cambia completamente la strategia negoziale di tutti gli attori perché spinge ad anticipare la ricerca dei compromessi che consentono di far parte di un’eventuale maggioranza. Questa riforma sarebbe quindi altamente auspicabile ed è bene che la discussione cominci. Bisogna tuttavia essere coscienti che le prospettive di progresso a breve termine sono modeste. Non solo la questione è per definizione controversa, ma la reticenza a lanciarsi in una nuova operazione di riforma dei trattati è ancora molto diffusa. Non si tratta solo di cattiva volontà. Alcune delle materie per cui si dovrebbe poter votare, sono vicine al cuore della sovranità dei nostri paesi. Anche se non ottimali e a volte complicati da attuare, i modi per aggirare i veti esistono e ne conosciamo diversi esempi. Alcuni sono molto importanti, come Schengen e l’euro. E’ una pratica di cui sono state date definizioni diverse; le più comuni sono geometria variabile e differenziazione. Almeno finché l’UE non avrà raggiunto una forma stabile di unione politica compiuta, questo resterà uno dei percorsi principali per far progredire l’integrazione: l’azione di avanguardie che mostrano il cammino, pronte in seguito ad accogliere i ritardatari. Tuttavia, l’esperienza di Brexit dovrebbe averci insegnato che la pratica della geometria variabile è per definizione precaria, difficile da gestire e non può durare eternamente. Prima o poi, la scelta fra ricomposizione e rottura non potrà essere evitata.
Le cose si complicano quando si vuole trasformare questo modo di procedere, da pragmatico in strutturale. È la teoria dei cosiddetti “cerchi concentrici” per cui i paesi membri dell’UE si raggrupperebbero in cerchi caratterizzati, dall’esterno verso l’interno, da gradi maggiori d’integrazione; ognuno essendo dotato di una propria struttura istituzionale, aperta ma distinta. Ne parliamo qui perché alcuni ne hanno voluto vedere tracce nel discorso di Macron a Strasburgo. Si tratta di un’idea intellettualmente attraente, ma densa di pericoli che possono condurre a gravi fratture. Per prima cosa, l’idea di cerchi concentrici non corrisponde alla realtà delle cose. Se prendiamo quelli più importanti, Schengen, l’euro, le cooperazioni rafforzate in materia di difesa, definire un nucleo centrale sulla base di uno di essi sarebbe impossibile perché, se di cerchi si tratta, essi si intersecano piuttosto che sovrapporsi. Inoltre, la gestione del mercato unico, che per definizione dovrebbe comprendere l’intero cerchio esterno dei 27, non è una zona di libero scambio che funziona da sola, ma un insieme integrato cha ha bisogno di essere governato politicamente, giuridicamente e finanziariamente. La sua gestione non è facilmente separabile da, per esempio, quella dell’euro o dalla decisione di applicare sanzioni economiche a paesi ostili. Se non si vuole che l’Unione vada incontro a fratture insanabili, è quindi necessario che la differenziazione sia gestita da una struttura istituzionale unitaria.
Ci sono però ragioni più profonde che incitano alla prudenza. L’Unione ha bisogno di un motore. Per molto tempo si è pensato che dovesse essere la coppia franco-tedesca. Essa resta essenziale, ma ormai lungi dall’essere sufficiente. Tutto il sistema è diventato politicamente molto più complesso e sarebbe pericoloso sottovalutare le spinte centrifughe. Sappiamo tutti che durante la crisi dell’euro si è creata una forte tensione nord-sud. Sappiamo anche che molti a nord delle Alpi hanno a lungo pensato che un euro liberato dal peso delle cicale meridionali sarebbe stato più stabile e sicuro. La svolta è avvenuta quando, posti di fronte a un dilemma concreto, si è deciso di resistere alla tentazione che pure esisteva di escludere la Grecia dall’euro. Oggi, uno dei pochi punti di consenso unanime a proposito del governo dell’economia è che le soluzioni e i compromessi devono tener conto degli interessi e delle esigenze, non solo di tutti i membri dell’euro ma anche di quelli che ancora non ne fanno parte. Il senso politico della recente presentazione di un documento ispano-olandese non è sfuggito a nessuno. Non sarà facile, ma alcuni sviluppi fanno pensare che una nuova iniziativa volta a finanziare in comune la risposta alle nuove sfide come la transizione energetica e il rinnovato sforzo a rafforzare la difesa europea, possa maturare in tempi non troppo lunghi.
La dimensione est/ovest è più complicata. A suo tempo tutti giudicarono l’allargamento a est come il naturale complemento della fine della guerra fredda e il ricongiungimento in nome della democrazia di due parti dell’Europa artificialmente separate. Mentre sul piano economico l’operazione può essere considerata un successo, sul piano politico il cammino è stato molto più accidentato. Il modo tradizionale e un po’ burocratico con cui era stato affrontato il processo di allargamento, aveva sottovalutato le difficoltà politiche di integrazione per popoli la cui tradizione democratica era più fragile e recente di quella della parte occidentale del continente. Popoli inoltre per cui il nazionalismo non era tanto percepito come un male da superare, ma spesso come un valore da conservare perché simbolo di una libertà ritrovata. Ci eravamo dimenticati che quell’arco di popoli che va dal Baltico all’Adriatico è il luogo in cui sono nate due guerre mondiali e avvenuti alcuni degli orrori più atroci della nostra storia. Una storia la loro condizionata da un costante conflitto fra il mondo germanico, quello ottomano e quello russo.
Quando abbiamo scoperto che l’integrazione era molto più complicata del previsto, abbiamo ascoltato le spiegazioni di alcuni intellettuali come Ivan Krastev che cercavano di educarci alla complessità e alle contraddizioni delle vicende di quei popoli e ai pericoli che rappresentavano anche per noi occidentali, ma lo abbiamo fatto con condiscendenza e un po’ di fastidio. In fondo, ci dicevamo, quella gente deve solo adeguarsi. Ci siamo comportati come in Italia quei piemontesi e lombardi che, dopo il 1860, hanno creduto che l’impresa di Garibaldi volesse solo dire una nazione più grande e non anche profondamente diversa. L’aggressione russa all’Ucraina suona il risveglio. Non è più possibile concepire una politica verso la Russia, oggi il nostro principale test di politica estera, senza prendere pienamente in conto ciò che pensano i baltici, la Polonia, altri paesi dell’est e anche gli scandinavi.
Una difficoltà dello stesso genere si presenta per la gestione della lunga lista di paesi nei Balcani occidentali, a cui si aggiungono ora Ucraina, Moldavia e Georgia, che sono candidati all’adesione. Non c’è dubbio che la lezione degli errori compiuti nell’ultimo allargamento debba essere oggetto di attenta riflessione. I tempi interminabili obbiettivamente richiesti dalla complessità dei problemi concreti, si scontrano con aspettative emotive sempre più forti che rischiano di produrre ingranaggi infernali che non consentono di affrontare i problemi più importanti che sono quelli politici. Un paio di anni fa, su iniziativa della Francia, si era deciso di adottare un metodo diverso, più flessibile e progressivo che mettesse in primo piano la gestione politica dell’adesione e rendesse possibile graduare le forme di appartenenza all’UE secondo il grado di maturazione politica ed economica. Un processo allo stesso tempo incentivante e reversibile. Era sicuramente la strada giusta.
Nel discorso di Strasburgo, Macron ha proposto di dare a ciò anche una veste istituzionale con la creazione di una forma di “Comunità politica”, una specie di cerchio esterno dell’UE. Il valore simbolico di questa proposta, che in Italia è formulata anche da Enrico Letta, è innegabile. Prima di intraprendere quella strada vale però la pena di chiederci quali sono i reali vantaggi di sovrapporre una struttura istituzionale comune a un processo politico necessariamente differenziato. All’atto pratico, essa rischia di essere la tipica “cattiva buona idea” e di comportare più inconvenienti che vantaggi. Un’istituzione richiede una lunga discussione sulle sue strutture e rischia rapidamente di diventare una macchina pesante e burocratica. L’esperienza della “Unione del Mediterraneo” avrebbe dovuto insegnarci qualcosa. Più seri sono i rischi politici. I paesi candidati sono quasi tutti in condizioni, con aspirazioni e problemi molto diversi fra loro. Un’istituzione comune contiene implicitamente la domanda di gestirli in modo unitario e coordinato. Bastano due esempi per illustrare i pericoli. Cosa si fa con la Turchia, paese importantissimo ma sappiamo quanto difficile per l’Europa? La sua candidatura è forse la più antica, ma tutti da Ankara a Stoccolma sanno che non ha ormai nessuna probabilità di arrivare a compimento. Come è possibile mettere nella stessa istituzione, che si vuole per definizione “politica”, l’Ucraina e la Serbia storicamente alleata e ancora oggi molto vicina alla Russia?
Abbiamo detto che la coppia franco-tedesca resta essenziale per fare avanzare l’Europa. Dopo un lungo periodo di un processo guidato dalla prudenza tedesca, un po’ di decisionismo francese non guasta. Tuttavia la leadership non richiede solo di indicare gli obiettivi, ma anche e soprattutto acquisire il consenso per realizzarli. Bisogna prendere atto che la difficoltà di conciliare il valore supremo dell’unità dei 27 con la possibilità di permettere ad alcune avanguardie di progredire, è più grande che in passato. La crisi dell’euro ha fatto riscoprire la necessità di dare spazio anche ad altri grandi paesi come l’Italia e la Spagna; ma anche questo non basta. Come abbiamo detto, la crisi ucraina rende impossibile una politica estera in cui la Polonia e i baltici non abbiano un ruolo centrale. Questa nuova centralità della Polonia, obiettivamente non facile da gestire, comporta però il vantaggio di introdurre un cuneo importante fra Polonia e Ungheria, i due principali problemi per la questione dello stato di diritto.
Non è ormai nemmeno più possibile pensare solo in termini di “grandi paesi”. Aggregazioni come il gruppo dei cosiddetti “frugali” che va dall’Olanda agli scandinavi fino all’Austria, non è solo come alcuni pensano con fastidio e disprezzo un’escrescenza del rigorismo tedesco, ma la manifestazione di una volontà di esistere. A fronte di questa complessità, si leggono invece sui media analisi di suprema arroganza che, riferendosi a Germania, Francia, Italia e Spagna, parlano “dell’Europa che conta”. La prudenza tedesca nell’era di Angela Merkel era a volte eccessiva, ma era anche ispirata dalla consapevolezza imposta dalla storia e dalla geografia di quanto sia necessario tener conto di tutte le variabili del gioco europeo. Sarebbe bene che un po’ di questo senso della complessità attraversasse il Reno e le Alpi per approdare anche a Parigi e a Roma. In Europa, la leadership è come uno spazzaneve. In caso di forte nevicata, se lo spazzaneve non c’è o va troppo lentamente, la neve si accumulerà e la strada resterà bloccata. Se però la velocità con cui lo spazzaneve si muove è superiore alla potenza con cui riesce e a liberare il terreno, resterà intrappolato lui stesso.