Domenica 25 settembre si terranno in Italia le elezioni politiche. Stando ai sondaggi, è molto probabile che alle urne prevalga la coalizione di destra-centro, i cui tre partner principali sono Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi e appartenente, in Europa, al Partito popolare; la Lega, il cui segretario federale è Matteo Salvini e che è iscritta a Strasburgo al gruppo “populista” di Identità e Democrazia; Fratelli d’Italia, partito presieduto da Giorgia Meloni, che aderisce ai Conservatori e Riformisti. Sempre secondo i sondaggi, Fratelli d’Italia potrebbe arrivare a valere più della somma dei suoi due alleati. Poiché Meloni insiste molto sul profilo ideologico conservatore del proprio partito, se le elezioni dovessero andare come da pronostico uno dei paesi più popolosi dell’Unione Europea, protagonista fin dall’inizio del processo d’integrazione continentale, si troverebbe ad avere un governo a trazione conservatrice.
Nelle pagine che seguono s’intrecciano tre diverse riflessioni, a ciascuna delle quali è dedicato un paragrafo: quale significato possa mai avere il conservatorismo nella nostra epoca; come si siano trasformate le forze politiche di destra negli ultimi trent’anni; come siano cambiati il sistema politico italiano e i rapporti fra l’Italia e l’Europa dopo il 1989. Tirando le fila dei tre ragionamenti, il quarto e ultimo paragrafo s’interroga sulle possibili conseguenze, per l’Italia e l’Unione Europea, dell’eventualità che, all’indomani delle elezioni, nasca nella Penisola un governo di destra.
Non si dà conservatorismo senza una sensibilità acuta nei confronti della continuità temporale: la convinzione che dal passato ci giunga una tradizione che può sì essere modificata, ma che ha comunque dimostrato il proprio valore resistendo al tempo e che deve quindi essere maneggiata con grande rispetto e cautela, e tramandata ai posteri.
giovanni orsina
Dell’impossibilità e indispensabilità del conservatorismo oggi
È difficile, nel 2022, non pensare che lo sforzo bisecolare del conservatorismo per arrestare, o almeno rallentare, l’avanzata della modernità sia fallito, e che oggi il conservatorismo sia perciò diventato, molto semplicemente, impossibile. Non intendo certo affrontare qui il ricco dibattito teorico sulla natura del conservatorismo. Mi pare tuttavia evidente che un’ideologia non possa dirsi conservatrice se non ha un atteggiamento robustamente scettico sulla capacità della ragione umana di comprendere e migliorare il mondo, e quindi sulla possibilità che, su questa Terra, si raggiunga mai la perfezione. Di conseguenza, se non ritiene che l’ordine politico e sociale debba essere ancorato a un “dogma minimo”: princìpi che siano accolti a priori e sottratti almeno in parte alla critica della ragione, siano essi di natura religiosa (Dio), storica (patria), o naturale (famiglia). Infine, non si dà conservatorismo senza una sensibilità acuta nei confronti della continuità temporale: la convinzione che dal passato ci giunga una tradizione che può sì essere modificata, ma che ha comunque dimostrato il proprio valore resistendo al tempo e che deve quindi essere maneggiata con grande rispetto e cautela, e tramandata ai posteri.
In Occidente, gli ultimi cinquant’anni di storia hanno spazzato via le condizioni che rendevano possibile (già comunque con grande fatica) questo modo di pensare il mondo. A partire dagli anni Sessanta del Novecento, quel che era riuscito a sopravvivere delle strutture sociali tradizionali è stato delegittimato e smantellato. I concetti sulla cui “durezza” faceva perno il pensiero conservatore sono stati sottoposti a una spietata critica logica e storica, alla quale naturalmente non sono sopravvissuti: si è scoperto che le nazioni sono delle comunità immaginate e le tradizioni delle invenzioni, che le identità individuali e collettive sono multiple e artefatte, che non c’è niente di così artificiale come la natura. Che Dio sia un figmento dell’immaginazione umana non è certo una convinzione degli ultimi cinquant’anni – Friedrich Nietzsche, com’è ben noto, ne annunciò la morte nel 1882 –, ma alla fine del ventesimo secolo i processi di secolarizzazione hanno subìto un’accelerazione impressionante. Nel frattempo l’aspirazione utopica che caratterizza la modernità non è affatto venuta meno, per certi versi si è anzi ulteriormente irrobustita – solo, ha reagito alla crisi del comunismo affidando i propri destini all’economia, alla tecnologia e al diritto invece che alla politica. La continuità temporale, infine, si è dissolta: il passato non ha più nulla da dire al presente, e di conseguenza il presente non può avere più nulla da tramandare al futuro. Tutto questo ha reso il conservatorismo insostenibile. Da qui l’atteggiamento quasi di scherno che i progressisti, non per caso egemoni nel mondo della cultura, riservano ai conservatori, accusati in buona sostanza di voler portare l’acqua col colabrodo. E da qui la sensazione che essi siano irrimediabilmente superati dalla storia, che vagheggino un impensabile oltre che indesiderabile ritorno al Medioevo.
L’aspirazione utopica che caratterizza la modernità non è affatto venuta meno, per certi versi si è anzi ulteriormente irrobustita – solo, ha reagito alla crisi del comunismo affidando i propri destini all’economia, alla tecnologia e al diritto invece che alla politica.
Giovanni orsina
Il discorso potrebbe anche chiudersi qui, se non fosse che, nel frattempo, quella stessa tarda modernità che ha reso il conservatorismo impossibile si è dimostrata a sua volta, per una parte non irrilevante dei cittadini delle democrazie occidentali, piuttosto difficile da abitare. Dopo il 1989, per un lungo decennio segnato da un certo ottimismo panglossiano, ci si è potuti illudere che fosse possibile costruire un ordine politico e sociale perfetto strutturato in forma riflessiva, ossia ripiegato e appoggiato su se medesimo: capace di fare a meno di valori assoluti, concetti “duri” e identità precostituite, attraversato il meno che fosse possibile da rapporti di potere, incentrato sulla razionalità formale e procedurale. I primi due decenni del ventunesimo secolo si sono incaricati di dimostrare che si trattava, appunto, di un’illusione. E quell’ordine, che era in realtà legittimato soprattutto dalla propria credibilità nel promettere un futuro di progresso, pace, stabilità e benessere, è stato duramente colpito da una serie di severe smentite storiche: dall’11 settembre 2001 al 24 febbraio 2022, passando per la Grande Recessione e la pandemia.
In questa strettoia il conservatorismo, impossibile in via di principio, è diventato indispensabile nei fatti: nel momento in cui gli abitanti delle democrazie avanzate, allarmati dall’illeggibilità del futuro e sempre meno convinti delle «magnifiche sorti e progressive», hanno cominciato a chiedere che il ritmo forsennato del mutamento storico rallentasse un po’ e che fosse ripristinato qualche minimo punto di riferimento, seppur precario e provvisorio. Troppo spesso prigionieri dei propri schemi astratti, oltre che dei loro begli appartamenti nei centri storici delle metropoli, gli intellettuali progressisti continuano a chiedersi stupefatti come possano gli elettori dimostrarsi inconsapevoli a tal punto da votare per chi farnetica di una famiglia naturale che, naturalmente, naturale non è, o di una patria costruita a tavolino. Mentre deridono la pagliuzza dell’inconsapevolezza altrui, non si rendono conto della propria trave. Eppure basterebbe che rileggessero con un minimo di attenzione Simone Weil: «Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana». Un bisogno che, per definizione, una tarda modernità impegnata nella distruzione sistematica delle radici non potrà mai soddisfare.
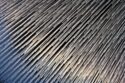
Popolari e populisti
La crisi dell’ottimismo progressista che aveva segnato i “lunghi” anni Novanta ha colto impreparati i partiti collocati a destra del centro, ossia le forze politiche che avrebbero dovuto rispondere alla richiesta, proveniente dai piani bassi delle democrazie avanzate, che i processi di trasformazione storica fossero riportati sotto controllo. Perché quei partiti si siano fatti cogliere impreparati è un altro quesito cruciale che richiederebbe un’analisi ben più approfondita di quella ch’è possibile offrire in questa sede. Delineate molto velocemente, a ogni modo, le linee portanti di quell’analisi potrebbero essere le seguenti. Il problema dell’inadeguatezza storica del conservatorismo alla modernità, innanzitutto, cresce a dismisura nell’ultimo mezzo secolo, ma nasce ben prima. È possibile sostenere che già il successo dei partiti democratico-cristiani all’indomani della seconda guerra mondiale sia dipeso non tanto dalla loro forza intrinseca, quanto dal bisogno diffuso di stabilità e rassicurazione; dal ruolo di rilievo svolto dalle chiese, accresciuto dalla crisi postbellica delle istituzioni statual-nazionali; dall’assenza, sulla destra dei sistemi politici, di concorrenti credibili, il conservatorismo tradizionale essendo stato ferito a morte dall’eccessiva contiguità col nazifascismo.
Dagli anni Sessanta in poi, i processi di secolarizzazione, l’appassire ulteriore delle strutture sociali tradizionali e la crisi del comunismo hanno accresciuto la pressione sulle già fragili strutture politiche e culturali dei partiti di destra, obbligandoli a ripensarsi e adattarsi alla nuova congiuntura storica. Col loro consueto pragmatismo, quelli si sono in effetti adattati e ripensati: in buona sostanza hanno accettato la tarda modernità, facendo tutt’al più forza sui rimasugli della tradizione per dare, di quando in quando, qualche piccolo colpo di freno, e soprattutto sforzandosi di identificare un nuovo principio ordinatore che fosse interno alla tarda modernità stessa. Quel principio lo hanno trovato nel mercato, sposato con entusiasmo prima dalle destre anglosassoni, e poi – in una forma assai meno diretta e ideologica, incapsulato all’interno del processo d’integrazione europea – pure da quelle continentali. Riconciliatesi con la tarda modernità e avendo puntato la maggior parte delle proprie fiches sul mercato, le forze politiche collocate alla destra del centro hanno finito per condividere – anzi: hanno contribuito a generare – il clima di ottimismo depoliticizzato che ha caratterizzato i “lunghi” anni Novanta. Di conseguenza, non sono più state in grado di svolgere quella funzione di controllo del cambiamento storico e di difesa dei fragili punti di riferimento residui che, nelle pagine precedenti, abbiamo dichiarato essere invece indispensabile.
Ma se una funzione è indispensabile qualcuno la dovrà pur svolgere. Nello spazio lasciato parzialmente vuoto dai partiti popolari o conservatori “tradizionali” si sono così insinuate forze politiche nuove o rinnovate da mutazioni recenti. Che, in mancanza di definizioni migliori, abbiamo chiamato “populiste”. Il cosiddetto populismo, nell’interpretazione che sto proponendo qui, è quindi il frutto politico della ribellione diffusa contro la tarda modernità, la dissoluzione di ogni punto di riferimento, l’accelerazione forsennata del tempo storico. Poiché la tarda modernità ha demolito tutti gli apriori e decostruito tutte le narrazioni, il populismo non può proporre un progetto politico coerente che si appoggi su robuste fondamenta teoriche. Poiché la stragrande maggioranza del ceto intellettuale ha accettato la tarda modernità, e perde anzi gran parte del proprio tempo a illudersi che quella possa correggersi da sé e produrre infine gli esiti miracolosi che ha promesso, il populismo non attira gli intellettuali e non può che avere un profilo anti-intellettuale. E poiché si tratta di esprimere una ribellione e una protesta, possono andar bene molteplici forme politiche e ideologiche: di destra, di sinistra, né di destra né di sinistra, libertarie e stataliste, cosmopolite e nazionaliste.
Il cosiddetto populismo, nell’interpretazione che sto proponendo qui, è quindi il frutto politico della ribellione diffusa contro la tarda modernità, la dissoluzione di ogni punto di riferimento, l’accelerazione forsennata del tempo storico.
giovanni orsina
Da qui anche una certa volatilità del voto populista, la sua capacità di passare velocemente da un partito all’altro malgrado quei partiti possano parere molto distanti l’uno dall’altro. Con la sconcertante chiaroveggenza del poeta, Eugenio Montale aveva già descritto il fenomeno con precisione chirurgica sessant’anni fa: «Quando la protesta diventa una proficua carriera la scintilla si spegne, il nostro delegato, il nostro eletto, l’uomo al quale avevamo affidato il coraggio che a noi mancava viene rapidamente sostituito da un altro. Inconfutabile rimane, in ogni modo, il fatto di una universale protesta che non colpisce questo o quel regime politico o sociale, ma l’innaturalità del nostro modo di vivere».
E tuttavia, poiché è rivolta contro i processi di liquefazione dei punti di riferimento che segnano la tarda modernità, è difficile che, nel suo girare e rigirare, la protesta non incontri prima o poi la nazione. Che sarà anche una comunità immaginata e sarà anche stata molto indebolita dalla catastrofe del 1945, ma rimane pur sempre una presenza storica plurisecolare, profondamente radicata nella psiche collettiva e assai difficile da sostituire. Oltre a restare il principio legittimante delle entità statuali entro le quali continua a svolgersi la maggior parte dei processi politici in generale, e di quelli democratici in particolare. La nazione non ha più la “durezza” che aveva nella prima metà del ventesimo secolo, insomma, ma è comunque più “dura” di qualsiasi possibile punto di riferimento alternativo. Ha preso così forma un populismo di destra nazionalista, o sovranismo.
Il laboratorio italiano
La riflessione che ho sviluppato finora ha l’impudenza di volersi applicare a tutte le democrazie avanzate, ovviamente in forme che possono essere assai diverse a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascun caso nazionale. Di certo, vale per l’Italia: un paese fragile e, di conseguenza, esposto più di altri ai condizionamenti internazionali, nel quale alcuni dei fenomeni che ho descritto nelle pagine precedenti si sono presentati prima e in maniera più macroscopica che altrove. Un paese, insomma, che per certi versi può esser considerato un laboratorio di liberal democrazia nella tarda modernità.
Qualsiasi ragionamento sensato sull’Italia contemporanea non può che prendere le mosse dagli eventi del lustro 1989-1994: la caduta del Muro di Berlino (1989), la firma del trattato di Maastricht (1992), la crisi del sistema politico italiano (1992-1993) e la discesa in campo e vittoria elettorale di Silvio Berlusconi (1994). Ancora una volta, non è questo il luogo nel quale sia possibile ripercorrere in maniera esaustiva trent’anni di storia d’Italia. In breve, tuttavia: la Guerra Fredda da un lato risparmiava all’Italia la fatica d’interrogarsi sulla propria identità nazionale e sulla propria proiezione esterna, incistandola nell’Occidente (“Bulgaria della Nato”) e garantendole una facile rendita di posizione sul proscenio internazionale; dall’altro forniva una struttura al sistema politico, bloccando la Democrazia cristiana al governo e il Partito comunista all’opposizione. Col 1989, di colpo, tutto questo viene meno, e la Penisola si trova di fronte alla propria fragilità identitaria e alla necessità di ripensarsi tanto negli assetti interni quanto nell’azione esterna.

Che la metamorfosi del sistema politico italiano sia avvenuta attraverso un terremoto giudiziario, nel biennio 1992-1993, costituisce la Urkatastrophe dell’Italia del ventunesimo secolo. I partiti storici vengono spazzati via, con l’eccezione del piccolo partito postfascista e dei ben più rilevanti partiti postcomunisti. La Democrazia cristiana collassa, aprendo una voragine sul centro e centro-destra dello spazio pubblico. In Italia, così, la crisi del popolarismo avviene assai precocemente. E certo, dipende molto dalle peculiarissime circostanze nazionali. Ma può anche essere interpretata, in chiave più generale, come una conseguenza dell’incapacità della Democrazia cristiana di raggiungere un equilibrio virtuoso e funzionale fra l’identità e gli interessi nazionali da un lato, il nuovo contesto europeo e internazionale dall’altro.
Che la metamorfosi del sistema politico italiano sia avvenuta attraverso un terremoto giudiziario, nel biennio 1992-1993, costituisce la Urkatastrophe dell’Italia del ventunesimo secolo.
giovanni orsina
La voragine che il collasso democristiano apre sulla destra del sistema politico viene almeno in parte colmata dalla Lega, formatasi nel corso degli anni Ottanta, e dai postfascisti del Movimento sociale italiano, fondato nel 1946. Ma si tratta di soluzioni fragili e residuali: sia l’autonomismo, quando non secessionismo, della Lega, che anche nell’Italia settentrionale non riesce a convincere più che una grossa minoranza dell’opinione pubblica; sia il postfascismo, impedito dall’inutilizzabilità delle proprie radici storiche e dalla debolezza della cultura politica che aveva saputo produrre, dopo il 1945, anche al di là di quelle radici. A partire dal 1994, quindi, a protagonista della ricostruzione della destra italiana si erge Silvio Berlusconi.
Il berlusconismo, in buona sostanza, tenta di ricostruire l’identità pubblica dell’Italia attraverso la valorizzazione della sua identità privata: il paese delle mille città, della creatività, dell’inventiva e dello spirito imprenditoriale, dell’arte e della bellezza, dell’inconcepibile varietà paesaggistica, enologica e gastronomica. È un’emulsione di populismo e liberalismo: populista perché enfatizza l’unità “naturale” del popolo italiano; liberale perché quell’unità è aperta, eterogenea e accogliente; populista e liberale al contempo perché lascia alle élite politiche un ruolo residuale. È un’operazione geniale e impossibile che poteva essere immaginata unicamente nel clima ottimistico e antipolitico dei “lunghi” anni Novanta. Ma Berlusconi mette stabilmente le mani sul potere solo nel 2001, quando il suo progetto è ormai fuori tempo. Nel frattempo, in armonia con l’incupirsi del clima storico alla svolta del millennio, ha attenuato il proprio liberalismo e accentuato il proprio conservatorismo. E nel 1999 il suo partito, Forza Italia, è entrato nel Partito popolare europeo: il popolarismo ha così avviato la collaborazione col populismo, seppure con un populismo tutt’affatto peculiare come quello di Berlusconi.
A sinistra, dove i postcomunisti occupano una posizione egemonica e i democristiani progressisti fanno da sparring partner, le cose non vanno molto meglio. Si tratta di due tradizioni politico-culturali – la comunista e la cattolico-progressista – che non soltanto rifiutano in astratto l’idea di nazione a vantaggio di referenti sovranazionali, ma, più in concreto, formulano un giudizio pesantemente negativo sulla storia d’Italia, che considerano sbagliata fin dai suoi esordi e bisognosa di un urgente riorientamento palingenetico. Dopo il 1994, così, venuti meno i punti di riferimento della Guerra Fredda, la sinistra italiana non è minimamente in condizione di ripensare la nazione, e non ha altra scelta che assumere una posizione integralmente europeista: l’Europa diviene per l’Italia l’unico possibile orizzonte identitario e al contempo l’unico strumento che possa sradicarla dal suo passato e proiettarla, integralmente rinnovata da un punto di vista morale prima ancora che politico, nel futuro. L’interesse nazionale italiano viene fatto coincidere senza alcun residuo con la sempre più profonda integrazione del continente.
Questa linea programmatica – che il centrodestra berlusconiano rifiuta in astratto ma non riesce a contrastare nei fatti, anche perché è fortemente rappresentata nel “deep state” italiano – fa sì, in buona sostanza, che al tavolo del poker europeo, dove si gioca con carte francesi, l’Italia si sia spesso seduta portando con sé un mazzo di carte napoletane e convinta che si giocasse a briscola. Fuor di metafora: i negoziati, nell’Europa di Maastricht, impongono che ci si presenti con un’identità forte, un’idea chiara dell’interesse nazionale e di come promuoverlo in maniera compatibile col contesto continentale. E che poi, una volta raggiunto l’accordo collettivo, il sistema decisionale domestico si modifichi in armonia con quell’accordo, così da adeguarsi ai limiti che esso impone e poterne trarre il massimo vantaggio. I due blocchi politico-culturali che si contendono l’Italia dopo il 1994, la destra egemonizzata dal liberal-populismo berlusconiano e la sinistra aprioristicamente europeista, sono inadatti a gestire questi due momenti. Il blocco di sinistra più inadatto a gestire il primo, perché, come detto, il suo obiettivo nei negoziati continentali non è la promozione dell’interesse nazionale ma il successo dei negoziati stessi. Il blocco di destra più inadatto a gestire il secondo momento, perché riluttante a disciplinare gli animal spirits del popolo italiano. La grave inefficienza dell’apparato decisionale pubblico e l’incapacità dei due blocchi contrapposti di raggiungere un accordo sulla sua riforma completano il quadro della profonda inadeguatezza dell’Italia all’Europa.
La grave inefficienza dell’apparato decisionale pubblico e l’incapacità dei due blocchi contrapposti di raggiungere un accordo sulla sua riforma completano il quadro della profonda inadeguatezza dell’Italia all’Europa.
giovanni orsina
Negli anni compresi fra la fine del primo e l’inizio del secondo decennio del ventunesimo secolo, sotto i colpi della Grande Recessione e della crisi dei debiti sovrani, quest’inadeguatezza conduce al collasso del sistema politico che aveva preso forma dopo il 1994. È il momento nel quale l’ottimismo dei “lunghi” anni Novanta s’inabissa definitivamente, il mondo tumultuoso, proteiforme e ingovernabile della tarda modernità comincia a mostrare il suo volto più spiacevole, e gli italiani non sanno più da che parte rivolgersi in cerca di protezione. La proposta berlusconiana di ricostruire un’identità nazionale ecumenica e liberale, come detto, poteva avere senso nello Zeitgeist del 1989 e dintorni, ma è ormai definitivamente superata dalla storia. L’Europa resta l’unica opzione plausibile, a tal punto che alla fine del 2011, col governo Monti, di fatto commissaria l’Italia. È assai probabile che in quel momento non ci fossero alternative. In ogni caso le conseguenze di quest’evento, privo di precedenti in alcun altro paese dell’Unione, sono arrivate fino ai nostri giorni. Le politiche di austerity del governo Monti, pro-cicliche in una fase recessiva, convincono una parte rilevante dell’opinione pubblica, a torto o a ragione, che fra gli interessi italiani e quelli europei la coincidenza non è necessaria né automatica, e che non è all’Europa che gli italiani possono chiedere di essere protetti dalle bufere globali.
Prende così avvio, coi caratteri descritti alla fine del secondo paragrafo, il ciclo populista italiano: il successo straordinario del Movimento 5 stelle, né di destra né di sinistra, alle elezioni del 2013; poi la metamorfosi della Lega, federalista e settentrionale, nel “Salvinismo”, populista e nazionalista; il montare dei consensi leghisti-salviniani a partire dal 2014, in coincidenza con la crisi migratoria; il successo combinato di Lega e Movimento 5 stelle alle elezioni del 2018 e la nascita del cosiddetto governo gialloverde. I populismi si sono accavallati, scavalcati e divorati l’uno con l’altro, fin quando, da ultimo, al loro interno non si è affermato un discorso nazional-conservatore. Arriviamo così al giorno d’oggi e al probabile successo elettorale di Fratelli d’Italia.
La destra italiana e l’Europa
È giunto il momento di tirare i fili che abbiamo disteso nelle pagine precedenti e di cercar di capire in quale modo possano gettare un po’ di luce sul nostro presente. Sulla politica italiana, sulla politica europea, e sull’impatto che quella potrebbe avere su questa.
Il conservatorismo nazionale di Giorgia Meloni è una creatura assai fragile. Per tre ragioni. La prima è quella generale della quale abbiamo parlato nel primo paragrafo: la tarda modernità ha decostruito tutti i valori sui quali potrebbe appoggiarsi un pensiero conservatore, rendendolo teoricamente impossibile e schierandogli contro la stragrande maggioranza delle élite intellettuali. Della seconda ragione abbiamo già detto qualcosa: non c’è in Italia una forte tradizione nazional-conservatrice cui Meloni possa far riferimento. Non è un caso, insomma, se dopo la fine della Guerra Fredda, quando per la Penisola si è posto il problema di ripensare la propria identità, le risposte sono state l’Europa da una parte e la bizzarra idea, quasi prepolitica, di un popolo composto di individui dall’altra. Nella storia politica italiana del ventesimo secolo, a destra hanno pesato il fascismo e la Democrazia cristiana. Ma la tradizione fascista è del tutto inutilizzabile, e lo sforzo di Meloni è anzi quello di dimostrare che il suo partito se n’è completamente distaccato. La tradizione democristiana potrebbe forse essere recuperata, ma a Fratelli d’Italia sarebbe di scarso aiuto: è una tradizione solamente in parte conservatrice e in quasi nessuna sua parte nazionale; ed è una tradizione che in Italia ha prosperato grazie al rapporto simbiotico con una Chiesa cattolica forte, presente e incisiva – là dove oggi la Chiesa, per quanto abbia conservato una sua rilevanza, è assai più debole, distratta e politicamente divisa.
È un po’ per disperazione, allora, che Meloni sembra andar cercando riparo nella tradizione conservatrice anglosassone. Straordinariamente ricca e profonda, certo. Ma pensata all’interno di storie diversissime dall’italiana quali l’americana e la britannica. E che perciò, quando la si tenta d’importare in Italia, non può che creare difficoltà. La compatibilità fra dimensione nazionale e dimensione occidentale non è scontata nemmeno nel mondo anglosassone, ad esempio, ma riesce senz’altro assai più naturale che in Italia: un paese che storicamente appartiene sì all’Occidente, ma in una collocazione eccentrica, e che non ha mancato di mettere quest’eccentricità al servizio della propria identità nazionale. Per il momento, anche sotto la spinta del conflitto ucraino, Meloni si sta sforzando di tenere insieme patriottismo italiano e atlantismo – ma quali siano i rapporti e pesi relativi fra quei due termini, nel suo pensiero, non è affatto chiaro.
È un po’ per disperazione, allora, che Meloni sembra andar cercando riparo nella tradizione conservatrice anglosassone.
giovanni orsina
La terza ragione per la quale il conservatorismo nazionale di Meloni è fragile deriva dalla storia del suo partito: una forza politica di piccole dimensioni, di testimonianza ideologica, che soltanto in questi ultimissimi anni si è gonfiata nei sondaggi a tal punto da potersi candidare alla guida del paese. Una forza politica che ha dato vita a qualche iniziativa culturale collaterale e prodotto un po’ di pensiero, insomma, ma necessariamente su scala ridotta e con risultati modesti. Non c’è dietro Meloni una riflessione ambiziosa su quale possa essere un conservatorismo adeguato al ventunesimo secolo, né sul contributo che a questo progetto potrebbe fornire la tradizione italiana. C’è solo un abbozzo di ragionamento sul rapporto fra libertà economica e protezione dei produttori nazionali, che credo sia la domanda cruciale alla quale i conservatori devono rispondere oggi. Non ci sono né un intellettuale di riferimento né un livre de chevet. È questa la ragione per la quale le radici post-fasciste di Fratelli d’Italia pesano in negativo: non certo perché il partito abbia il desiderio, tanto meno la possibilità, di ricreare in Italia un regime fascista – un’ipotesi a dir poco ridicola –, ma perché il partito non può attingere alla propria tradizione e non ne ha un’altra con cui sostituirla.

Malgrado questa fragilità, stando ai sondaggi Fratelli d’Italia prenderà un quarto dei voti e la coalizione di destra-centro quasi la metà: il conservatorismo impossibile, come si diceva nel primo paragrafo, è indispensabile, poiché è da quel lato che guarda una parte rilevante dell’opinione pubblica. Sono elettori spesso irritati, ombrosi, volubili, geograficamente, culturalmente o socialmente periferici, che a torto o a ragione si sentono poco considerati, e una parte dei quali è passata, fra il 2013 e il 2018, per il populismo né di destra né di sinistra del Movimento 5 stelle. La maggioranza di costoro si colloca senz’altro a destra, ma si esiterebbe a definirli ideologicamente dei conservatori, tanto meno dei nazionalisti: il nazional-conservatorismo viene dall’alto, seppure coi caratteri di fragilità che ho illustrato sopra, e raccoglie (per questa volta – la prossima chissà) un elettorato magmatico alla ricerca di comprensione e di un po’ di protezione più che di vere e proprie battaglie ideologiche. Ciò nonostante, il fatto che a destra abbia preso forma una coalizione, che questa coalizione possa raccogliere quasi la metà dei voti, vincere le elezioni e dare vita a un governo, e che i tre partiti principali dell’alleanza appartengano a tre diversi gruppi del parlamento europeo resta comunque un fatto storico destinato ad avere, con ogni probabilità, conseguenze non irrilevanti.
Non c’è dietro Meloni una riflessione ambiziosa su quale possa essere un conservatorismo adeguato al ventunesimo secolo, né sul contributo che a questo progetto potrebbe fornire la tradizione italiana.
giovanni orsina
L’Italia, si diceva prima, è un paese fragile, esposto più di altri ai condizionamenti internazionali. Se sommiamo questo dato strutturale alla debolezza – insufficienza culturale, competizione interna, dissensi programmatici, carenza di classe dirigente – dei singoli partiti di destra e della loro coalizione, e inquadriamo il tutto in un contesto storico come quello attuale, segnato dal Next Generation EU e dal conflitto ucraino, otteniamo come risultato che lo spazio di manovra per l’eventuale futuro governo di destra sarà molto modesto. C’è chi prevede fin d’ora che si tratterà, ammesso che riesca a nascere, di un ministero effimero, destinato a durare “come un gatto in tangenziale”, e che l’Italia tornerà ben presto a un governo commissariale come quelli di Mario Monti e Mario Draghi, sostenuto dal Partito democratico, referente del “deep state” italiano e guardiano della fedeltà europea. È possibile che vada così, anche se, ovviamente, non è detto. Di certo, sarà un governo che non potrà andarsi a cercare, ma al contrario dovrà fare di tutto per evitare, tensioni con Washington, i grandi investitori internazionali, Bruxelles, Berlino, Parigi. La coalizione di destra-centro a trazione nazional-conservatrice, insomma, dovrà commisurare le proprie aspirazioni ideologiche alla dura realtà.
Ma se un governo italiano di destra-centro dovesse nascere e durare, potrebbe allora aprirsi una più generale, seppur complicatissima partita europea. Finora le forze politiche appartenenti al gruppo conservatore e riformista, e ancor di più quelle aderenti a Identità e Democrazia, sono state tenute ai margini del gioco politico continentale, isolate da una sorta di “cordone sanitario”. Legittimato per un verso dal dubbio, non da poco, su quanto una prospettiva esplicitamente e duramente nazionalista sia compatibile con le istituzioni europee; per un altro dall’auspicio che la ribellione populista di destra si riveli effimera e congiunturale e venga riassorbita rapidamente. La posizione che ha preso la Polonia nel conflitto ucraino, ma ancora di più lo scivolamento a destra delle opinioni pubbliche europee, già stanno indebolendo il cordone sanitario quanto meno nei confronti dei conservatori, se non dei nazional-populisti. Un eventuale governo di destra-centro in Italia, paese fra i più popolosi dell’Unione e protagonista del processo d’integrazione fin dal suo inizio, un governo incentrato su una forza politica conservatrice alleata con una nazional-populista e una popolare, potrebbe tagliare definitivamente quel cordone e aprire nuovi spazi per un dialogo a destra. Il laboratorio italiano, insomma, potrebbe anticipare un più generale processo di ristrutturazione della politica continentale.
Il laboratorio italiano, insomma, potrebbe anticipare un più generale processo di ristrutturazione della politica continentale.
giovanni orsina
Oppure no. Oppure il cordone sanitario potrebbe rimanere intatto, nella paziente attesa che il gatto della destra italiana, sconsideratamente avventuratosi sulla tangenziale, finisca sotto un SUV. Quest’opzione, che nell’immediato è di certo politicamente meno costosa della precedente, porta tuttavia con sé almeno due controindicazioni. La prima, che il fallimento di un governo di destra dotato di una robusta legittimazione elettorale – sarebbe il primo dal 2011 – e la sua sostituzione, ancora una volta, con un gabinetto di garanzia europea assesterebbero un ulteriore, duro colpo all’edificio già periclitante della democrazia italiana. La seconda, che in una democrazia periclitante la ribellione degli elettori potrebbe imboccare strade ancora più dirompenti rispetto agli equilibri continentali. Soprattutto se quella ribellione dovesse dimostrare di non essere né effimera né congiunturale, come questo saggio ha sostenuto fin dall’inizio.
[Se pensate che il nostro lavoro sia utile e volete contribuire affinché il Grand Continent resti una pubblicazione aperta, potete abbonarvi qui.]
