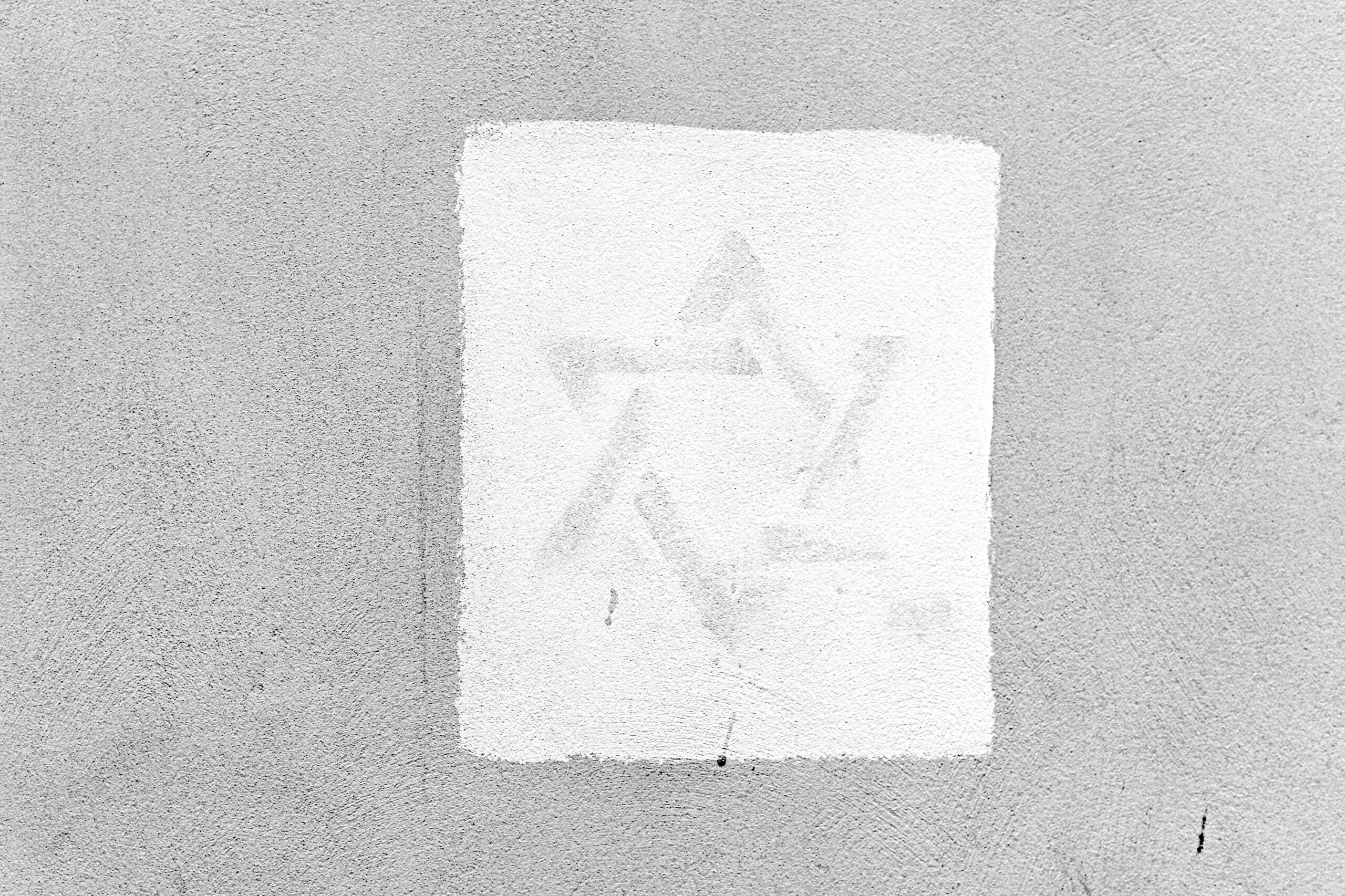A chi scrive o legge di storia certe domande non passano di mente. E quando i conti non tornano – conti miseramente intellettuali, s’intende – esse riaffiorano come un presagio sinistro e ineluttabile, come l’iscrizione a quella “globalizzazione dell’impotenza” che papa Leone XIV denuncia, dichiarando la sua.
Una domanda storica molto classica, ad esempio, riguarda il modo, i tempi, i passaggi attraverso i quali si è formato quell’oggetto storico corposo, complesso, stratificato che chiamiamo antisemitismo e che una cura più attenta dell’espressione chiamerebbe die Sache-Antisemitismus. Che al suo interno si siano intrecciate convinzioni teologiche e mistificazioni teologiche, teorie scientifiche e pseudo-scientifiche, sentimenti politici e fiammate – lo capisce chiunque. Chiunque, d’altronde, sa che quella “cosa” (cucinata in un tempo che va dai Concili del IV secolo a quello del 1215, da lì a Lutero e poi su fino al XX). Sa che essa ha connotato il regime di Cristianità e avvelenato la catechesi delle Chiese; sa che ha subito una metamorfosi politica strepitosa e ha disseminato la storia di una teoria di abomini, simili ma non identici a tanti altri: fino alla pianificazione di quello sterminio industriale dell’ebraismo europeo, apice distinto e conseguente di ciò che lo ha preparato.
Ma dal punto di vista storico, la questione non è che ci sia un gomitolo di orrore al centro del Novecento, né che, ovviamente, abbia delle origini, delle cause, un vissuto. La domanda storica è molto più tagliente, puntuale, appuntita. Se la si volesse sgranare in una serie di sotto-questioni, enunciate in modo casuistico, esse suonerebbero grosso modo così.
Qual è la ragione precisa per cui Leone Magno, non troppo tempo dopo i decreti imperiali che colpivano con le stesse sanzioni cristiani ed ebrei, conia un vocabolario dell’invettiva sul sacrilegio deicida destinato a durare nel tempo? Per quale esatta ragione (culturale, teologica, politica) i crociati che si mettono in marcia al comando del papato gregoriano mentre scendono verso gli imbarchi del sud fanno strage di ebrei? E attraverso quali strumenti specifici il diritto canonico medievale prende in prestito la teoria agostiniana sulla necessità che un ebraismo minoritario e umiliato resti nella società cristiana per fissare leggi di discriminazione? Quale meccanismo puntuale fa sì che l’odio per gli ebrei sia l’unico punto di contatto fra evangelici e papisti all’esordio della Riforma di Lutero? E dandosi quale fondamento, modi e figure ecclesiastiche che conoscevano l’antico principio che vietava il battesimo invitis parentibus lo aggirano portando alla stagione che va dalle conversioni forzate al rapimento dei bambini ebrei? Qual è il passante concettuale – chiaro agli occhi di chi lo percorre, trovandolo ora trafficato, ora deserto – che va dall’odio anti-islamico a quello antiebraico e alla cultura del nemico che li concima? E perché così pochi credenti, nell’Europa di Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer, vedono che gli stereotipi della discriminazione cristiana combaciano con le politiche nazi-fasciste che perseguitano prima i diritti e poi le vite degli ebrei?
Il ritorno
Sono domande che hanno punteggiato il lavoro quotidiano di chi affrontava professionalmente e scientificamente gli antisemitismi (nella storiografia italiana i plurali sono oggi all’ultima moda). Problematiche a lungo “fredde”: intimamente urgenti e, per molti, fin troppo alte.
Su di esse, però, ha fatto irruzione un presente disperante, nel quale Pòlemos è tornato con la forza di un dio “pater, cioè potens” (spiegava un saggio di Massimo Cacciari sul famoso frammento 53), la cui “potenza, non si manifesta distruggendo, ma ponendo” e “tutti accomuna proprio nel costituirli come differenti”, antagonisti, ostili, incomunicanti. Sotto i nostri occhi, l’oggi ha preso ad accumulare evidenze che suggeriscono quanto possa essere rapido, preciso, geometrico, il formarsi della cultura del disprezzo e dell’odio antiebraico – sulla cui precedente genesi ci interroghiamo per mestiere. Segnali, spunti, mentalità affiorano da un presente, nel quale si stanno riannodando – come sempre nel candore di una apparente “innocenza” soggettiva di chi lo esprime – un antisemitismo vecchio e nuovo. Reso invulnerabile da un argomento altrettanto geometrico e oggettivo che rifiuta (giuntamente) di usarlo come alibi davanti ad una guerra non più orrida di tante altre, ma attorno alla quale si è acceso un incendio di cui il cinismo politico (né quello pro-Pal, né quello Bibi pro domo sua) non vuole calcolare gli esiti.
Come davanti a Ellie Sattler e Alan Grant di Spielberg, un odio antisemita che sembrava estinto cammina davanti a noi, si muove, si nutre, si riproduce. Le teologie e il Concilio sembravano averlo ripudiato e fossilizzato con decenni di dialogo ebraico-cristiano. La lucidità morale, le costituzioni democratiche e il senso civico sembravano averlo sepolto sotto una montagna di “mai più”.
Invece – lo vediamo sotto i nostri occhi – gli antichi stereotipi dell’antisemitismo cristiano (talora definito antigiudaismo con una distinzione implicitamente auto-assolutoria), si ripropongono in una variante secolarizzata, ma non troppo. L’accusa del deicidio, la diaspora come sanzione, la leggenda dello spargimento rituale del sangue dei bambini che avevano reso l’antisemitismo un mito popolare e popolano, creduto e credibile – sono risuscitati, rigenerati, in un nuovo impasto (vedremo come). Un sentimento che porterà tragedia a chi della violenza che esso legittima sarà vittima; e poi colpirà i compilatori dei nuovi breviari dell’odio, che si troveranno fra le mani un senso della libertà fradicio e una professione della fede umiliata dall’odio.
Lo sapevamo?
A parte quelli che l’antisemitismo non l’avevano mai dismesso, per gli altri è una scena che porta dentro una ulteriore domanda, altamente ustionante. Dovremmo esserne sorpresi o dovevamo aspettarcelo?
Sì, dovevamo saperlo. Anzi: lo sapevamo.
Lo sapevamo talmente bene che non potevamo dircelo. Non avevamo gli strumenti per dirci che gli innumerevoli “mai più” delle cerimonie sulla Shoah e lo sdegno collettivo per gli attentati alle sinagoghe, ai ristoranti kosher o agli asili ebraici d’Europa, l’allarme per l’odio cialtrone degli stadi, erano tutti fondati sulla sabbia. Tutti. Quelli ipocriti e quelli più sinceri. Sabbia piena di nobili propositi, ma sabbia. Sabbia impastata dalla prosa della commozione, ma sabbia.
Il ricordo dei superstiti, condannati a ricordare e a chiedere di ricordare, sembrava aver fissato la punteggiatura morale del discorso pubblico. I loro volti amati, le loro voci rotte, i loro volti “resi duri” (Is 50,7), le loro parole lente consentivano di non dire che quella punteggiatura morale, era scritta su righe spesso vuote, nelle quali speravamo che il tempo avrebbe scritto l’analisi profonda, spietata, severa alla quale ci si sottraeva.
Loro no. Loro lo sapevano. I più implacabili con se stessi, come Primo Levi ne erano stati schiacciati. I più pessimisti di loro – penso Liliana Segre – descrivevano amaramente un domani nel quale di ciò che avevano portato e sopportato sarebbe diventato dieci righe di sussidiario, come un casus della malvagità umana.
Gli altri confidavano in una superstizione civile derivata dalla grammatica latina: “spero, promitto e iuro vogliono l’infinito futuro”, insegnava il manuale.
E allora, con volontarismo impaziente, gli altri si immergevano nei gesti e testi artistici, storici, cinematografici, liturgici della memoria. Erano, gli altri, fiduciosi che poche note (“si-mi, si-mi, do-si-sol-si” di John Williams per Schindler’s List) bastassero per sostituire la sordità degli indifferenti con un acufene sentimentale. Sopportavano gli incantesimi à la Benigni – quelle che chiedevano ai bambini morti appena scesi sulla rampa di Birkenau, di fingersi vivi per dire ai discendenti degli assassini che “la vita è bella”, come se la prova di tutto questo nel crogiuolo della storia potesse svanire. Accompagnavano la stagionale transumanza di giovanetti verso i lager, con sindaci e insegnanti volonterosi, che stimolavano l’identificazione di sé con la sofferenza; un’identificazione (faceva eccezione) che non era accompagnata dall’assunzione di categorie esigenti, radicali. E così diventava una compassione generica per un dolore di cui scorge la profondità sulla quale richiude il coperchio, sigillandolo con un silicone di lacrime di un minuto, di un’ora, di un giorno.
La logica della memoria come “emozione” lasciava così intatti i pregiudizi che pascolano nel tempio lurido delle coscienze, insensibili agli esorcismi generici. Perché l’esorcismo funziona se il Male viene chiamato per nome, se è riconosciuto nel suo essere non-Assoluto, ma umanissimo, se viene sbeffeggiato esponendosi alla sua ritorsione. E per respingere il senso di un’azione fragile ripassavamo i “però”, gli “almeno”.
Perché tutti sapevamo tutto: ma speravamo che quelle emozioni, il giro della memoria a somma zero fra Shoah-foibe-resistenza-terrorismo-15/18 – che tutto quel castello potesse ritardare, spostare avanti, di un’altra generazione, il redde rationem; o forse due generazioni? O tre? Poi – chissà – poteva accadere che la virtù diventasse tale per abitudine a non far troppo male il male: no?
La Shoah in miniatura
Invece no. Sono bastate poche ore di un 7 ottobre non proprio qualsiasi (7 ottobre come la fucilazione dei ribelli di Auschwitz, 7 ottobre come l’inizio della guerra di Yom Kippur). Poche ore usate per qualcosa di infinitamente più importante della celebrazione armata di una delle tante scene del conflitto arabo-israeliano. In quella striscia di terra palestinese che l’assedio israeliano aveva trasformato nel brodo perfetto di coltura è stata preparata una selezione di atti metodicamente valutati, scelti con la precisione, con cui il predicatore scrupoloso sceglie le sue citazioni.
Grazie ai soldi dei nababbi venerati dai venditori di Rolex e di Ferrari. Grazie all’inefficienza dell’esercito più potente del Medio Oriente. Grazie alla stupidità naturale con cui l’intelligence più costosa al mondo s’è fidata delle tecnologie più evolute. Grazie all’illusione politicante di lasciare che gli spietati padroni della Striscia collaborassero a ridurre l’autorità dell’ANP a proporzioni vaticane. Grazie alla pazienza con cui la Fratellanza Musulmana – che vestiva i bambini con la mimetica, li decorava col nastrino dei martiri, li addestrava dai 5 anni in poi a prendere un ostaggio e tenerlo sotto tiro – aveva costruito una pedagogia del sangue che trasformava la speranza di veder riconosciuti o risarciti i torti subiti in sete di vendetta.
Tutto visto, tutto fotografato, tutto detto. Tutto ignorato, tutto sottovalutato da un governo che si regge su figuri che la stampa definisce (sa Dio perché) “messianici” o “ultra-ortodossi”. Politici che hanno poco a che fare con l’ebraismo pensoso e santo dei Martin Buber, dei Franz Rosenzweig, degli Emmanuel Lévinas: perché il fondamentalismo biblico di cui menano vanto, è oggettivamente debitore non dai padri della sapienza del giudaismo o del sionismo o dello Stato d’Israele, ma deriva pari pari da una eresia evangelicale americana definita solitamente come Christian Zionism. Quella dottrina fissa il secondo avvento del Cristo e la rottura della fine del mondo ad un momento successivo alla ricostituzione del regno di Giuda, alla distruzione delle moschee, alla ricostruzione del III Tempio, alla ripresa del sacrificio e del vero olocausto, offerto alla divina presenza. Una pantomima blasfema di una eresia cristianeggiante il cui materialismo amorale avrebbe fatto inorridire i maestri di tutte le generazioni venute dopo Moshé, e che invece ha trovato in alcuni partiti, figli del proporzionale puro, e in alcuni ambienti ottusi la sua nicchia elettorale e teologica.
Fino al giorno fissato: Shemini Atzeret (lo stesso shabbat dell’assalto alla sinagoga di Roma nel 1982). E quel giorno i figli di un sistema educativo islamista – entro il quale avevano marciato alti un metro vestiti da soldati, quelli che avevano in casa la foto di papà col passamontagna nero che li teneva in braccio – hanno attaccato il nemico di sempre, con uno scopo preciso, identico per ciascuna delle brigate messe in campo.
Lo scopo non era compiere un’azione di terrorismo, ancorché sanguinosissima. Lo scopo era produrre una “Shoah in miniatura”. L’obiettivo era servire in terra d’Israele a ragazzi assai secolari e danzanti, agli abitanti di kibbutz “pacifisti”, ai soldatini e soldatine di leva che avevano dato qualche allarme ignorato dal nonnismo da caserma – servire a tutti loro tutto ciò che era stato somministrato durante la seconda guerra mondiale ai loro nonni e bisnonni in Ucraina e in Polonia, in Francia e in Croazia, in Italia e in Germania.
Il 7 ottobre non era un atto di terrorismo compiuto da terroristi. Non era un atto di resistenza, non c’entrava con lo Stato palestinese, non era un gesto “spettacolare” di tipo binladeniano.
Era l’atto par excellence di una statualità sui generis di uno Stato che andava ad adempiere con i suoi soldati la sua finalità statutaria e statuale: uccidere, bruciare, violentare, straziare e – non ultimo – deportare. Deportare per uccidere, uccidere per deportare.
Era un messaggio che diceva, chiaro e tondo, a chi aveva usato molte volte il teorema della “terra dei Padri” lontani, che i loro padri più prossimi erano venuti fin lì, in questo rettangolo di ex impero ottomano, per niente.
Perché quando Hamas dice che “la bandiera di Allah che deve sventolare su ogni centimetro di Palestina”, secondo il wording della Fratellanza Musulmana, evoca per i propri sudditi e schiavi un destino di morte. Ma quando Hamas pianifica e realizza i piani del 7 ottobre non fa una “guerra”, come tante, ma “quella” guerra che è stata lo sterminio.
Non potendo fare un “genocidio” di proporzioni nazifasciste, si è dovuto limitare alla sua miniaturizzazione. Ma come nei plastici dei trenini elettrici, ha ricostruito tutto in modo millimetrico. Il rastrellamento casa per casa, le porte sfondate, le uccisioni gratuite davanti agli altri, la deportazione fatta per “selezione”, la prigionia e, comunque, la morte di un numero quanto più alto possibile di “pezzi”, si sarebbe detto nel gergo di Heinrich Himmler.
Tutto, il 7 ottobre, è stato predisposto e dispiegato per dire che Israele non aveva un vicino agguerrito (ne ha avuti) o un nemico forte (ne ha avuti): ma che aveva accanto un aguzzino dal quale non poteva fuggire. Un antagonista acuto: che aveva capito che il filo spinato e il muro avevano una valenza ambivalente: chi l’aveva posto per imprigionare, ne era imprigionato e non poteva scappare da quella porzione di terra che anziché Heretz Israel era stata eletta da Hamas a Ghetto, sul quale nella soleggiata alba del 7 ottobre sono partite da Gaza le ondate dei fucilatori, poi dei deportatori, degli stupratori, dei saccheggiatori.
Hamas sperava esattamente ciò che ha ottenuto e ha ottenuto esattamente ciò che sperava: morti, ostaggi, reazioni, effetti. Ma soprattutto la merce più preziosa. La convinzione che quell’atto così evocativo avrebbe dato a Netanyahu qualcosa che avrebbe accettato. Lui che non era né Levi Eshkol né Moshé Dayan, né Golda Meir né Itzhak Rabin avrebbe trovato – se evitava la crisi di governo e il governo di unità nazionale che il capo dello Stato avrebbe potuto pretendere – funzione politica, legittimazione militare, pretesti, consenso, mandato. E avrebbe guidato la prima guerra di Israele priva di obiettivi strategici chiari e che quando li ha avuti è finita.
Una guerra destinata a dare ad Hamas l’altra cosa di cui aveva bisogno urgentissimo: “martiri”, lo aveva detto Sinwar. Martiri: meglio se a migliaia. Martiri combattenti: ma ancor meglio se innocenti. Martiri singoli: ma ancor meglio se famiglie. Martiri adulti: ma ancor meglio se bambini. Martiri da buttare attraverso il proprio Ministero della Salute nel sistema informativo, con un bollettino che non avrebbe avuto troppo bisogno di essere falsificato né arricchito con la descrizione delle regole di ingaggio israeliane che affidano all’AI il riconoscimento facciale (chiamarlo The Gospel è stata una gratuita bestemmia) e all’AI la scelta del sistema d’arma proporzionato al “valore” del bersaglio in termini di vittime innocenti.
Questa modalità d’azione di Israele sulle città della Striscia, di martiri ne ha forniti ad abundantiam. In un ambito dove Israele avrebbe potuto mettere in opera un sistema di rappresaglia tremendo come quello letteralmente scoppiato fra le mani dei comandanti di Hezbollah in Libano, è stata ordinata una serie di operazioni in un contesto urbano dove nessun generale vorrebbe entrare, scommettendo che al mondo ci fosse un uomo capace di entrare in un bellum perpetuum senza un piano – ed abitasse a Cesarea.
Tutto quello che i capi e le diverse brigate di Hamas desideravano, dunque, è accaduto. Il 7 ottobre e dopo il 7 ottobre.
Il rimbalzo
È accaduto tutto ciò che voleva Hamas anche nel rimbalzo informativo.
Che il 7 ottobre fosse “un legittimo atto di resistenza” lo hanno detto in pochissimi, anche se erano già troppi; che era il modo in cui “i palestinesi hanno affermato la loro esistenza”, pochi, pure troppi. Che fosse “l’atto giustificato di lotta di un popolo oppresso” troppi. Dall’altra parte il grosso dell’opinione pubblica e del mondo diplomatico non si aspettavano da Israele una reazione “moderata”: nemmeno Joe Biden che aveva raccomandato di non fare l’errore americano dopo l’11 settembre.
Ma intanto quella reazione vedeva il contatore delle vittime gazawi, combattenti e civili, donne e bambini, salire vorticosamente anche perché Hamas ha usato non “scudi umani”, ma ha praticato “sacrifici umani” offerti ai bombardamenti: e questo ha eroso l’idea che Israele stesse reagendo, ma che stesse “compiendo” qualcosa. L’ammissione che le stragi di civili fossero atrocemente e inaccettabilmente simili a quelle perpetrate da tanti eserciti in tanti quadranti di guerra ha ceduto il passo al fatto che Israele stava facendo qualcosa di nuovo; e che questo dipendeva dal fatto che era il beneficiario-tipo del “double standard” con cui certi paesi si permettono ciò che impediscono ad altri.
Nel frattempo il totale delle millecinquecento vittime del 7 ottobre è stato pareggiato con una quantità di uccisi (miliziani e innocenti) che si è ingigantita: il doppio, il quintuplo, il decuplo, cinquanta volte tanto e ancora. La strategia di Hamas di mettere i comandi negli ospedali ha “funzionato”; la tattica di mimetizzare i capi fra i civili e i bambini ha funzionato. Così il lessico è scivolato: l’esercito israeliano che colpiva, è diventato Israele bombarda; i crimini di guerra di cui erano accusati i vertici del governo israeliano e hamasiano è diventato lo sterminio dei sionisti; le violazioni delle leggi di guerra dei comandi israeliani, la colpa degli ebrei. La guerra è diventata strage; anzi carneficina, anzi “genocidio” (ci tornerò).
Era questo lo scopo di Hamas? Chi la notte fra il 6 e il 7 ottobre 2023 chi vegliava in attesa di veder correre sangue israeliano e palestinese in un “diluvio”, aveva pianificato quella inversione dei ruoli che avrebbe cambiato l’opinione pubblica mondiale e risuscitato un odio antico e nuovo?
Chi, come disse il card. Zuppi, aveva “preso in ostaggio 253 israeliani e 2 milioni di Gazawi” ha scommesso che il lancio di 5mila missili e l’assalto in tre ondate a Kfar Aza, Nir Yitzhak, di Nir Oz, Re’im nel rave Supernova, sarebbe stato sospettato di essere non un fatto militare, ma un alibi, un complotto, un pretesto in fondo gradito? Hamas avrà calcolato che per ogni miliziano ucciso in quel campo di battaglia strapieno di gente sarebbero sorte nuove “vocazioni”? Avrà pensato che nessuno avrebbe fatto un severo esame di coscienza politico, morale, teologico su cosa aveva fatto o detto quando Hamas aveva preso il potere con un golpe, liquidato i membri dell’ANP, imposto un’economia di guerra finanziata a peso d’oro e trasformato chilometri di tunnel in una invulnerabile santabarbara? Aveva contato che l’analfabetismo religioso saltasse a piedi pari il problema di cosa tiene insieme una rete inter-denominazionale sciita-sunnita, di cui la Fratellanza Musulmana è il collante, temuta più dagli Emirati e dai governi arabi che da quelli della “entità sionista”? Ha forse progettato che anche per la immaginaria “Free Palestine from the river to the sea” – cioè cancellando lo stato di Israele in un modo che oggi sembra impossibile, ma domani chissà? – si potrebbe realizzare un “modello siriano” che vede un capo miliziano come Ahmad Al’Shara passare dalle fila dell’Isis al ruolo di statista?
Forse sì. Ma c’era una domanda ben più amara da farsi?
I capi del marketing di Hamas, a Gaza e fuori, hanno capito prima di noi, che ancora non ce ne capacitiamo, che ogni grammo di solidarietà europea ed occidentale verso una popolazione usata dalle grandi potenze arabe per decenni, ingannata dalla sua leadership a più riprese, usata dalla strategia iraniana del nemico esterno, straziata dalla dittatura di Hamas, oppressa dalla politica israeliana, ingiuriata dai coloni fondamentalisti ebraici – ogni grammo di solidarietà si sarebbe trasformato in un quintale di quel nuovo antisemitismo, che stiamo vedendo nascere, che torna per rimanere e che ci fa sentire la stessa impotenza dei clan gazawi che hanno osato domandare la resa di Hamas e sono stati passati per le armi?
Quel che non torna
È questo quel che non torna.
L’incancrenirsi della guerra, la quantità di vittime di un conflitto che ha posto in secondo piano la vita degli ostaggi israeliani e gazawi (per i quali si è battuto un movimento notevole in Israele al quale non è andata tutta la solidarietà – destrorsa, centrista e gauchiste – che ci si sarebbe potuti attendere), non ha comportato la crescita di un fronte pacifista.
L’orrore incancellabile del conflitto non ha alimentato la denuncia della guerra come superstizione che promette di risolvere problemi che aggrava, della guerra come crimine, della guerra come atto di idolatria dei “sangui” (come dice la versione latina del Salmo 50, che fa supplicare al plurale: de sanguinibus libera me Domine).
Se si volesse dirlo in modo visivo la guerra non ha visto salire le bandiere della pace, ma semmai ammainarle per sventolare quelle della Palestina (che sarebbe la Palestina dell’ANP, si presume), in nome di un sostegno alla Palestina combattente che è quella di Hamas.
Questo non torna.
Come non torna l’assunzione implicita che l’ebreo buono deve essere vittima – e se invece si sottrae a questo ruolo, è un ebreo che fa agli altri ciò che ha subito. Cioè un “genocidio”: categoria storicamente complessa, che dentro il diritto internazionale è ritenuta da alcuni troppo aspecifica per poter essere efficace e da altri troppo perimetrata per poter portare a sanzione crimini che sono sfuggiti a tutti i sistemi di prevenzione costruiti dalla politica e dalla diplomazia.
“Genocidio” che è entrato nel discorso pubblico ed è diventato un dogma: e chi esita ad usarlo, chi dice massacro, carneficina, o qualsiasi altra cosa deve accettare di essere insolentito come codardo, complice, sionista.
Il termine ha conquistato il proscenio lentamente. Prima di diventare una stella gialla da cucire al bavero di chi non la vuole usare, come notitia criminis, come peccato imperdonabile (o perdonabile solo da chi ne è il gestore cultuale e culturale), ha avuto una sua storia.
L’incriminazione di Benjamin Netanyahu e del ministro Yoav Gallant insieme a Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, tutti uccisi da Israele, davanti alla Corte Penale Internazionale con relativi mandati di cattura è del maggio 2024. È seguita una lunga discussione diplomatica sugli obblighi violati da Israele in quanto potenza occupante di Gaza in sede ONU e poi davanti alla Corte internazionale di giustizia.
Ben prima, a gennaio 2024, era stata formulata l’ipotesi di azioni “plausibilmente genocidarie” davanti alla CIG da parte del Sud Africa: un rapporto steso fra il 26 febbraio e il 5 aprile 2024 dello special rapporteur Francesca Albanese (“Anatomy of a Genocide – Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territory occupied since 1967 to Human Rights Council”) consacrava il termine in sede Onusiana non solo per Gaza, ma in senso estensivo, facendo della guerra iniziata nel 2023 l’ultimo capitolo di una politica ab origo (origo del 1948) segregazionista, coloniale, disumanizzante – in ultima analisi genocidaria.
Il 5 dicembre 2024 un rapporto di Amnesty International (“You Feel Like You Are Subhuman’: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza”) rendeva note le proprie conclusioni sul “genocidio” in corso a Gaza. E da lì nel corso del 2025 il termine è diventato non solo invalso nella protesta pubblica contro Israele, ma è diventato lo spartiacque fra chi, usandolo, si schiera dalla parte del diritto internazionale e chi rifiutandolo viene accusato di esserne “complice”.
Sola, provvisoria, eccezione il papato: che sia con Francesco che con Leone ha lasciato perlomeno aperta la questione della natura effettivamente “genocidaria” dell’interminabile sequenza di morti, mutilazioni, ferimenti e patimenti patiti dai civili di Gaza, Rafah, Khan Younis in un tempo ormai lungo la metà dell’ultima guerra mondiale. Ma a parte loro due a nessuno è concesso definire altrimenti l’inutile strage causata da due eserciti in guerra fra le case, le tende, gli sfollati, con una parola che non sia quella.
La coazione
“Genocidio”, dunque, è diventata la chiave di volta di una costruzione ideologica nella quale si riconoscono ambienti qualificati, giornali, in alcuni paesi folle terribilmente vaste; attecchisce in zone della politica distanti: è il motore delle logiche di boicottaggio commerciale e perfino sportivo, artistico o scientifico.
Si potrebbe considerare l’accusa di “genocidio” un puro fenomeno della psicologia di massa? Non si potrebbe attendere che passi l’affezione ad una parola che viene usata con sospetta parsimonia in altri quadranti bellici, ma che potrebbe forse evaporare, come acqua in una pentola? A mio parere no, assolutamente no.
Dentro di essa suona infatti una specie di teorema di psicologia sociale che suona così: gli israeliani, eredi delle vittime della Shoah, stanno facendo ai Palestinesi ciò che hanno subito. Quello che le truppe di Tsahal fanno a Gaza è solo l’acme di una “disumanizzazione” dei palestinesi che costituisce l’essenza stessa della politica israeliana e che a ritroso trova la sua riprova nelle annessioni recenti, è lo sbocco dell’occupazione delle terre del 1967, è il risultato della proclamazione dello Stato d’Israele, è il frutto del sionismo come tale.
La implausibilità di un tale assunto ideologico non è il vero punto.
Il punto è che per la proprietà palindroma dell’assurdo rendere dogmatica la definizione di “genocidio” (perpetrato da Israele) anziché condannare l’ecatombe di cui gli eserciti in guerra non tengono il conto, ha un retrogusto.
Se Israele non ha la responsabilità di aver accettato la condotta di guerra criminale di Hamas e di essersi illusa che la montagna di vittime civili potesse essere attribuita alla volontà del nemico, ma è colpevole di “genocidio” – tutto ciò che accadrà agli ebrei, dovunque, è legittimo; lo si potrà far rientrare nella categoria del “pazzo” (come a Manchester per Yom Kippur) o dei combattenti (come il terrorista che nell’82 ammazzò i clienti di un ristorante e il piccolo Stefano Gaj Taché a Roma che l’ANP ha consegnato alla Francia in cambio del riconoscimento dello Stato di Palestina). Se Israele è colpevole di “genocidio” tutto ciò che accade va atteso con fatalismo, tenendo pronto il messaggio di cordoglio. E non solo.
Se infatti Israele replica tutto ciò che l’ebraismo ha subito nella Shoah, allora proprio la Shoah riceve, retrospettivamente, una attenuazione: il conto torna magicamente in pareggio.
Sì: noi, perpetratori della Shoah, siamo stati spregevoli fascisti, nazisti, razzisti e criminali. Ma dato che i discendenti delle nostre vittime stanno facendo lo stesso vuol dire che il “nostro” delitto – preparato da secoli di odio e di odio cristiano diventato catechesi e magistero fino al Vaticano II – è stato solo una fattispecie della malvagità umana, che sempre c’è e sempre ci sarà. E dunque (andando incontro alla tesi diasporica per la quale gli ebrei devono smetterla di pensarsi come vittime-vittime-vittime) anche noi possiamo smettere di considerare carnefici-carnefici-carnefici gli uomini del nostro passato.
Se quello di Gaza non è un orrore che angoscia ogni anima viva, ma un “genocidio”, allora il male di un tempo diventa un male che ne ha generato un altro al quale non si somma, ma dal quale si sottrae. Totale morale: zero.
Il “genocidio” fallito dei fascisti e dei nazisti diventa premessa minore del “vero” crimine che è quello di cui non i sei milioni di europei, ma i palestinesi di ogni dove, oggi rappresentati dalle decine di migliaia di civili gazawi morti nella guerra ad Hamas sono le vere vittime e di cui i veri colpevoli sono Netanyahu, oppure il suo governo, oppure lo Stato di Israele, oppure gli israeliani, oppure ebrei – in un crescendo indiscriminato e indiscriminabile.
Inoltre insistere sul fatto che l’assedio di Gaza – assedio di cui sono parte le bombe e i viveri, le tende e le medicine – è stato un genocidio, anzi “il” genocidio trasforma il sogno della Fratellanza Musulmana di guidare un regime teocratico islamista in una opzione politica meno irrealistica. Giustifica la speranza di poter cancellare quell’errore della storia che è stata la creazione dello Stato di Israele. Motiva una nuova generazione di bambini sopravvissuti alle bombe a votarsi alla distruzione di una società dipinta come compattamente feroce, religiosamente vendicativa, dove tutto ciò che non è prevaricazione (dall’orchestra di Daniel Barenboim al sincrotrone Sesame) è inganno, propaganda, alibi.
Infine il termine “genocidio” cancella ogni dubbio metodologico. Se le intollerabili sofferenze patite dai civili gazawi sono (speriamo di poter dire almeno sono state) un “genocidio” non si può interrogare sulla strategia informativa di Hamas, che controlla ogni notizia nella striscia e sulla striscia. Non si può comparare la reazione “sproporzionata” dell’aviazione israeliana a quella alleata sull’Italia fascista, sulla Germania nazista e sul Giappone imperiale – eventi dopo i quali abbiamo costruito un sistema di leggi internazionali per la protezione delle popolazioni in guerra, che non ha mai avuto un effetto dirimente, ma che per uno Stato civile dovrebbe essere vincolante.
La ricostruzione del sistema
Il “genocidio” così è il seme di quell’antisemitismo che si sta cristallizzando, sotto una mobilitazione piena di intenti etici, di sdegno umanitario, di quella pietas che non può non esserci davanti a migliaia e migliaia di bambini morti, mutilati, resi orfani da una guerra che a Gaza, all’una del 7 ottobre, era stata salutata con colpi in aria e clacson orchestrati dall’Hamas attorno ai propri ragazzi tornati, carichi del sangue altrui.
Perché quando i buoni sentimenti, le buone ragioni, le buone intenzioni saranno evaporati, quando laggiù la guerra cederà definitivamente il posto ad una tregua, quando in Medio Oriente ci saranno leadership politiche che usciranno dall’idea di spargere sale sulle macerie dell’altro, qui resterà qualcosa.
Come una salina che si prosciuga al di qua del mare nostrum prenderà dimora un altro antisemitismo. Nuovo di zecca? o forse quello vecchio ringiovanito dal breve e intermittente riposo che si era concesso? Sia come sia, sarà come l’altro: un odio costruito teologicamente.
In quel sistema dell’old antisemitism un ruolo centrale l’aveva l’accusa di “deicidio”. Esso fissava non tanto la responsabilità per l’uccisione di Gesù – condannato ad un supplizio tutto romano, con una sentenza del prefetto romano – ma la convinzione che ci fosse una colpa collettiva degli ebrei di tutti i tempi ed una sanzione (la diaspora) calata collettivamente sul popolo d’Israele ripudiato per l’eternità dall’Eterno, cacciato in ogni dove così che ciascuna porzione della cristianità avesse i “propri” ebrei a disposizione per dimostrare a se stessi che il crimine per il quale erano stati condannati non era andato in prescrizione.
Il “genocidio”, oggi, ha la stessa funzione – e i tre volumi di “world history” del genocidio editi nella serie dei grandi manuali enciclopedici di Cambridge sono lì a dircelo. Mentre in ogni vicenda storica antica o recente, ci sono responsabilità individuali, solo per Israele e solo per gli ebrei esistono una colpa collettiva, come l’altra incancellabile. E come l’altra capace di far scattare un corto circuito così veloce da passare inosservato: per cui le sole colpe collettive sono degli israeliani, renitenti al loro ruolo, e in fondo di tutti gli ebrei.
Tranne i “convertiti”, appunto. Il secondo pilastro dell’antisemitismo di conio cristiano era infatti la “conversione”. Infatti la riprova morale dell’innocenza dell’antisemitismo cristiano era che “bastava” il battesimo, perfino invitis parentibus, per sfuggire alla discriminazione di cristianità, non sempre a quella del razzismo nazista. Oggi al posto del battesimo c’è il ripudio non della fede dei padri, ma della storia dei fratelli: al posto della resa alla verità oggi è chiesta la conversione dall’“occupazione”: cioè la conquista di territori non previsti dalla partizione che creava i due Stati e che Israele ha annesso nel corso delle guerre che ha combattuto nella sua storia di Stato laico (inizialmente socialista) e poi di Stato nel quale la componente religiosa ha avuto un ruolo che neanche un miscredente, ma Buber in persona avrebbe condannato con la forza della saggezza dei grandi Maestri. Come nel regime di cristianità solo l’ebreo convertito per tempo sfugge alla condanna, anche in questo nuovo regime solo l’ebreo che ripudia e sfugge all’occupazione – a parole se diasporico, andandosene da Israele per lasciare che i palestinesi governino la “Terra Santa” Hamas – dimostra di essere meritevole di un destino nel quale, come vuole Agostino, sarà qualcun altro a custodirlo intatto per l’ultimo Giorno.
Il terzo pilastro dell’antisemitismo era il supersessionismo: la dottrina per la quale l’alleanza di Israele non era stata estesa nella nuova alleanza, ma sostituita. Il nuovo popolo di Dio redento dal sangue di Gesù, prendeva il posto di quello vecchio, ipocrita, incredulo, formalista, cultore della vendetta e non dell’amore e perciò assetato di sangue. L’accusa agli ebrei di rapire i bambini il venerdì santo per dissanguarli e impastare le azzime aveva una capacità suggestiva enorme. Poco serviva che anche una superficiale conoscenza della Halakah dicesse che si trattava di una leggenda improponibile; essa entrava nel culto dei santi e nella sensibilità popolare. Poco serviva che un dotto come don Iginio Rogger fosse riuscito a far cessare il culto di san Simonino. Oggi l’accusa del sangue è diversa solo nella meccanica: non ci sono rabbini che dissezionano le arterie del martire bambino, ma persone, università, aziende, complici del genocidio e dunque meritevoli di boicottaggio necessario, giustificato, non negoziabile, che andrebbe confessato con la stessa docilità con cui confessarono gli ebrei sottoposti a tortura davanti ai tribunali ecclesiastici.
L’esito
C’è modo di evitare che questo residuato antisemita si insedi fra noi da qui in poi? Ci sono buone ragioni per dubitarne. L’altra volta (per quel che vale, ma vale) il suo formarsi non ha avuto ostacoli. S’è trasmesso fra generazioni, culture, confessioni, fino a che nei centocinquant’anni che vanno dalle emancipazioni alla Shoah è stata possibile una presa di coscienza. Di cui poi abbiamo percepito la fragilità.
Questa volta, per di più, c’è di mezzo la politica di Netanyahu, che aggiunge acqua salata alla pentola che ribolle di sdegno e sul cui fondo quel salgemma antisemita residuerà con spessori ancora più alti.
Chi ha scelto come mestiere quello dello studio della storia è vissuto fin qui con una convinzione: produrre sapere storico ha una efficacia paradossale, ma reale; quanto più è immune da finalizzazioni sempliciste ed ideologiche, tanto più ottiene dei risultati etici e sociali. Per questo lo studio dell’antisemitismo era così urgente negli anni Cinquanta. Per questo capirne i meccanismi antichi e recenti, dai battesimi forzati tanto ben studiati da Marina Caffiero ai dilemmatici silenzi di Pio XII, dall’odio per il Talmud alla svolta del Vaticano II, era così necessario.
L’angoscia dello storico di oggi è che la rapidità con cui l’antisemitismo si va ricomponendo in una teologia politica piena di tremenda energia dica non tanto che il suo lavoro è stato vano, ma che non c’è nulla da fare di utile, se non consegnarsi alla irricevibile logica sottesa al discorso pubblico della destra israeliana (“dato che nessuno condivide i nostri metodi qualunque ne sia la graduazione, vale fare un macello perché costerà uguale”).
Ma forse la perseveranza in questo mestiere, la testarda convinzione che il rigore critico possa bilanciare – se non oggi, domani – il furore ideologico è l’unico antidoto all’angosciante senso di impotenza che prende.
E proprio il mestiere di storico insegna che una forza di resistenza a questo antisemitismo rebound, ci sarebbe: e sta proprio nelle chiese cristiane, incubatrici e custodi dell’altro antisemitismo.
Non tutte: il mondo evangelicale che ha inventato il Christian Zionism è al contrario un sostenitore della peggiore politica israeliana: sarà favorevole all’annessione della Samaria; sarebbe felice se incidente o un missile qualsiasi (Houthi sarebbe perfetto) distruggesse le moschee, scatenando un bagno di sangue; sosterranno tutte le politiche che identificano materialisticamente la promessa della terra con la terra promessa.
Nelle chiese stabilite, e nel cattolicesimo romano in modo particolare, invece, ci potrebbe essere la coscienza e la credibilità necessaria per una resistenza. La chiesa del papa che telefonava a Gaza, del patriarca che s’era offerto ad Hamas in cambio degli ostaggi, potrebbe vigilare. Non per ispirazione divina, ma per la consapevolezza storica che l’antisemitismo si accende in un secondo e si spegne in un millennio, perché sa trovare ragioni teologiche con cui alimentarsi, in un roveto empio e incombusto che contamina la terra su cui brucia.
C’è nel lavoro critico la lucidità necessaria? C’è nelle chiese questa forza teologica?
Come diceva il peggior ambasciatore francese di tutti i tempi «l’avenir nous renseignerait».